«Un giorno sarà legato al mio nome il ricordo di qualcosa di enorme – una crisi quale non si era mai vista sulla terra, la più profonda collisione della coscienza, una decisione evocata contro tutto ciò che finora è stato creduto, preteso, consacrato. Io non sono un uomo, sono dinamite. […] Non voglio essere un santo, allora piuttosto un buffone. […] la verità parla in me, ma la mia verità è tremenda: perché fino a oggi si chiamava verità la menzogna»
F. Nietzsche, Ecce homo. Come si diventa ciò che si è, Torino, Casa Fratelli Bocca, 1922
Friedrich Nietzsche ha traghettato l’Occidente verso il suo tramonto, e ce lo ha descritto con immagini e metafore come mai nessuno aveva fatto prima. Nietzsche come Caronte. Il grande tramonto tratteggiato dal filosofo della morte di Dio e dell’eterno ritorno è un prisma, dove però gli indirizzi fondamentali per comprendere – almeno in parte – quell’autodefinirsi ‘dinamite’, sono due: quello della distruzione del testo – insieme alla scomparsa del suo autore – e quello della morte della nozione di verità. Non c’è più il testo, non c’è più l’autore, non c’è più la verità. In che senso non ci sono più? In che senso dobbiamo fare a meno dell’autore di un testo e della nozione di verità? Questo è un cammino che nel racconto nietzschiano è iniziato (almeno) con Umano troppo umano, testo che è un punto di svolta della sua produzione, ma negli ultimi scritti è un qualcosa che esplode in maniera straordinaria, decisiva, potente e allo stesso tempo ignorata e ignota. Il testo nasce senza ordine, apparentemente senza coesione interna, senza una struttura, riportando una divisione interna assolutamente fittizia, con titoli singolari e originali, ma con una straordinaria profondità d’ispirazione. Nietzsche ha avviato un processo di distruzione dell’autore, ha iniziato a dirci che le opere non hanno un autore, e dunque colui che ritiene di essere l’autore altro non è che uno scriba intento a trascrivere una situazione esplosiva e distruttiva.

Sulla base di questi due tramonti le modalità canoniche di approccio al pensiero di Nietzsche sembrano non funzionare più ed entrano in crisi. Il primo approccio è quello che ricerca in Nietzsche un pensiero lineare e strutturato, veritativo, sistematico nella sua a-sistematicità, un Nietzsche manualistico del quale è possibile decriptare in modo certo ogni passaggio, un approccio esegetico tipico degli storici della filosofia che ricerca la trasparenza, la verità oggettiva del testo. In questo atteggiamento che procede “senza sospetto” (curiosa contraddizione per chi era stato definito da Paul Ricoeur uno dei «filosofi del sospetto»[1]) manca l’attenzione sull’influenza che il proprio modo di leggere filologicamente il testo ha sull’interpretazione stessa del pensiero di qualunque autore, figuriamoci di quello nietzschiano. Si capisce quindi come quello dell’ultimo Nietzsche sia un pensiero che sconfessa la sua stessa origine, quella del giovane professore di filologia classica all’Università di Basilea.
Il secondo modo di interpretare Nietzsche, che diventa problematico nella lettura della sua ultima produzione, è il prospettivismo, che si riduce sempre a un mero relativismo conoscitivo, perché si tratta di un pensiero nel quale non è più individuabile un centro che possa definire una linea interpretativa. Si tratta di scritti a-centrici, vorticosi, ed è lo stesso Nietzsche a rivelarlo quando scrive: «da Copernico in poi l’uomo scivola dal centro verso una X»[2], dove ogni interpretazione è un’incognita possibile.
La terza lettura che non può più reggere, se si è compresa la portata del gesto finale nietzschiano, è quella della volontà di potenza interpretata come forma di irrazionalismo, come nichilismo debole avrebbe detto Gianni Vattimo, laddove invece Nietzsche stesso sostiene un nichilismo forte, che disintegra il senso comune occidentale della verità, ma di cui resta ancora oscuro il significato reale.
Queste tre modalità classiche di interpretare il pensiero nietzschiano – come si è detto – vacillano. In Al di là del bene e del male Nietzsche, combattendo gli uccellatori metafisici intenti ad esaltare la superiorità e specialità dell’essere umano, cerca di esortarci a una più profonda comprensione della natura umana, ma poi, quasi in un sussulto apparentemente contraddittorio, scrive: «perché però, in generale, conoscere?»[3]. Cioè, perché l’uomo deve per forza trovare una risposta definitiva all’esigenza di scoprire quale sia la vera natura dell’uomo? L’uomo si sarebbe quindi sempre filosoficamente chiesto, da Talete in avanti, che cosa fosse e quale fosse la verità, che cosa fosse l’essenza profonda di ogni realtà, dell’uomo, della natura, del trascendente e del linguaggio stesso, ma questi interrogativi – molto socratici – su che cosa si basano? Di nuovo: perché l’uomo ha sempre creduto che si possano formulare tali domande e che queste possano portare a risposte certe e definitive? E quindi verrebbe da chiedersi, con Nietzsche, perché mai l’umano dovrebbe essere naturalmente mosso da questa esigenza di verità, da questa volontà di conoscenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza?
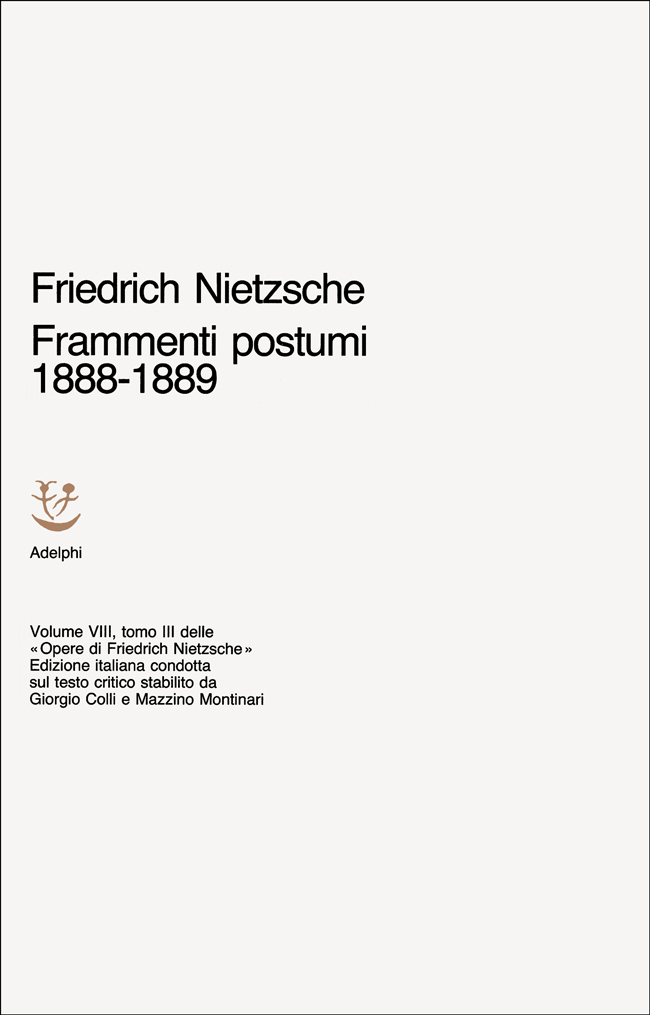
Nei Frammenti postumi, raccolti fra la primavera e l’autunno del 1888, Nietzsche – a un passo dalla follia – ci fornisce alcune indicazioni sul declino di quello che lui chiama nei suoi appunti il fideistico valore-verità[4], richiamandosi al tramonto di questo valore supremo, che è in definitiva il consumarsi di ogni forma di fede e «tramonto di tutti i tipi di dominanti»[5]. In questo ritroviamo un’associazione estremamente interessante, che deve farci riflettere: l’idea che vi sia un rapporto fra il declino del concetto di verità in quanto immutabile e il declino della possibilità di esercizio reale – “politico” verrebbe da dire – del dominio di qualcuno su qualcun altro. È una possibile e interessante (quanto nietzschianamente fallace) chiave di lettura. L’idea stessa del potere e l’esercizio di tale potenza si fondano sulla pretesa di essere i detentori di una verità monologica, che non ammette repliche e non ammette dialoghi, che non considera altro all’infuori di sé, che è per definizione totalizzante e di conseguenza totalitaria.
Ed ecco invece che Nietzsche viene a dirci che non c’è qualcosa che sia più vero di qualcos’altro, perché non c’è più qualcosa che possa avere la pretesa di essere la verità, che altro non è che quella potenza che ognuno di noi traveste di verità per darle valore. La verità è dunque una convinzione, un campo di prova per testare la forza della propria narcisistica volontà. Tutto è diventato segno, tutto è diventato interpretazione, o per dirla con le parole del titolo del quinto capitolo del Crepuscolo degli idoli: il ‘mondo vero’ finì per diventare favola, un’illusione. Tutto quanto accade e viene detto ha eguale valore, tutto è livellato, ogni conoscenza è una costruzione di finzioni e astrazioni utili, dove «i sensi e il linguaggio […] <sono> una mera semiotica e niente di reale»[6].
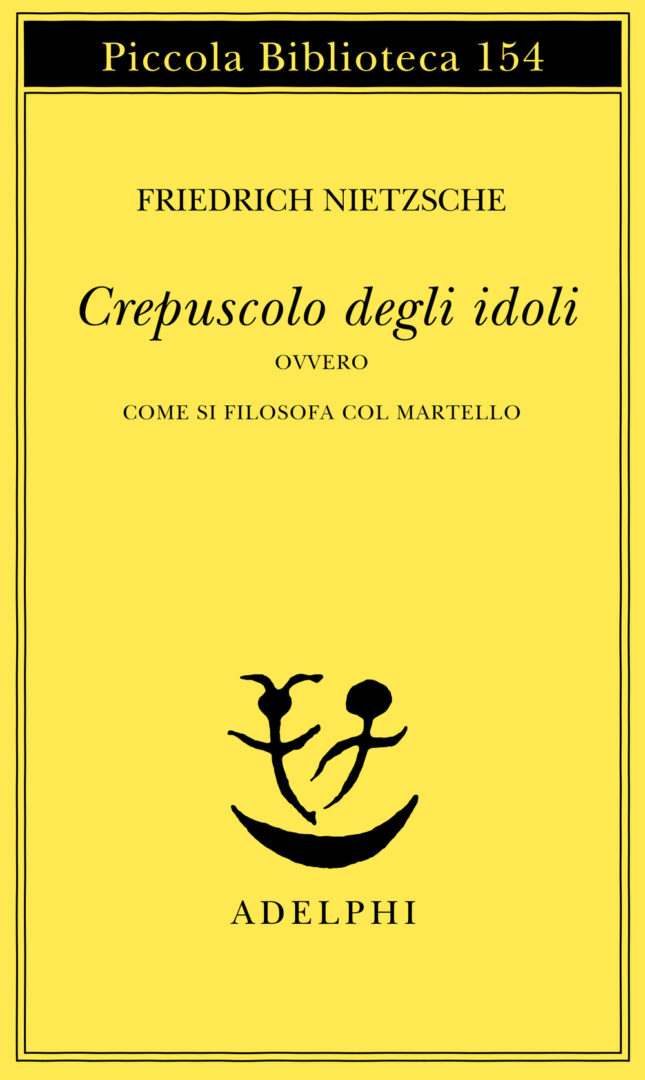
Proviamo a riportare la filosofia di Nietzsche all’oggi, alla nostra storia. L’Occidente si è da sempre concepito come il detentore esclusivo della verità, e in virtù di questa autoinvestitura ha creduto di dominare il mondo sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello politico, da quello culturale a quello militare. Questo spiega il motivo per cui esso abbia oggi molta difficoltà a confrontarsi e a tollerare il resto del mondo, a constatare l’esistenza di altre prospettive che non sono la propria. Per secoli l’Europa ha preteso di voler dominare esportando quelli che erano i suoi valori, dal Cristianesimo alle illuministiche liberal-democrazie, tutte manifestazioni di una stessa volontà di potenza, qui intesa come la volontà egemonica del dominante: la pretesa di essere i portatori della verità, del Bene supremo di platonica memoria, che di riflesso innesca un narcisismo intollerante. Si tratta di una constatazione che non avrebbe avuto bisogno di scomodare un’interpretazione nietzschiana, sarebbero bastate le ragioni del dialogo socratico, oppure il profondo legame che troviamo in Locke fra la critica alle idee innate e l’idea di tolleranza, laddove per il filosofo britannico il principio innato e veritativo proposto dal razionalismo cartesiano fungeva da piedistallo a qualsiasi forma di fanatismo (‘religioso’, pensava Locke, ma estendibile a qualunque altra ideologia). Tuttavia Nietzsche ci permette di andare oltre: il potere lo possiamo intendere come uno strumento che gli uomini hanno per mettere in atto le loro idee, i loro concetti, le loro verità, ma la soglia critica che porta verso la fine dell’idea di verità per come l’abbiamo sempre intesa mette in discussione anche l’idea stessa del potere come volontà di dominio.
La volontà di potenza è in realtà da intendere come un pathos, un sentimento, un’energia esistente all’interno di un vortice di altre energie che si esprimono senza dover necessariamente annullarsi le une con le altre, ma anzi, continuando a esistere proprio perché esse agiscono reciprocamente le une sulle altre – senza un centro e senza una periferia avrebbe detto Giordano Bruno. Stiamo parlando della (parziale) distruzione della dialettica autocoscienziale hegeliana, dove non ci sono più né un “servo” né un “signore”, ma dove comunque ciascuna potenza è perché è riconosciuta dalle altre e lo è in modo sempre diverso, in un caotico insieme di reciproche energie. Proviamo a fare lo stesso ragionamento sul terreno della scienza: una realtà fisica è tale perché esercita una forza, un quanto di potenza – dice Nietzsche –[7], su un’altra realtà fisica, dove l’una non può fare a meno dell’altra senza collassare; o ancora, possiamo dire che un’idea è tale perché inserita in rapporto con altre idee opposte, ma necessarie alla sua esistenza. È un vortice infinito che separa perché allo stesso tempo connette ogni coscienza, ogni realtà, ogni idea.
Ma come si fa a vivere così? Come si fa a non pensare che il nostro osservatorio sul mondo, che è la civiltà occidentale, nelle sue elaborazioni teoriche non sia approdata al massimo grado di progresso ideale? Come facciamo a pensare di dover coesistere con una pluralità di mondi che noi riteniamo hegelianamente a uno stadio dialettico precedente al nostro, e non solo diverso? Come possiamo coesistere con mondi dove ci sono capi liberi e sudditi più o meno consapevoli – da Oriente a Occidente –? Come si fa a coesistere con chi massacra altri esseri umani in nome di presunte appartenenze religiose, ideologiche, etniche o addirittura di genere? E allo stesso tempo come si fa a non cogliere i tradimenti dei grandi ideali di giustizia e di libertà che i falsi profeti dell’Occidente vanno predicando oggi, inquinando ogni possibilità di comprensione del reale in modo sofistico, retorico e volgarmente falso in nome dell’aumento indiscriminato della capacità economica di pochi a danno dei molti? Come può non percepire il mancare della terra sotto i piedi chi ha sempre avuto e continua ad avere la presunzione di essere dalla parte giusta della storia, e che ritiene che un giorno o l’altro tutti, dopo aver attraversato gli hegeliani travagli della negatività, possano approdare a una sintesi finale, quella ideale della democrazia, della giustizia sociale, della libertà dell’individuo che agisce sempre per il bene della collettività, per l’interesse generale?
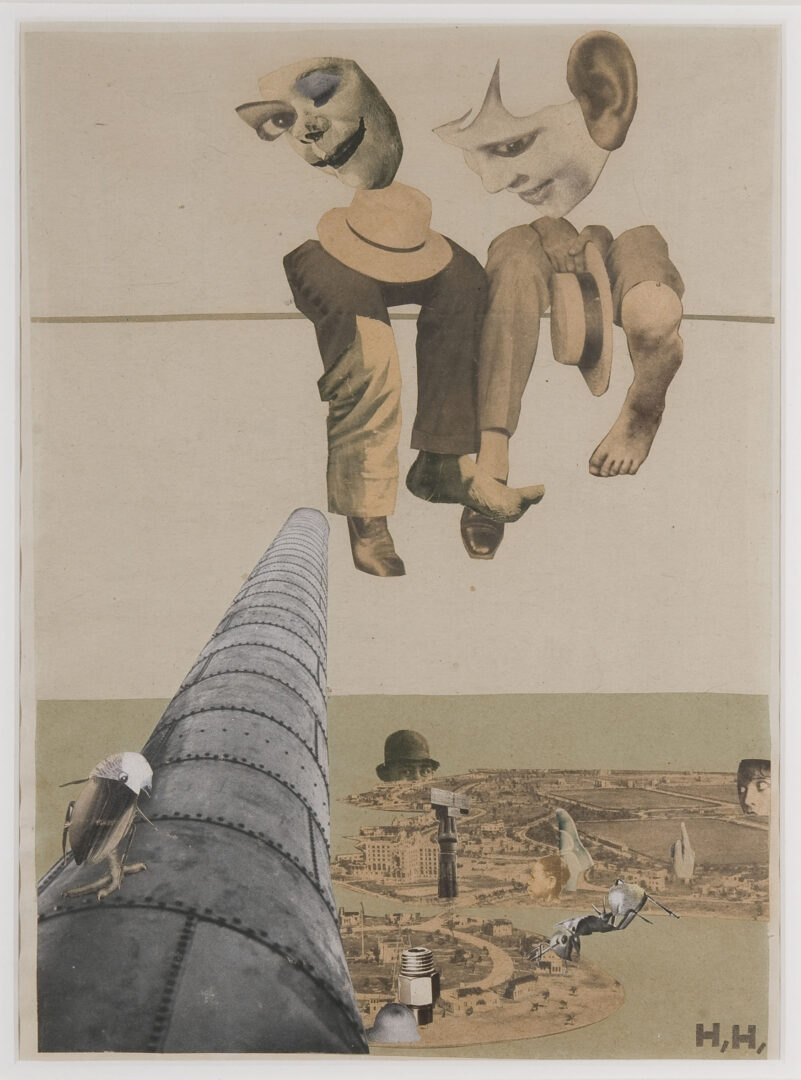
Abbiamo l’impressione che le certezze stiano vacillando, in realtà sono già cadute. Gli immutabili sono paradossalmente tramontati mentre noi continuiamo a vivere come se seguitassimo a essere sorretti dalla nostra volontà di pre-potenza e dalle nostre granitiche certezze.
La fine della pre-potenza prevaricatrice dell’Occidente ci lascia smarriti, ci lascia incapaci di scorgere degli orizzonti, perché l’unico orizzonte che credevamo possibile era proprio quello occidentale, ma la nostra presunta verità, cioè la nostra finzione, si è scoperta nuda e debole. I totalitarismi a sfondo religioso del passato, quelli tremendi del Novecento, il socialismo reale, le liberal-democrazie sono tutti prodotti dell’Occidente, e la storia vista dal nostro telescopio è sempre stata uno scontro tra prospettive interne all’Occidente. Oggi non è più così: il confronto è con altri mondi che chiedono di uscire dal confinamento per emergere, per coesistere, per esprimersi.
In fondo la volontà di potenza non è una dottrina, ma è un esercizio di vita, è una pretesa di potenza, è il tentativo di ogni realtà (e di ciascuno di noi) di poter stare nel mondo, di reggere all’urto delle altre volontà di potenza impedendo che il tutto collassi. Forse è proprio questo che Eraclito intendeva quando diceva che il pólemos (il conflitto) è padre di tutte le cose, di tutte il re. La volontà di potenza è un’illusione, una favola, è quella intollerabile consapevolezza che costringe l’uomo a esistere essendo consapevole che ciò che dice “non è vero”, ma è un falso, un qualcosa che ha una sua potenza non assoluta. E l’anno seguente, nel 1889, per Nietzsche questo urto, questa energia, si affievolirà sino a non reggere più: sarà l’implosione, sarà la follia. Per porgere lo sguardo verso il lascito testamentario di questo scriba del caos – felice espressione di Ferruccio Masini – che è Nietzsche, va ricordato che tutto ciò di cui si è riflettuto più sopra è falso, nel senso che non è la verità, ma una postura disponibile, fra le tante, verso un testo che non ha autore, e quindi non ha una (sola) volontà. Dobbiamo capire che Nietzsche intende le sue stesse parole come un «mondo accomodato e semplificato»[8], perché non dicono la verità, ma sono solo apparenze, sono «istinti pratici»[9]. Pierce diceva che in ogni giudizio si esprime la filosofia dell’universo, che in ogni fatto è già racchiusa la totalità delle sue interpretazioni, eppure noi siamo sempre così viziati e corrotti da questa idea della verità che ci rende potenti, da farcene profeti; in realtà ci troviamo all’interno di una trascrizione universale dell’esperienza che, in sé, è solo potenza (agita e subita): una semiotica universale fatta di astrazioni utili, dove le leggi della realtà – da quelle della fisica a quelle della politica – non sono che istinti pratici, che non esistono in quanto verità di fatto, ma in quanto strumenti che consentano una relazione fra le cose che ci spieghi ciò che è contingente, che ci spieghi in fondo la nostra vita.
Immagine di copertina: Jan Švankmajer, Dimension of dialogue, 1983
[1] Si veda P. Ricoeur, Dell’interpretazione. Saggio su Freud (1965).
[2] F. Nietzsche, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere, vol. VIII, tomo I, a cura di G. Colli e M. Montinari, trad. it. di Sossio Giametta, Adelphi, Milano, 1974, p. 114.
[3] F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, in Opere, vol. VI, p. 142.
[4] F. Nietzsche, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere, vol. VIII, tomo III, p. 4.
[5] Ibidem.
[6] Ivi, p. 48.
[7] «Un quanto di potenza è definito dall’effetto che esplica e a cui resiste, è essenzialmente una volontà di sopraffare e di difendersi dalla sopraffazione. Non autoconservazione: ogni atomo proietta la sua azione in tutto l’essere – lo si sopprime se si sopprime questa irradiazione di volontà di potenza. Perciò lo chiamo un quanto di “volontà di potenza”: in tal modo si esprime il carattere che non si può sopprimere nell’ordine meccanico stesso. [Non ci sono parti, non il tutto di queste parti; nel punto di ogni accadimento c’è una relazione tra potenze che vogliono sopraffare o non essere sopraffatte, punto che si espande in un infinito vortice di ripetizioni]», in F. Nietzsche, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere, vol. VIII, tomo III, p. 47.
[8] F. Nietzsche, Frammenti postumi 1885-1887, in Opere, vol. VIII, tomo III, p. 61.
[9] Ibidem.
