A pochi giorni dalla premiazione finale, prevista per sabato 10 ottobre, si conclude il viaggio di Limina alla scoperta dei libri finalisti della X edizione del Premio Lattes Grinzane, riconoscimento internazionale organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes che vede la partecipazione di autori italiani e stranieri ed è dedicato ai migliori libri di narrativa pubblicati nell’ultimo anno. Finalisti dell’edizione 2020 sono Giorgio Fontana con Prima di noi (Sellerio), Daniel Kehlmann con Il re, il cuoco e il buffone (traduzione di Monica Pesetti; Feltrinelli), Eshkol Nevo con L’ultima intervista (traduzione di Raffaella Scardi; Neri Pozza), Valeria Parrella con Almarina (Einaudi) ed Elif Shafak con I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo (traduzione di Daniele A. Gewurz e Isabella Zani; Rizzoli).
Il prossimo appuntamento sarà per aggiornarvi sullla premiazione finale di sabato 10 ottobre presso il Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba alle ore 16.30, in presenza fino a esaurimento posti e in diretta streaming.
Per la quinta e ultima tappa del nostro cammino valichiamo il confine continentale per volare in Turchia con Elif Shakaf e il suo romanzo I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo.
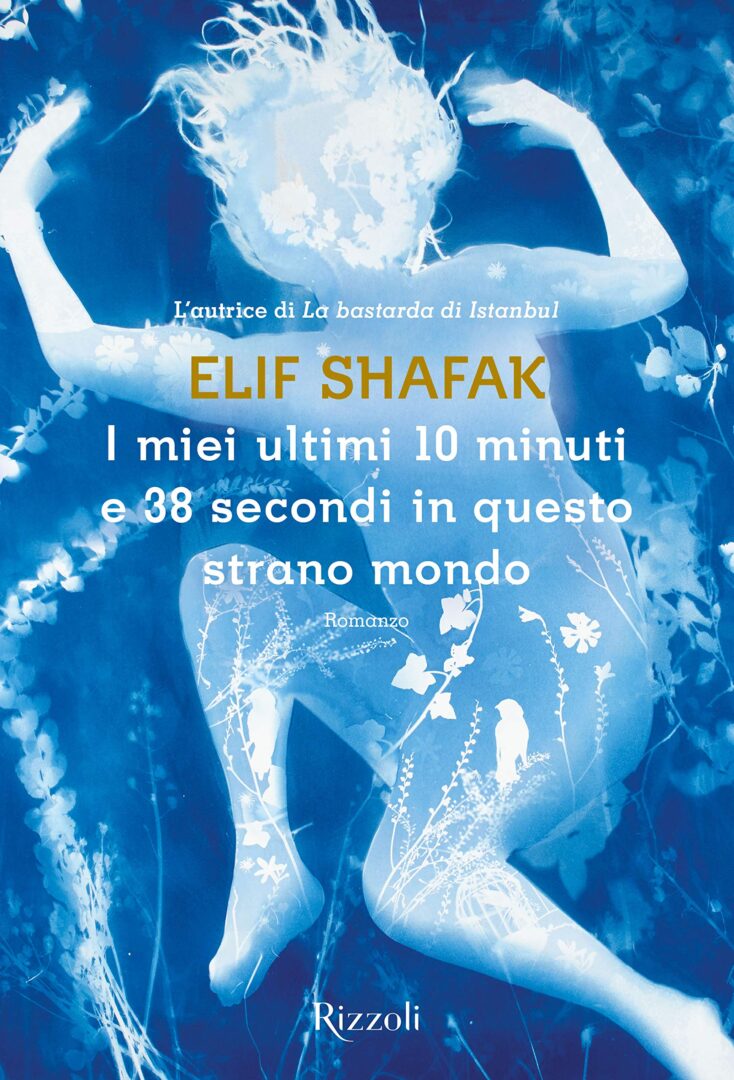
L’ultimo romanzo di Elif Shafak comincia a partire da “La fine”. Da un’apparenza di conclusione, la morte, che invece di essere ricapitolazione ci è presentata come resistenza vitale, un lento spegnimento che vale un’esistenza, quella di Leila Tequila, che da un cassonetto sul ciglio di una strada di Istanbul ricorda I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo.
Autrice di La bastarda di Istanbul (BUR Rizzoli), Tre figlie di Eva (Rizzoli), e molti altri romanzi tradotti in cinquanta lingue, in I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo (Rizzoli, traduzione di Daniele A. Gewurz e Isabella Zani), Shafak torna ad affrontare temi centrali della sua produzione e del suo impegno politico e sociale.
Il romanzo si articola su una struttura complessa, una prima parte che procede a ritroso, intrecciando diversi piani temporali tra presente, passato remoto e prossimo, cadenzati e introdotti dal susseguirsi di diverse epifanie gustative e olfattive – «Leila riandò col pensiero a due sapori contrastanti: il limone e lo zucchero» – seguita da una seconda parte in cui la protagonista perde pensiero e parola, e la narrazione, passata al tempo presente, il tempo dell’azione, si accosta a chi di Leila è la propagazione: i suoi cinque amici.
Leila Tequila è una prostituta di mezza età, è una bambina che sogna di vorticare il ventre nell’hulla hoop, è una ragazzina che si taglia l’interno delle cosce, è una donna che ha la forza di rimanere fedele a se stessa fino alla fine. Addentrandoci nelle pagine del romanzo si coglie con precisa evidenza il divario e la contraddizione presenti tra l’immagine esteriore, che si fa stereotipo e quindi pregiudizio, e l’identità stratificata e versatile dei personaggi. Tra questi, c’è Nalan, che prima di essere la Nostalgica, era Osman, «figlio minore di una famiglia di contadini dell’Anatolia»; oppure Jamila, prostituta somala che si rende diversa per ognuno, nata e cresciuta a Mogadiscio, in bilico e strattonata tra la religione materna cristiana e quella paterna musulmana. Narrando le storie passate e i tempi presenti di Leila Tequila e i suoi cinque amici, Elif Shafak compone un romanzo dal respiro multiculturale, che chiama al centro tematiche di grande importanza e complessità, quali l’origine, la memoria e le diversità.
La stessa autrice potrebbe essere una dei protagonisti del libro: nata in Francia, cresciuta in Turchia, trasferitasi poi in Spagna e negli Stati Uniti, oggi vive a Londra e il giorno di ritorno a una della sue patrie, forse la più affezionata, le è stato vietato. «Vengo da molte città e culture, pluraliste e diversificate, ma vengo anche dalle loro rovine e dalle macerie, dai ricordi e dalle dimenticanze, dalle storie e dai silenzi», così ad Elif Shafak piacerebbe rispondere alla semplice domanda «da dove vieni?», come confessa nel pamphlet Non abbiate paura, pubblicato da Rizzoli a settembre 2020 nella traduzione di Daniele A. Gewurz e Isabella Zani. E così l’equazione per cui origine determina identità è smentita puntualmente dalla storia di ogni personaggio di I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo, perché «l’appartenenza non è una condizione data una volta per tutte, un’identità statica tatuata sulla pelle», e l’origine, pur segnandoci, può appartenere a una memoria che ha ferito, in cui non si trova riconoscimento e si vuole dimenticare.
L’oggi del romanzo si svolge a Istanbul, su cui torneremo, città ricettacolo che ospita e si contamina della stratificazione dei suoi abitanti, mentre il passato più remoto, quello della memoria, conosce un paesaggio ogni volta diverso: la città turca Van, quella di Mardin al confine con la Siria, l’Anatolia, la Somalia, il Libano, territori tutti dislocati all’interno dell’Asia occidentale, eccezione fatta per la Somalia, che si accumuna però per le medesime tradizioni medio orientali. Sono questi i porti da cui salpano i cinque personaggi di I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo, animati dal sogno e dalla volontà di trovare una patria che li accolga, e con essi, la loro verità e la loro diversità. Con i loro desideri non coincidenti con le aspettative familiari e sociali, hanno forzato il tentativo disperato per cui «non si può cambiare la geografia, ma si può imbrogliare il destino».
Nel romanzo i percorsi di vita dei personaggi si intrecciano e con loro anche le consuetudini e le usanze, che dalla pagina – e da questa trasuda anche tutto il vivo interesse di Shafak verso le tradizioni e le storie di trasmissione orale – risultano a tal punto sconosciute, per non dire incomprensibili, al lettore occidentale da trasfigurare momenti di narrazione in realtà parallele e magiche in cui il simbolo abbandona l’astrattezza e incarnandosi si fa sostanza. Così, quando a Van iniziano le doglie della madre di Leila, Binnaz, intorno a lei si ritualizzano gesti scaramantici e apotropaici affinché il neonato sia in buona salute, e a tal fine vengono liberati tutti gli animali tenuti in gabbia; oppure l’idea che Humeyra ha del confine che separa la sua città Mardin alla Siria, come una «cosa viva e vitale, una creatura notturna che si spostava quando le persone, da entrambi i lati, dormivano della grossa; per poi risistemarsi, il mattino dopo, appena più a destra o a sinistra».
L’impressione di Humeyra introduce a un altro concetto principe dell’architettura del romanzo e dell’interesse narrativo di Shafak. Il confine è per definizione una linea retta, uno spartiacque tra un qua e un là, un prima o un dopo: è un limite che circoscrive e determina, è un sinonimo di margine. Lo sguardo della romanziera è rivolto proprio verso tale prospettiva e ne svela un istinto di «scavare nella “periferia” piuttosto che nel “centro” e di focalizzare l’attenzione su voci emarginate, trascurate, prive di diritti e censurate». Non a caso la soglia è un’immagine che attraversa, sia a livello concreto sia metaforico, l’intero romanzo. Sulla soglia Binnaz pone prima del parto una scopa per tenere lontano Sheitan; per Humeryra la soglia, come già anticipato, è fonte di timore ancestrale; sulla soglia tra la vita e la morte è costruito l’intero romanzo. Il confine allora assume diverse significati in base alla prospettiva di sguardo e la realtà agli occhi stratificati di Leila Tequila si rivela suscettibile a interpretazione molteplice. Cosa può dunque essere considerato obiettivo in Paesi diventati crocevia culturali in grado di ergersi sulla convivenza delle contraddizioni?
Una certezza di non risposta la troviamo nella prima parte del romanzo. Se, indugiando un attimo ancora tra le forme geometriche, si intende la figura del cerchio come opposta alla linea retta del margine e come simbolo di libertà – il hula hoop che da bambina Leila in gran segreto faceva girare intorno ai fianchi assaporando nuove emozioni e fantasticando altri mondi –, risulterà pressoché contradditorio scoprirlo poco dopo un manifesto pubblico di prigionia: «Come faceva la stessa figura che separava e intrappolava un essere umano, a diventare un simbolo di libertà suprema e pura beatitudine per un altro?», si chiede Leila quando incontra per caso uno yazidi intrappolato in un cerchio disegnato con il gesso sulla strada.
Il fuoco di contrasti è il cuore pulsante del romanzo e di un’altra sua grande protagonista – il femminile non è caso -, la città di Istanbul. Ricettacolo di culture diverse, utopia metropolitana e multiculturale, Istanbul per i personaggi di I miei ultimi 10 minuti e 38 secondi in questo strano mondo è ambita come Itaca, la patria tanto desiderata che promette dolcezze e riserva amarezze – «Istanbul non era una città di occasioni, ma di cicatrici». Ma, pur scheggiandosi l’utopia, Istanbul rimane lungo tutto il romanzo un centro di attrazione, l’unica possibilità di libertà, seppur quest’ultima costi enormi sacrifici.
A Istanbul o si sogna o si è infelici, ci rammenta Shafak, mentre i restanti abitanti cercano invano di catturarla, protesi a sentirsi parte di una città che sembra accogliere e insieme respingere, che in fondo non è altro che «un’illusione […] un gioco di prestigio finito male».
Artwork copertina a cura di Alessandra Corsi
