Scrivo queste righe mentre l’ultimo album dei National – I am easy to find – risuona per la terza volta oggi dalla minuscola cassa del mio cellulare. Lo so, non c’è niente di romantico in questa descrizione, e nessuno scoprirebbe mai la mia impostura se scrivessi che la voce baritonale di Matt Berninger affiora roca dalle casse anni ’70 dello stereo ereditato dai miei genitori. Ma questo non è un brano di fiction, e quando decidi di scrivere la verità ci terminerà dentro ogni cosa, il bello e lo splendido, il brutto e lo spiacevole. Lo stereo anni ’70 è a Bologna, io in questo momento non lo sono: il mio presente è una stanza con una riproduzione di Botero sulla parete lunga, un tavolo bianco adatto al consumo dei pasti più che al battere dei tasti, il cellulare che emette suoni e lo schermo mai pulito di un computer portatile fuori moda.

L’ultimo anno è stato florido per la musica che amo, regalandomi – oltre al suddetto I am easy to find – anche la nuova fatica dei Vampire Weekend, Father of the bride. Uscita, quest’ultima, attesa anni, per quanto risibile possa sembrare associare il concetto di uscita a un’azione come quella che compio da alcuni anni al lancio di un nuovo disco, ovvero clickare l’icona Spotify sul cellulare e far scorrere l’indice in corrispondenza della scritta download; ma sono figlio degli anni ’80, non è parte del mio lessico dire che un album è reso disponibile un dato giorno. Un album nel mio mondo personale esce, e trovo affettuoso che la mente si riempia di immagini fittizie come un camion che scarica vinili sui marciapiedi di Great Jones Street, i colletti bianchi che scavalcano plichi accatastati cercando di non rovesciarsi addosso il caffè della Brooklyn Roasting Company. È una visione purificatrice e consolatoria, come tutto ciò che associamo al tattile in un’epoca smaterializzantesi come la nostra. Uso un linguaggio antico, lo so, ed è normale anche questo: il gergo del mondo è governato da coloni di vent’anni, magra consolazione per la perdita di un potere economico chiuso a doppia mandata nelle sacche da squash dei maschi caucasici over 60, quelli con la scritta “I’m 1%, fuckers” sulle t-shirt sudate.

National e Vampire Weekend sono due tra le migliori band americane contemporanee, ma questo non è importante rispetto a ciò che sto per dirvi – ci sto arrivando, siate pazienti. La musica che queste due band realizzano, per quanto associabile al mito decadente dell’indie rock, è difficilmente intrecciabile, così elegante e da camera quella dei National, così hawaiana e danzante quella dei Vampire Weekend. Eppure un elemento (o più di uno, scoprirete perseverando nella lettura) accomuna il loro corso recente, ed è un elemento che non ha a che vedere con la qualità, bensì con la quantità. I am easy to find e Father of the bride sono entrambi album estremamente lunghi, ed entrambi composti da un numero ragguardevole di canzoni: diciotto per i Vampire Weekend, sedici per i National, per un’ora e più di musica a disco – altra parola bellissima, che spazza via i polverosi pensieri associati ai concetti di streaming e download.
Ora, non mi è dato conoscere il perché dietro la scelta di album così lunghi, soprattutto in questa nostra epoca che corre prepotente nell’opposta direzione, quella del singolo e del consumo facile, scorri avanti scorri avanti scorri avanti. Eppure non può essere casuale. Forse la soluzione dell’enigma risiede proprio nel suo opposto? Andare contro corrente per riaffermare la propria centralità nel mondo? Snobismo alla ricerca di una fruizione nostalgica e rivolta al passato, al fine di ingraziarsi noi che nascemmo con gli album e le date di uscita?
Difficile dirlo, ma ho diversi dubbi a riguardo, ed è questo il fulcro del testo che state leggendo. È il momento di ringraziarvi per la pazienza ed entrare finalmente nel vivo. Veniamo, la maggior parte di noi occidentali grassi e invecchianti, da un secolo, il Novecento, nel quale l’opera d’arte ha posseduto una forte componente dimensionale. L’icona pittorica, Guernica, non ha solo un contenuto rilevante e ricco di storia, ma occupa lo spazio fisico di una parete. Il romanzo più rappresentativo dello scorso secolo, Ulisse di James Joyce, reca con sé un’intrinseca difficoltà di comprensione, unita a una mole scoraggiante il novantanove per cento dei lettori. Difficile immaginare un libro più presente nelle case e meno letto. Nella cultura americana che monopolizzò il dopoguerra, ciò avvenne in modo ancora più deciso: il romanzo cult della covata postmoderna, L’arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon, deve la sua fama alle proprie dimensioni, oltre che alla difficoltà di toccarne il fondo; lo stesso vale per il libro indispensabile della mia generazione, quell’Infinite Jest di David Foster Wallace che nelle librerie post-postmoderne figura più da soprammobile che da oggetto di reale consumo. Philip Roth è ricordato più per Pastorale Americana che per Lamento di Portnoy, e lo stesso vale per Don DeLillo, il cui apice è considerato universalmente il romanzo-mondo Underworld. Gli esempi potrebbero tracimare e condurre il lettore al sonno.
Il grande romanzo americano, questa la definizione che accomuna i capolavori sopra citati. E benché grande corrisponda all’inglese great piuttosto che a big, è come se i due aggettivi finissero per compenetrarsi nell’italiano grande, mai così calzante nella sua splendida ambiguità. Pochissimi autori di racconti hanno ricevuto il Nobel per la Letteratura, e perfino il gigante della short story Raymond Carver dovette motivare più volte la scelta di trascurare il formato lungo, affermando stizzito che scrivere un bel racconto fosse molto più difficile che dare vita a un bel romanzo. Avete mai letto un’intervista nella quale un romanziere avvertisse il bisogno di scusarsi e motivare la carenza di racconti nel suo percorso autoriale?
L’apice di un artista novecentesco era direttamente proporzionale alle dimensioni della propria opera. Accadeva lo stesso nella musica, dove un album doppio (a partire dal capostipite Blonde on Blonde di Bob Dylan) diventava pietra di paragone per ogni futura pubblicazione. Le dimensioni contano. Soprattutto, creano attesa. È come se l’artista accendesse un faro su se stesso, chiedendo al mondo di illuminarlo e di riservargli importanza. Questo pretende la grandezza. O almeno la pretendeva, fino al flop del millennium bug.
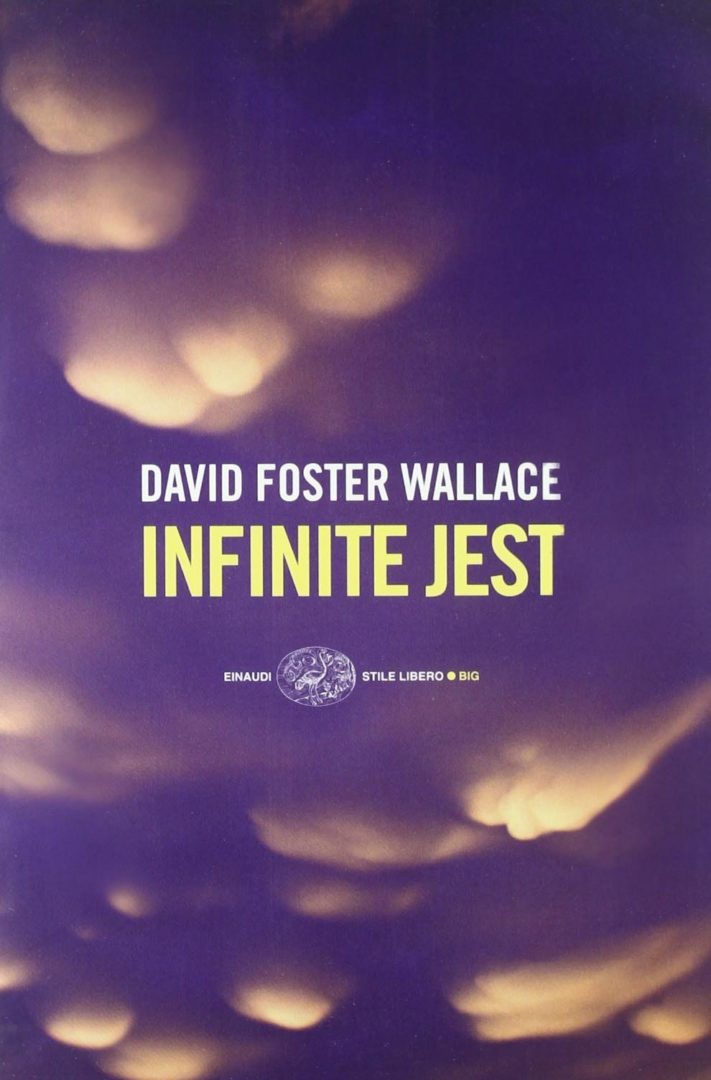
L’ultimo album dei National ha una curiosa origine, la quale si sposa particolarmente bene con il testo che state leggendo: il regista Mike Mills, fan dei National, contattò la band chiedendo di poter realizzare un videoclip per una nuova canzone; la band di risposta inviò dieci canzoni ancora in fase di registrazione, chiedendo al regista di pensare in grande; il regista decise allora di realizzare un film della durata di ventisei minuti con le musiche della band, rendendolo disponibile su Youtube in concomitanza dell’album.
Pensare in grande. È davvero questa la spiegazione?
È una soluzione che non mi convince fino in fondo, che si sposava forse con il secolo passato (secolo di grandi guerre, di grandi rivoluzioni, secolo breve eppure sovradimensionato), ma che non sembra vestire su misura questo ventunesimo con i suoi computer che diventano tascabili e l’arte che si liquefa e si fa individuale, schermo dopo schermo dopo schermo. È davvero la grandezza che cercano due band già popolari, le cui uscite avrebbero attirato comunque l’attenzione di critica e pubblico? Un album di quaranta minuti e dieci canzoni avrebbe fatto meno scalpore?
Forse. Ma non riesco a convincermi che la chiave sia esclusivamente questa.
Nel frattempo l’album dei National è terminato, e per sinapsi ho di nuovo cliccato play su quello dei Vampire Weekend. Le somiglianze, me ne rendo conto mentre gli ascolti si moltiplicano, non si limitano alla durata e al numero dei brani presenti; almeno altri due aspetti accomunano i due dischi (concedetemi il termine, almeno per il difficoltoso districarsi tra sinonimi): il primo è che entrambe le scalette sono inframezzate da passaggi riempitivi, intermezzi musicali per i National, tracce brevi e minimali per i Vampire Weekend; il secondo è che entrambi i leader, Matt Berninger ed Ezra Koenig, sciolgono qui il monopolio del canto – cosa mai avvenuta prima – e condividono i microfoni con altre voci, voci femminili che dialogano con loro alla ricerca di una maggiore ampiezza cromatica rispetto al passato. Strane coincidenze, soprattutto la seconda, che aprono il campo a ulteriori chiavi di lettura.

La grandezza si fa ampiezza. Ampiezza di sguardi, ampiezza di stili e tonalità. Guernica si dispiega come un film di Kubrick, un grattacielo si liquefa in villette a schiera di diversi colori.
Pensiamo all’immagine di un artista, un pittore che abbia appena concluso un quadro e desideri mostrarlo a una persona speciale: inviterà questa persona a casa, e l’invito conterrà le parole «ho concluso un nuovo quadro, vorrei mostrarlo a te». Il fulcro sarà l’opera d’arte, poco importa se l’appartamento non sarà perfettamente in ordine, se l’artista riceverà l’ospite in pigiama e con un paio di pantofole usurate. Il quadro, non l’ambiente, non le luci della città e il rumore di fondo, il quadro sarà l’unico fulcro dell’attenzione. Differente sarebbe se lo stesso pittore avesse appena traslocato, e decidesse di invitare la persona speciale a casa per mostrargli dove vive: l’attenzione dell’ospite si scinderebbe in centinaia di particolari più o meno consci, dalla scritta sullo zerbino al colore delle pareti, dall’ampiezza delle finestre alle piastrelle del bagno, dalle fotografie appese ai muri alle dimensioni della libreria, alla sua collocazione nello spazio. L’attenzione umana ha criteri di finitezza che, pur variando da individuo a individuo, non possono prescindere dalle mura della propria specie: più elementi stendiamo sul tavolo, meno intensa sarà l’attenzione che imprimeremo su ogni singola tessera del puzzle. E questo, mentre il vinile dei Vampire Weekend giunge al lato B (non c’è nessun vinile, non c’è nessun lato B, ma siamo verso la conclusione, rilassiamoci e deponiamo le armi dialettiche, io e te) può essere non solo fonte di dispersione, ma di salvezza.
È possibile, mi domando allora, che due band osannate dalla critica, con alle spalle album stra-osannati, decidano di ancorarsi alla grandezza per allentare le briglie dell’attenzione verso la forma canzone, come un padrone di casa consapevole di una perdita nel bagno decida di indugiare con il proprio ospite sulla vista delle colline dalla propria finestra, ignorando il rintocco goccia dopo goccia dopo goccia? Per dirla in modo brutale: allargare l’inquadratura, ampliare la tavolozza, può essere l’escamotage di un artista con meno cose da dire di un tempo per frantumare quell’attenzione altrimenti feroce e insopportabile, votata a un confronto con un passato spesso, inevitabilmente, perdente?
Da un saggio – da un microsaggio – aspettereste una chiusura definitiva, lo comprendo. Qualcosa come «l’uomo del ventesimo secolo cercava la grandezza, l’uomo del ventunesimo dietro la grandezza si nasconde». Ma c’è un motivo se ho scritto cinque romanzi e un solo saggio, di certezze ne ho poche e maledettamente rare. Insinuare un dubbio, una parvenza di risposta, è già molto per un testo come questo.
«Dopo anni è complicato essere il frontman», ha affermato in una recente intervista il cantante dei National, come scusandosi per aver aperto le porte del proprio disco a voci differenti. Come un romanziere che abbia preso una pausa dai romanzi, decidendo di scrivere racconti in assenza di materiale congruo e del coraggio necessario per gettarsi in un nuovo grande romanzo americano. Sono solo supposizioni, non ho abbastanza elementi per chiudere il cerchio da solo. E forse, più che chiuderlo, mi basta sapere di averne aperto uno, un cerchio più ampio nel quale proseguire, io e te lettore, questo viaggio affascinante nel concetto di grandezza.
Può bastarmi. Può bastare.
