«Io sono Lazzaro, vengo dal regno dei morti, torno per dirvi tutto, vi dirò tutto.»
T.S.Eliot, Canto d’amore di J.Alfred Prufrock
«Quando Lazzaro uscì dal sepolcro, dov’era stato tre giorni e tre notti nell’enimma sovrano della morte, e vivo ritornò alla propria dimora, nessuno colse in lui quella funesta estraneità che rese terrifico col tempo il suo nome stesso».
Convergenza imperdonabile tra due destini, la traduzione è, dovrebbe essere, un aderire al testo «perché esso muoia bene», come l’assassino aderisce anima e corpo alla sua vittima. Ceronetti parla di una distruzione inevitabile portata dall’incontro tra due intuizioni, nel passaggio da una poesia a un’altra, almeno «se non si è troppo stupidamente vissuto». Il sopravvissuto sconvolto della Grande Guerra, Clemente Rebora, traduce nel 1919 Lazzaro, dello scrittore russo Leonid Andreev. Piero Gobetti saluterà la sua traduzione come «un capolavoro, e noi in Italia non siamo abituati a lavori di tal serietà e finezza d’arte». Gobetti si sofferma sulla capacità di Rebora di mantenere il colore dell’originale nel senso di una straordinaria relazione di ‘simpatia’ in senso etimologico, attraverso ineguaglianze, sovrapposizioni, ricreazioni audaci, neologismi.
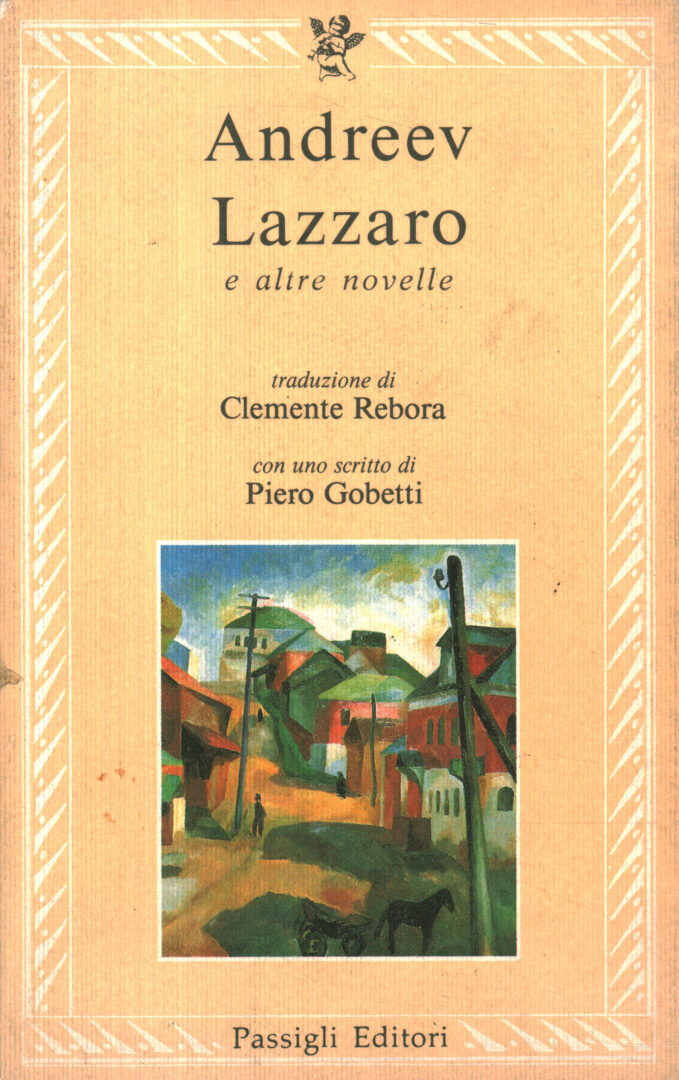
In Andreev (appartenente alla generazione successiva a Dostoevskij e Tolstoj e morto in quello stesso 1919) secondo Gobetti si nota il temperamento di un’entusiasta deluso: vede una società che si dibatte senza riuscire a comprenderla, trovando diffidenza e covando un inesausto bisogno di amore, «un amore desolato, che non ha fine, come il pianto e il dolore». Figura contraddittoria e ancora sfuggente, traccia un’estetica del lacero, del perdente, di un resto eccedente: avrà una breve folgorante passione per la Rivoluzione, per poi rientrare nella sua monade. Muore esule in Finlandia.
Il Lazzaro di Andreev/Rebora è «maschera di cadavere in pompose vesti nuziali, riscintillanti di aureo giallo e di sanguigna porpora, incombente e taciturno, già spaventevolmente spersonato e incomunicabile». Un’orchestrina suona mentre siede fra amici e parenti, nel banchetto che festeggia il suo ritorno. «Il tripudio gli fluttuava intorno a larghe ondate or soavi or clamorose; caldi sguardi d’amore approdavano al suo volto, che serbava il rigore del sepolcro; e l’ardente mano di un amico andava carezzando la sua, livida inerte». D’un tratto, uno «sconsiderato» è capace di nudare la verità «in tutto il suo raccapriccio»: «O Lazzaro, perché non racconteresti un po’ che successe laggiù?». Dilaga il silenzio: sconvolti, come se solo allora si rendessero conto del lividore estremo del volto, del ripugnante gonfiore, della mano lividopaonazza(1), attendono con ansia una risposta che non arriverà. Conosceranno invece l’annientatrice onnipotenza di una fissità senza rimedio: gli occhi di Lazzaro sono immobili, irraggiungibili.
«[…]Nessuno – né chi perduto s’infranse per sempre, né chi seppe trovare un’istintiva energia di resistenza nelle primigenie sorgenti della vita, misteriosa così come la morte – potè mai render ragione a sé stesso dell’essenza orrenda che nel profondo delle nere pupille sue sussisteva immota».
La seconda vita di Lazzaro sarà costellata da incontri, nel racconto di Andreev. Pieni di boria e curiosità, vengono a vederlo da paesi lontani: guerrieri, adolescenti in amore, uomini d’affari e sacerdoti, saggi che credono di avere risolto il segreto della vita e artisti alla ricerca di nuova ispirazione, alla fine persino l’imperatore Augusto. Tutti interrogano quello sguardo, nessuno ne torna come era venuto. Sono tutti contagiati dall’identica ombra, e in un aspetto nuovo appare ora il «vecchio conosciuto mondo»: «vestiva la terra d’un incommensurabile velame nero – e come padre l’abbracciava».
Che lo sguardo di Lazzaro sia uno sguardo che contempla ciò che lo acceca viene scritto anche in Lazare parmi nous, ‘Lazzaro fra noi’, saggio del 1950 del poeta francese Jean Cayrol – La’zar, forma abbreviata di Ele’azar, ‘Iddio ha soccorso’–. Senza dilungarsi sull’origine biblica del personaggio e sulle tre figure che ne sono la matrice, quelle dei vangeli di Marco, Luca e Giovanni, Cayrol attua una sorta di equazione tra la resurrezione di Lazzaro e il ritorno alla vita del deportato sopravvissuto ai campi di concentramento. La figura ben si attaglia alla sua personale esperienza (fu lui stesso prigioniero politico a Mauthausen, sotto il regime di ‘Nacht und Nebel’, con cui si designavano i prigionieri destinati a scomparire senza lasciare traccia), ma già nell’introduzione il lettore è messo sull’avviso: il libro non è scritto con spirito ‘da reduce’ perché «la battaglia, in cui siamo entrati per caso, ha avuto inizio già dalle origini del mondo e noi non ne siamo stati che effimeri testimoni».
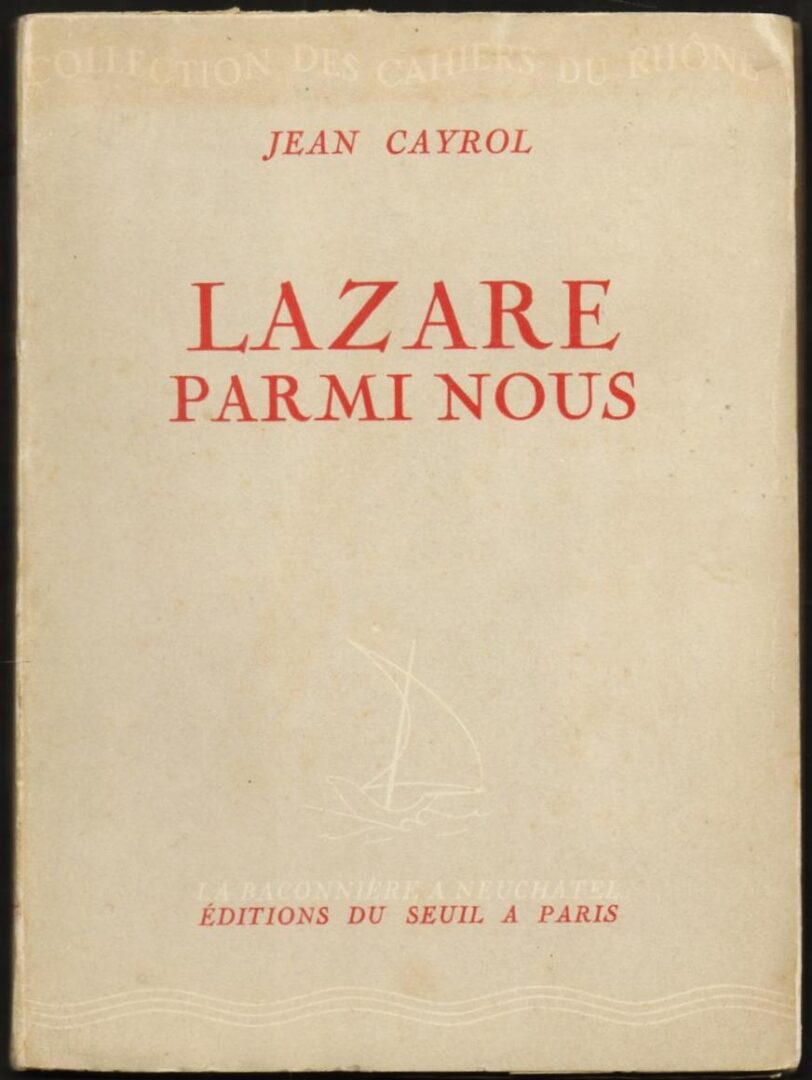
Qui Lazzaro avanza col volto deformato di una «vita allo stremo, in cui la figura umana non somiglia più a niente». «Chi – pensa il deportato – ha ritrovato il proprio volto dopo il ritorno, chi è potuto rientrare nei propri tratti, chi non ha subìto ‘operazioni alla faccia’? Conosceremo mai chi si trova al nostro fianco?’» Cayrol ritrae un «conquistatore spaurito, curvo sotto il peso delle sue stravaganti reliquie». Davanti a volti amati e conosciuti lo sguardo trema, diffida. E così il mondo non ha più un aspetto umano. «I passati sono sfocati. La deturpazione umana è stata portata al culmine, siamo al riconoscimento di cadaveri».
È l’homo mutans, l’emergenza dell’informe, la magia della spersonalizzazione che Roger Caillois chiamerà psicastenia leggendaria(2): in un’orgia di somiglianza, ogni volto approcciato dal sopravvissuto è l’umanità intera in una metamorfosi senza fine. Approcciando un volto, Lazzaro non approccia che la morte.
Scrive Starobinski in un saggio sulla poesia di Nerval:
«Ecco l’orbita vuota che regna ormai nella profondità dello spazio, annunciando che la legge materiale – la notte – è la sola padrona. In questa vanitas vanitatum suprema, il cranio non è più quello di un mortale anonimo contemplato dal penitente, esso occupa il posto stesso di Dio».
Lazzaro è testimone dell’indicibile – ha bevuto lo schwarzer milch, il nero latte della Todesfuge di Celan – e si scaglia contro la sua scandalosa museificazione, operata da storici e scrittori nell’immediato dopoguerra. Il risultato è stato il confezionamento di un campo di concentramento a misura d’immaginazione, spogliato della veste ardente da cui era avvolto, disinnescato, strappato alla sua stessa sostanza esasperata e folle, rendendo plausibile la sua comunicabilità. «Si può farlo visitare, come il Musée Grévin o le catacombe. Ha diritto a un custode, a una guida che conosca a memoria ciò che deve dire». Per Debord la coscienza, prigioniera di un ‘universo appiattito’, delimitato dallo «schermo dello spettacolo dietro il quale è stata deportata la sua vita», non conosce altro che interlocutori fittizi che la intrattengono unilateralmente sulla loro merce e sulla politica della loro merce.
Cayrol dedica uno spazio importante del saggio ai sogni lazzariani, intimo spazio inviolato di ogni detenuto, tratteggiando il subbuglio interiore che ha consentito all’uomo di resistere, «senza mezzi, senza riserve, conservando un’anima inafferrabile a dispetto delle mani enormi di una storia gigantesca e inumana». I sogni nati all’interno del campo sono vie di fuga dall’intollerabile, idealizzazioni di un passato quotidiano che sembra vecchio di millenni, allucinazioni da fame che assumono i colorati contorni di una «illustrazione popolare, era questo che perseguivamo con tutte le nostre deboli forze». Di più, viene creandosi una vita fittizia che è il duplicato dell’altra, opponendo un rifiuto al diurno negativo e conquistandosi la possibilità di un immaginario altrove: ogni istante aveva un’altra faccia. Cayrol racconta di come i kapò ebbero difficoltà a farsi ascoltare dai concentrazionari impiegati nella piccola fabbrica del campo, quando una mattina credettero profilarsi davanti ai loro occhi stupiti l’oro e il bianco della catena delle montagne austriache. Uno stato di fluttuazione, di vagabondaggio senza radici in cui i prigionieri potevano arrivare a sentirsi «non importa dove fuori dal mondo»(3). Così rievocare ricette di cucina permetteva di mangiare la minestra più ripugnante e cambiare il sapore del pane più ammuffito. Così l’improvvisa apparizione della madre che da una finestra tende verso di lui le mani, «due mani blu», diventa per Cayrol foriera della propria salvezza.
Lo psicanalista Roheim descrive ne Le porte del sogno (1953) l’elementare, originaria energia di vita proveniente dall’attività onirica, la sua potenza. Questa forza non resta prigioniera di una matrice, nel circuito narcisistico del corpo, ma si definirebbe come energia cumulativa, che irradia ogni nostra attività della veglia: il sentire, il percepire, il pensare. Roland Barthes(4), ha sottolineato «la straziante bellezza, il lusso sensoriale così puro» delle immagini notturne che il deportato dispiega come ultima resistenza, caratterizzate da sconvolgenti cromie: un prigioniero sogna in modo ricorrente che tutte le porte del campo siano di un verde ‘benefico’; un altro, un sacerdote, sogna di trovarsi ai piedi di Gesù inchiodato sulla croce: improvvisamente il petto di Cristo si squarcia, fa sgorgare su di lui il Suo Sangue: in esso è visto un segno di salvezza che prefigura la coperta rossa che lo avvolgerà una volta salvato. Il sogno di salvezza diventa, citando Roger Dadoun, «insurrezione che a ogni alba pianta nel cuore del mondo il desiderio rigenerato».
Marina Galletti mette in risalto la nascita di un vero e proprio «sacro concentrazionario» all’interno di una scenografia irreale da noviziato infernale, in cui a punizioni sanguinarie risponde «l’ebbrezza estatica di un universo proibito e sovrannaturale» unica via per tornare a quella che Georges Bataille chiama «la vecchia casa umana»(5), il mondo sovrano dell’essere.
I sogni dei sopravvissuti invece sono le stigmate, il perdurare del terrore, le cicatrici che segnano ‘il testimone di quell’orgia di sangue’ per tutta la vita. Un ex deportato sogna il suo corpo ricoperto da pidocchi giallo oro; una ex deportata sogna la metamorfosi del coniuge in membro della Gestapo. Soprattutto, ricorrono le reiterate messe in scena della situazione vittima-carnefice in cui l’assassino pazientemente si mette a sfigurare l’ucciso, modificandone i tratti fino a renderli uguali ai propri. Altre volte l’assassino rivela sotto una maschera il volto della vittima. Lazzaro si ritrova revenant ectoplasmatico proveniente dall’Ade, come Cayrol nel ‘46, nell’impasse tra il desiderio di testimoniare di un «evento irrecuperabile» e la ricerca di un linguaggio capace di riappropriarsi di quella ‘terra materna’ che era venuta a mancare da sotto i piedi. Primo Levi scrive: «Il linguaggio di tutti i giorni è adatto a descrivere le cose di tutti i giorni, ma qui è un altro mondo, qui ci vorrebbe un linguaggio ‘dell’altro mondo’, un linguaggio nato qui».


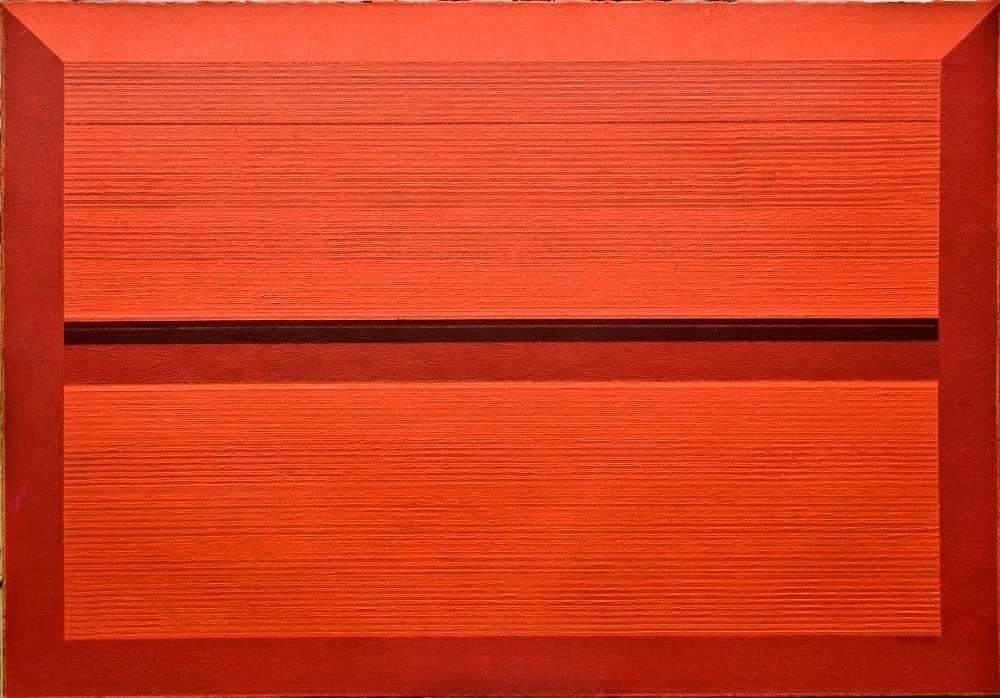
Cayrol definisce ‘artefici della lacrima pubblica‘ coloro che, come Erich Maria Remarque e Robert Merle, edulcorano «ciò che altro non era se non un mostro impossibile da descrivere e da comprendere», a ricoprire di una patina indolore «una realtà che sfiorava il delirio, che puzzava, gridava». Il dibattito sull’irrappresentabile risale almeno al monumentale documentario Shoah (1985) di Claude Lanzmann: il regista sceglie deliberatamente di non mostrare, durante le nove ore e mezzo di durata, alcuna immagine dei campi di sterminio, perché non si ha il diritto nemmeno di immaginare. Ed è così che oggi un regista come Jonathan Glazer nel recente La zona d’interesse decide di non mostrare le vittime, per riflettere sulla vita piccolo-borghese dei carnefici. Per Lanzmann: «Ci sono momenti in cui capire è pura follia».
Per il filosofo Georges Didi-Huberman immaginare l’inimmaginabile, che per i suoi stessi artefici doveva rimanere segreto, diventa invece un dovere etico: «L’immagine non è né tutto né niente». Lazzaro ha vissuto in un mondo che non esisteva da nessuna parte, le sue domande, come quelle di Cayrol, tradiscono l’impossibilità di comunicare, («Come spiegarvi, come dirvi, come farmi capire?») e di ritrovare Dio («Cos’è la verità? La vostra verità? Deve risultare sufficientemente esile per essere difesa solo da una sorta di prete di una religione di cui non comprendiamo più la dismisura»). Cosa ne sia dei ‘testimoni di quell’orgia di sangue’, quale sia il loro comportamento nel mondo quotidiano, ordinario, che per anni hanno vissuto come allucinazione, è la questione finale di Cayrol, che mette in guardia dalla mutazione della comunità umana in «massa anonima e cieca»; una società, nelle parole di Antonin Artaud, «assolta, consacrata, santificata e invasata» che dimentica di vivere, respirare a pieno la vita e le sue forze originarie, preferendo a questo la normale esistenza. Questo «cuore paralizzato e sensibile», queste orbite vuote, potrebbero essere le nostre, nel giorno inoffensivo «in cui riterremo inqualificabile la nostra speranza».
Nerval fa dire a Cristo sul Monte degli Ulivi(6):
«L’occhio di Dio cercando, ho visto solo un’orbita / vuota, nera e infinita, dove notte dimora / e s’irradia sul mondo ed è ognora più fitta».
Questo sguardo, tuttavia, questo nero, non è la parola finale: nella penultima strofa della poesia conclusiva dei Fiori del Male, Il viaggio, è la Morte ad essere apostrofata come ultima confidente, la sola complice, e una figura chiara spicca sull’immenso sfondo scuro. Una sorgente radiosa rimane desta, nell’imminenza del naufragio: è il ‘cuore’ di coloro che, esperendo il proprio male fino in fondo, si precipitano verso l’ignoto.
«[…]Son neri come inchiostro terra e mare, / ma i nostri cuori, vedi, sono colmi di luce»
Note
- Una delle invenzioni di traduzione di Clemente Rebora.
- Una «spersonalizzazione mediante assimilazione allo spazio», in R. Caillois, Il mito e l’uomo, Bollati Boringhieri, 1998.
- C. Baudelaire, Lo Spleen di Parigi, Mondadori, Milano, 2018.
- Si veda Il brusio della lingua, Einaudi, Torino, 1988.
- Si veda L’apprendista stregone, in D.Hollier (a cura di) Il Collegio di Sociologia, Bollati Boringhieri, 1991.
- Les Chimères, 1854.
In copertina:
Caravaggio, Resurrezione di Lazzaro, Olio su tela, 1609.
