Questo lavoro è stato improntato sull’analisi di un fenomeno tanto controverso quanto affascinante, quale è l’antropofagia, inteso come l’atto con il quale si assumono parti di un altro essere umano.
Si è trattato di un “viaggio” nei meandri della criminologia, della sociologia, dell’antropologia e soprattutto della psicoanalisi, tutte discipline legate non da un filo sottilissimo, ma da innumerevoli cavi di connessione.
Trattare ciò che è un tabù significa toccare la sensibilità collettiva, la quale preferisce molto spesso voltarsi dall’altra parte, indossare una maschera di ipocrisia piuttosto che andare al di là di ogni apparenza: per dirla in termini śivaisti, è necessario squarciare il velo di Māyā che avvolge e ottunde la realtà, per provare a cogliere aspetti nuovi, che in realtà sono esistenti e presenti da sempre.
Così, quanto scritto da Patrick Süskind, in una delle pagine finali del suo romanzo, Il profumo, consente di riflettere su quanto è stato detto, poiché coglie qualcosa che non è semplice da ammettere: la presenza di istinti, seppur vaghi e per certi versi inibiti, distruttivi.
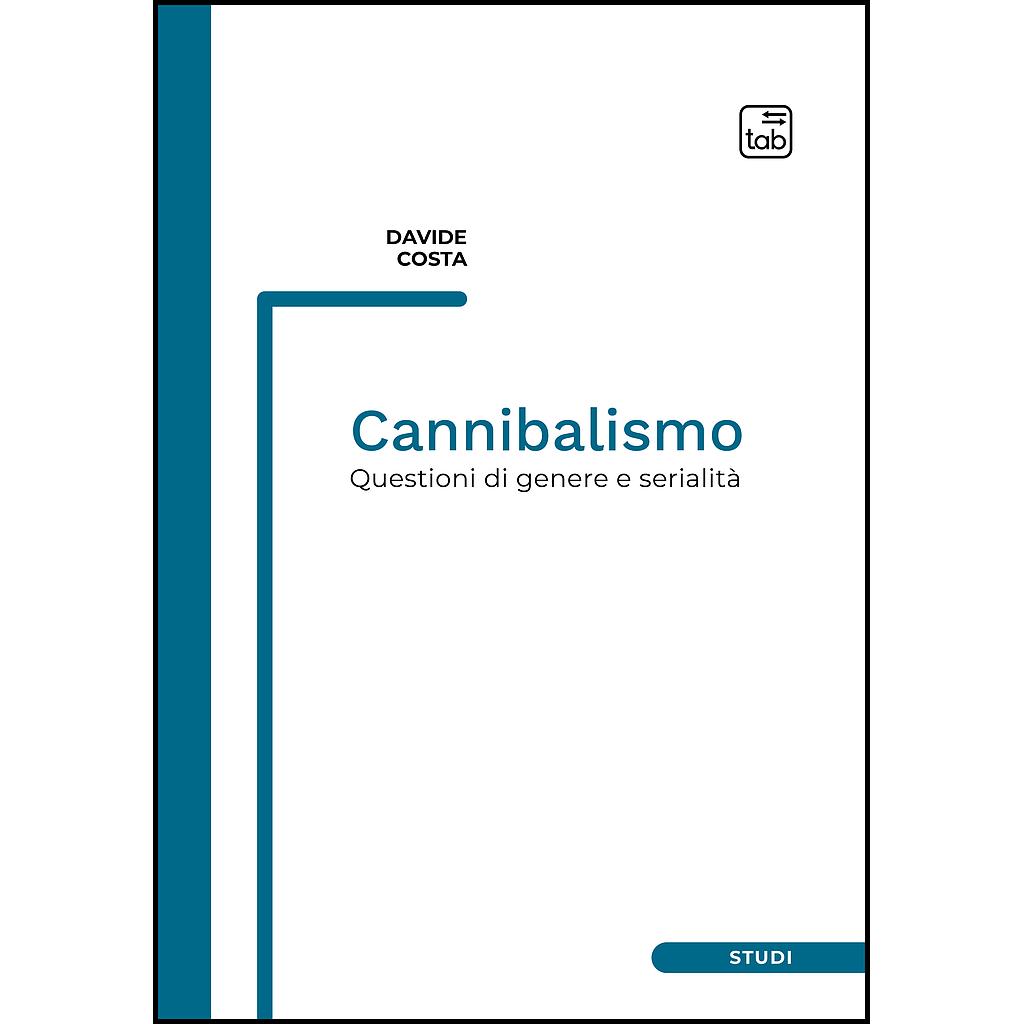
«Ognuno di loro, uomo o donna, aveva già commesso una volta un delitto o qualche altro crimine abietto. Ma divorare un uomo intero? Mai e poi mai avrebbero pensato di poter compiere un gesto tanto orribile. E tuttavia si meravigliavano di come fosse stato facile per loro, e di non avvertire neppure un’ombra di rimorso, pur con tutto l’imbarazzo. Al contrario! Nonostante lo stomaco fosse pesante, il cuore era straordinariamente leggero. Nelle loro anime tenebrose si agitava d’un tratto un’ombra di gaiezza. E sui loro volti aleggiava un tenero, timido barlume di felicità. Per questo forse avevano timore di alzare lo sguardo e di guardarsi negli occhi. Quando poi trovarono il coraggio di farlo, dapprima con circospezione e in seguito senza più riserve, dovettero sorridere. Erano straordinariamente fieri. Per la prima volta avevano compiuto un gesto d’amore[2].»
Questo è un passaggio evocativo, che stimola a rammentare come dietro ad un atto cannibale si celi «un essere desiderante simile a quello che alberga in noi. È il desiderio il denominatore che ci accomuna ai serial killer: l’uomo è un essere desiderante […], il resto è tutta una questione di gradazione, o anche di situazioni che allentano dei freni, rompono degli argini e fanno passare dal pensiero all’atto»[3]; si tratta di una considerazione simile a quella che si cela dietro il titolo di un’opera di un noto psichiatra forense, Robert Simon, I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno. In altri termini, si sta parlando della celebre dicotomia tra l’essere e l’apparire; quella naturale tensione tra il sé interiore e il sé esteriore.
Ma chi è un mostro? Un cattivo? Come ricorda Freud «È raro che un uomo sia totalmente buono o cattivo; perlopiù è buono sotto certi riguardi e cattivo sotto altri, o buono in date circostanze e decisamente cattivo in altre»[4].
L’etichetta di mostro, e in generale il ricorrere ai tabù, ha in sé un tentativo di placare il timore. Perché avviene ciò? Per la necessaria sopravvivenza, che spinge, mediante la cultura, a creare strumenti atti a semplificare e rendere più accessibili segmenti di realtà, che in altri modi sarebbero inaccessibili ed incomprensibili. Ecco perché «se invece si studiassero a fondo le vicende ed il background di tutti i soggetti dei cui abbiamo parlato […], ritroveremmo in loro quelle che sono anche le nostre necessità di contatto, attenzione, amore e controllo; potremmo quasi specchiarci nelle loro storie: come in un noto aforisma di Nietzsche, se scrutassimo nell’abisso, l’abisso scruterebbe dentro di noi»[5].
Certo, nel caso dei serial killer è innegabile che siano soggetti impregnati di una grave forma di ostilità distruttiva, che in termini sociologici si potrebbe definire come la manifestazione più evidente della natura conflittuale dell’uomo stesso in primis con sé stesso e poi, per trasposizione, verso l’altro. Un’ostilità che in parte sottende una necessaria ritualità negli atti, dal momento che solo ciò che si ripete può garantire una traccia, un ricordo, il tutto all’insegna della linearità. Kundera a riguardo sostiene che «Il tempo umano non ruota in un cerchio ma avanza veloce in linea retta. È per questo che l’uomo non può essere felice, perché felicità è desiderio di ripetizione»[6]; forse tale ritualità conferisce, a questi soggetti, una pseudo-felicità, una tonalità emozionale di cui hanno avuto poca esperienza.
In individui di questo tipo, così, amore e odio, vita e morte, creazione e distruzione, insomma tutte le dicotomie esistenziali si mescolano, si intrecciano, così come è sempre stato nelle culture più tradizionali, in cui non vi è separazione netta, non vi è polarizzazione, bensì coesistenza. Ecco perché in alcuni casi, come quelli discussi, la compulsione omicida si spinge fino al cannibalismo, che a sua volta è la manifestazione di forme di un amore e odio di tipo atavico e tribale.
Non è questa la sede per muovere giudizi, di natura giuridica, o di valore, perché nel primo caso sarebbe necessario ricorrere alle scienze giuridiche, e un locus ad hoc, quale un’aula di tribunale, ed eccetto gli Aghori, tutti soggetti di cui si è parlato sono stati giudicati e condannati; né si può ricorrere ai giudizi di valore, che andrebbero ad inficiare e a rendere sterili i tentativi di tutte le scienze dell’uomo, dalla sociologia alla criminologia, di essere sì guidate dalla prospettiva di colui che intende osservare un fenomeno, ma senza che il senso comune, e in ultima battuta, i propri pre-giudizi, entrino a far parte di considerazioni e valutazioni scientifiche.
Il che significa, in altri termini, prendere consapevolezza della relatività dell’agire umano, della nozione stessa di devianza e di deviante, perché al di là di ogni forma di ripugnanza e non accettazione di e per un atto di questo tipo, l’antropofagia è nell’immaginario collettivo ed individuale sin dalla comparsa stessa dell’uomo. Montaigne sosteneva che «ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi; sembra infatti che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle opinioni e degli usi del paese in cui siamo. Ivi è sempre la perfetta religione, il perfetto governo, l’uso perfetto e compiuto di ogni cosa»[7].
Se i riferimenti antecedenti non dovessero essere sufficienti, si pensi[8]:
- al mito di Dioniso e il suo essere oggetto di cannibalismo da parte dei Titani e di Zeus stesso, suo padre, che si ciba del suo cuore, per poi ridargli nuova vita;
- al mito di Orfeo, che nel tentativo di recuperare Euridice dall’Ade viene sbranato dalle Menadi;
- a Crono, come è stato già accennato, che divorò i suoi figli;
- alla Divina Commedia, dove Dante parla del conte Ugolino;
- al celebre personaggio Hannibal Lecter.
E ancora è bene rammentare come l’antropofagia non è solo presente nell’immaginario “adulto” ma anche in quello “infantile”. Si pensi ad alcune fiabe come Hänsel e Gretel, Barbablù, Il pifferaio di Hamelin, Pollicino, ecc.
La stessa cultura popolare, inoltre, è ricca di personaggi cannibali: il licantropo, lo zombie, il vampiro, ecc. Sono tutte prove evidenti, che si potrebbero definire “fossili” culturali, da cui è possibile cogliere un legame peculiare tra società primordiali, identità collettiva, istinti atavici e sopravvivenza, che come già detto potrebbe, tale correlazione, consentire di muovere l’ipotesi, come già riportato in precedenza, dell’esistenza un istinto atavico di tipo socio-psico-culturale e non biologico, come sostenuto da Lombroso.
Probabilmente la strada intrapresa, ossia quella del parallelismo tra serialità e śivaismo, risulterà eccessiva o azzardata, ma è solo un modo diverso per osservare il medesimo fenomeno. A riguardo, durante la prima lezione di metodologia delle scienze sociali, venne affermato che «la realtà mostra tante facce differenti, quanti sono gli osservatori della medesima realtà».
Un ulteriore elemento di riflessione è stato intrecciato con l’antropofagia, ovvero quello delle questioni di genere. Nella società liquida in cui ruoli, istituzioni, e ogni altro prodotto sociale appaiono sempre meno stabili, le distinzioni e le categorizzazioni di genere sembrerebbero affievolirsi, per dare spazio a nuove forme di contaminazione tra generi. Eppure sotto il profilo criminologico è stato possibile osservare come vi siano delle sostanziali differenze tra uomo e donna, ed anche tra eterosessualità e omosessualità. Differenze, certo, non categorizzazioni o classificazioni, perché sia chiaro non vi è un copione di genere giusto o sbagliato, ma solo ed unicamente l’umano e la sua incessante produzione di forme sociali, ossia costellazioni di elementi culturali entro cui la vita di ogni individuo si “rapprende”.
Ma ritornando al tema principale:
«l’idea dell’antropofagia continua (e continuerà) a non essere accettabile. Di fronte al cannibalismo […] rimuoviamo prontamente qualsiasi associazione tra pasto e amore, tendenza candidamente dimostrata dalle parole del giudice di primo grado – per il processo di Armin Meiwes: “Con questo processo abbiamo aperto una porta su un mondo nuovo. Inutile negare che adesso vada immediatamente richiusa”.[9]»
Questa esigenza di chiudere la porta è riconducibile al fatto che «L’ostacolo più grande allo sviluppo della propria esistenza […] nella cultura occidentale […] deriva […] dalla superbia spirituale dell’uomo»[10] che lo porta a negare parte della sua natura istintuale e distruttiva.
Invece, secondo la prospettiva assunta in questo lavoro si vuole sostenere che sia necessario non solo mantenere aperta la porta su fenomeni di questo tipo assieme alla problematicità che sottendono, ma che sia fondamentale varcarla più frequentemente, perché come sostiene Popper «la conoscenza non comincia con percezioni o osservazioni o con la raccolta di dati o di fatti, ma comincia con problemi. Non c’è sapere senza problemi-ma neppure problema senza sapere»[11]. Il che dovrebbe spingere ad andare ben oltre il pregiudizio che si cela dietro l’antropofagia, anche perché la conoscenza «comincia con la tensione tra sapere e ignoranza: non c’è problema senza sapere – non c’è problema senza ignoranza. Poiché ogni problema nasce […], dalla scoperta di un’apparente contraddizione fra quello che riteniamo nostro sapere e quelli che riteniamo fatti»[12].
Estratto da Cannibalismo di Davide Costa (tab edizioni)
In copertina Respira, ph. di Anna Rotundo
[1] C. Cipolla, Il ciclo metodologico della ricerca sociale, cit., p. 56.
[2] P. Süskind, Il profumo, Longanesi, Milano 1996, p. 261.
[3] E. Belfatto, Il cannibale di Rotenburg, cit., p. 52.
[4] S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, Bollati Boringhieri, Torino 1976, p. 40.
[5] E. Belfatto, Il cannibale di Rotenburg, cit., p. 52.
[6] M. Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere, Adelphi, Milano 2012, p. 312.
[7] M. De Montaigne, Saggi, Adelphi, Milano 2007, p. 272.
[8] Si pensi, in merito alla letteratura più recente, al personaggio cannibale femminile di C. Deangelis, Bones and All (2015), Maren, di cui è stato anche girato l’adattamento cinematografico da Luca Guadagnino.
[9] E. Belfatto, Il cannibale di Rotenburg, cit., p. 53.
[10] A. Tartabini, Cannibalismo e antropofagia, cit., p. 123.
[11] T.W. Adorno, et al., Dialettica e positivismo in sociologia, Giulio Einaudi, Torino 1969, p. 106.
[12] Ibidem.
