In questi giorni più che mai ho la sensazione che il tema “comunicazione” sia un tema rilevante. Con buona pace di chi pensava si trattasse di un problema di packaging del pensiero, e anche di chi in modo certo più accorto pensava fosse solo questione di forma e non di contenuto, mi pare che oggi – in tempi di infodemia – la questione si riveli urgente. Certamente il problema sanitario e quello economico ci stanno più a cuore, ma cosa sarebbero l’uno e l’altro al di fuori dei discorsi dei virologi che hanno invaso i nostri media, dei DPCM che abbiamo seguito su FB, dei webinar che ci hanno fatto compagnia, delle anodine conferenze stampa con cui di sera in sera ci siamo abituati ai morti?
Non è possibile qui ripercorrere tutto questo (alcune riflessioni interessanti, di impostazione semiotica, le trovate su http://www.ec-aiss.it, come Diario semiotico del Coronavirus). Mi limito solo a evidenziare qualche aspetto, che spero possa esserci utile per orientarci un po’ di più in questa ridda di voci sovrapposte.
Anzitutto la parola “infodemia”: cosa significa? Significa fake news? Significa post-verità? É un neologismo inutile? Io credo che ci sia bisogno di igiene anche nelle parole, pulizia; e per questo mi piace distinguerle.
Se devo pensare queste tre parole spazialmente, le visualizzo a cerchi concentrici. La post-verità è il fenomeno più ampio e ha a che fare con un regime in senso foucaultiano: un complesso sistema di pratiche, dispositivi politici, strutture comunicative che definiscono i valori di verità che articolano la nostra vita (presupponendo che la Verità non è una sola, maiuscola, ma può assumere tante forme, in funzione dei paradigmi che la definiscono). La post-verità non ha quindi a che fare solo con la comunicazione, ma con le forme della nostra prassi (politica, sociale, mediatica, comunicativa). É un problema epistemologico e politico, non comunicativo.
Il fenomeno fake news, da parte sua, è solo un’isola in questo mare: può contribuire a rafforzare il regime di post-verità ma non ne è sinonimo e neanche parte essenziale. E penso che questa consapevolezza dovrebbe essere cruciale, specie quando di questa parola abusiamo: anzitutto perché il problema del falso è questione molto complessa, in secondo luogo perché le declinazioni della verità nel regime di post-verità sono infinitamente più sfumate del rigido binomio vero-falso cui la questione fake news ci predispone.
Ma andiamo con ordine: perché il tema del falso è questione complessa? Perché esso rimanda a un’implicita visione ontologica e corrispondentista (esistono stati di fatto e i discorsi devono essere loro corrispondenti) che, se non vogliamo mettere in crisi sul piano filosofico (ricorrendo a teorie olistiche o relativiste o decostruzioniste), però certamente dobbiamo mettere in crisi sul piano pragmatico: come facciamo ad accedere agli stati di fatto? E come facciamo, sulla base di quali criteri, stabiliamo delle corrispondenze? (Come noto, anche la somiglianza è concetto graduato e culturale; il modo in cui il mio volto assomiglia a quello di una mia foto è molto diverso dal modo in cui assomiglia a quello di una caricatura che mi viene fatta da un conoscente antipatico).
Ahimè, viviamo di mediazioni discorsive – e non credo che questa sia deformazione semiotica. Accediamo al mondo per via discorsiva, sviluppiamo competenze organizzate da precisi paradigmi culturali, ci formiamo in base a modelli che sono ormai ampiamente mediatici… Il più delle volte, nel nostro stare al mondo (non solo oggi, in epoca di infodemia, né solo in epoca di post-verità) ci troviamo per lo più a confrontare non parole e cose ma parole con altre parole, e ciò che è vero non è ciò che corrisponde al reale ma forse solo ciò che non si oppone al reale, che è (circolarmente) ciò che non è falsificabile dai discorsi ritenuti veri sulla realtà. Quanto dico echeggia il realismo negativo di cui Eco ci ha parlato dal suo Kant e l’ornitorinco in poi, ma echeggia soprattutto la sua visione olistica della cultura: ciò che conta è l’insieme delle teorie, dei presupposti, dei significati che costituiscono i sistemi di credenze. Sono questi a costituire i nostri parametri di realtà. Come Eco dice appunto nel libro che ho appena citato, «non è l’autorevolezza della prova in se stessa quella che ci convince, o ci trattiene dal falsificarla: è piuttosto la difficoltà a mettere in questione una prova senza sconvolgere l’intero sistema, il paradigma che la sorregge».
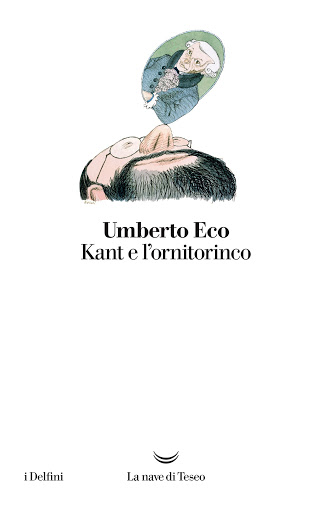
Per correggere le fake news, dunque, non basta il fact-checking. Il fact-checking, forse, è solo il minimo di deontologia professionale che si richiede a chi fa informazione: è ovvio che le informazioni date dovrebbero essere verificate. Per correggere le fake news, bisognerebbe ragionare invece sui parametri di realtà che assumiamo nella nostra vita, e qui il discorso si complica, perché come cercavo di evidenziare nel libro che ho pubblicato su questi temi (Postverità. Fra reality tv, social media e storytelling, Roma-Bari, Laterza, 2018) questo è un punto cruciale: i nostri parametri sono cambiati. Nel regime della post-verità, “reale” significa qualcosa di molto diverso (e molto più complicato) da ciò che poteva significare per una persona del primo’900: ciò che accade in un reality è reale? Difficile rispondere. Ci sono buone ragioni per dire sì (accade davvero, non è simulazione, non c’è sceneggiatura) ma altrettante buone ragioni per dire no (la telecamera condiziona la spontaneità, le condizioni contestuali sono date e delimitate in partenza, la dinamica degli incontri è predisposta, non spontanea). E la verità forse è che un reality è reale in un modo diverso da quanto lo sia un incidente stradale, così come sono stati reali in un modo diverso le decine di chiacchierate, aperitivi, lezioni, riunioni che abbiamo fatto in queste settimane di lockdown, senza contatti fisici, da quelli che facevamo prima, quando non avevamo restrizioni.

E vengo qui al terzo termine, infodemia. Voglio riportare dall’articolo di Rothkopf del 2003 sul Washington Post che per la prima volta lo ha utilizzato, questo stralcio: «A few facts, mixed with fear, speculation and rumor, amplified and relayed swiftly worldwide by modern information technologies, have affected national and international economies, politics and even security in ways that are utterly disproportionate with the root realities. […] An infodemic is not the rapid spread of simple news via the media, nor is it simply the rumor mill on steroids. Rather, it is a complex phenomenon caused by the interaction of mainstream media, specialist media and internet sites».
In questa prima definizione di infodemia, si parla di qualcosa di più specifico del generico ricorso a emozioni e opinioni condivise come criterio dell’informazione, che era il cuore della definizione del 2016 degli Oxford Dictionaries. Si parla di un triangolo vizioso: fear, speculation and rumor, che significa non emozioni generiche ma paura, e non solo opinioni ma tendenze a teorizzare (speculation) e tendenze a spettegolare (ad alimentare dicerie). Vediamo allora che, entro il paradigma della post-verità, il cerchio si stringe: un’infodemia è un fenomeno diverso, tecnicamente più preciso e più perverso, che vive dell’interazione fra media mainstream, fonti specialistiche e generici siti internet.
E qui vorrei evidenziare un’altra specificità dell’infodemia attuale, che dà una flessione specifica a un generale problema del regime di post-verità: nell’infodemia, il punto non è che non si dà più peso alle fonti autorevoli di informazione e che si discreditano le istituzioni. Il problema, nell’infodemia, è che le fonti autorevoli assumono le modalità delle fonti comuni, e gli spazi discorsivi si confondono: non sono più le persone comuni ad atteggiarsi a scienziati (come è successo ampiamente ad esempio nella battaglia no-vax, tipico esempio di manifestazione di post-verità), ma gli scienziati e i politici a scendere spesso sul terreno delle persone comuni, usando i loro canali, facendo commenti stizziti, spazientendosi.
Se dunque c’è un nodo cruciale della post-verità, che l’infodemia assume e rilancia, è la qualità confusiva: il problema oggi non sono le fake news, il problema è la carenza di principi distintivi, di criteri discriminanti per differenziare spazi discorsivi, obiettivi perlocutori, canali di comunicazione… E per questo l’unica strategia contro l’infodemia (e per gestire la post-verità, senza limitarsi ad abituarsi ad essa) non può essere il fact-checking (che ragiona e viaggia sul binomio vero-falso) ma l’educazione ai media, la critica dei linguaggi, la consapevolezza discorsiva.
Come diceva Eco, e come io stessa ho già detto altrove, non moriremo di penuria di verità, ma di eccesso di verità. Ne abbiamo troppe, e per questo dobbiamo ricominciare a saper fare distinzioni. Non procediamo come in un quiz a risposte giuste/sbagliate: questo è vero, questo è falso. Degli agognati fatti ci sono tante versioni vere, e saperle distinguere non è la posta in palio di un gioco a premi. É la scommessa di una vita, di una vita meno agonistica e più analitica (ma con questo apriamo un altro problema…).
