La vita delle forme. Filosofia del reincanto è il libro di Emanuele Coccia e Alessandro Michele da poco uscito per HarperCollins. Una copertina dall’estetica secentesca, un’impaginazione che assume la postura dei manoscritti della Bibbia o del Talmud, con le glosse aggrovigliate attorno al testo sacro: la tessitura riproduce plasticamente quella coincidenza di forme e vita che, secondo gli autori, contraddistingue la moda come arte, un incantesimo che ogni giorno trasmuta il nostro corpo e il nostro volto.
Sette sono le stanze – Filosofia, Ambiguità, Animismo, Design, Collezione, Hollywood, Gemelli -, gli spazi concettuali in cui le voci dei due autori s’intrecciano e si rincorrono coi loro registri: il filosofo e il couturier, uguali ma diversi, a loro modo gemellari. E viene da dire che ben pochi oltre ad Alessandro Michele, indimenticabile direttore creativo di Gucci ora alle redini di Valentino, ed Emanuele Coccia, il filosofo de La vita delle piante e della Filosofia della casa, avrebbero potuto dar vita a una fucina di questo tipo. Non è una spinta erudita quella sottesa al volume, piuttosto uno smottamento naturale, come l’incontro che lo ha fatto nascere. Non una “filosofia della moda” quale la si potrebbe immaginare: in questo testo non è la filosofia a scendere a patti con la moda ma è la “moda” che attraverso la filosofia si complica e prende vita.
L’ultima sezione del libro, Costellazioni concettuali, raccoglie i comunicati stampa di tutte le sfilate di Alessandro Michele per Gucci, dal 2015 al 2022. Comunicati stampa che, sebbene più sotterraneamente, hanno rivoluzionato la moda tanto quanto i suoi show, inaugurando una sorta di genere letterario alieno, alieno forse al pubblico stesso a cui era destinato. Eppure efficace nel forgiare assieme a quelle collezioni un nuovo modo – alchemico e animistico, anacronistico e contemporaneo, iperbolico e poetico – di pensare e vivere gli oggetti, e con essi la moda. Ne abbiamo parlato in questa intervista con Emanuele Coccia, Professore di Filosofia all’École des hautes études en Sciences Sociales di Parigi.
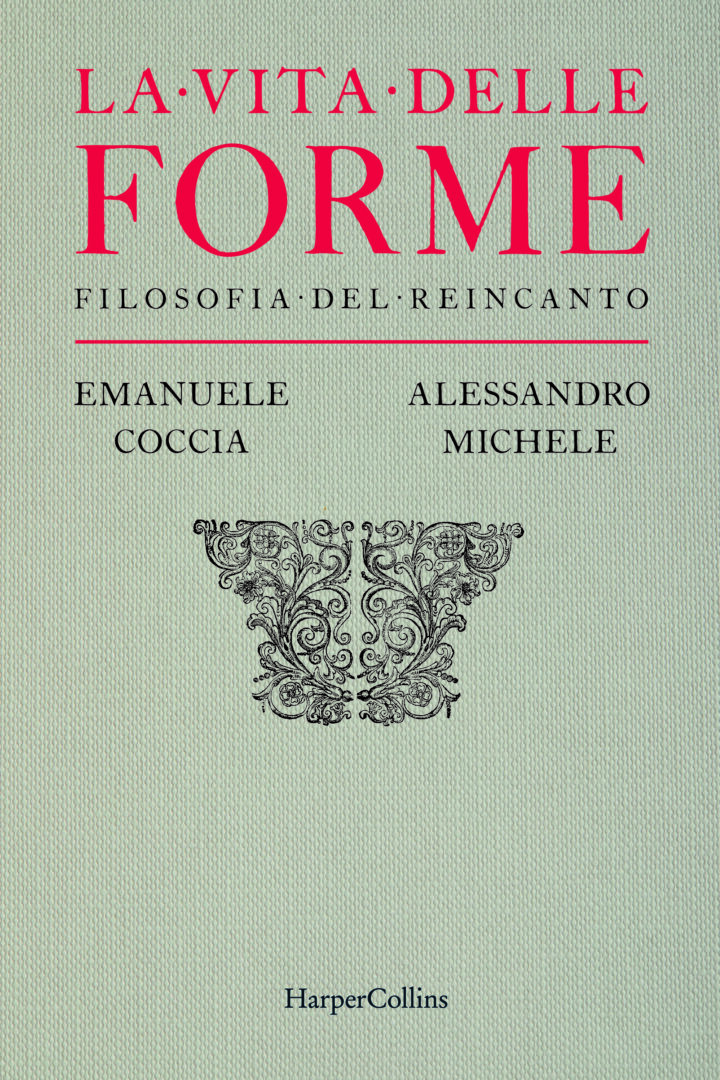
Moda e filosofia: un binomio che farebbe storcere il naso a molti accademici, ma nell’introduzione al volume scrivi che «per capire la moda è necessaria la filosofia», o meglio, «un dottorato in filosofia», come ebbe a commentare uno dei tuoi studenti ad Harvard. Perché?
La moda non è semplicemente una delle arti: è la forma che l’arte ha assunto quando le avanguardie hanno deciso che il compito supremo di ogni arte è di coincidere con la vita. Un abito è l’artefatto più universale: chiunque lo indossa tutti i giorni, tutto il giorno. E, a differenza di dipinti, sculture, film o performance, non è un puro oggetto di contemplazione ma uno spazio e uno strumento di trasformazione, posto nelle mani di chiunque. È come poter indossare una tela di Picasso e poterne fare il nostro stesso volto. L’arte è ovunque, e ogni corpo umano grazie a un abito diventa assieme opera d’arte, museo e artista. Per questo la moda è forse è la più metafisica delle arti: impone un esercizio di immaginazione speculativa su di sé e il mondo, invita a mutare volto, a inventarsi nuovi modi di essere, ad attraversare tutte le forme del mondo e a coincidere con esse almeno per un attimo grazie agli abiti. E che cosa è la filosofia se non il tentativo d penetrare nella vita di tutte le forme?
Dal volume: «I discorsi prodotti dalla critica della moda, così come dalla sua storiografia, sono infinitamente distanti dalla complessità e dall’erudizione che vengono richieste per qualsiasi riflessione sulla pittura, l’architettura o il cinema». In che modo il nostro tempo ha segnato la prevalenza di un giornalismo di moda poco colto?
Il sistema moderno della moda ha imposto a chi si riconosceva nel genere maschile eterosessuale quella che uno storico del secolo scorso, John Carl Flügel, aveva battezzato “la grande rinuncia maschile”: l’obbligo di ostentare una sublime indifferenza agli abiti, alla varietà di forme, colori, stoffe, e l’adozione ascetica di minimalismo e understatement per sottolineare la scelta di essersi consacrati alla produzione, alla serietà. È questo stesso genere ad aver imposto l’indifferenza e il sottile disprezzo per le forme della moda al sistema educativo occidentale: è solo per questo che si studia la storia della letteratura, della pittura o dell’architettura ma non la storia della moda. L’ironia della sorte è che in realtà questa fedele adesione al principio della rinuncia fa di costoro i più fanatici fashion victim.
Dicci di più.
La mancanza di educazione ha prodotto il paradosso di cui tu parli: chi scrive di moda può adottare uno stile pedestre inaccettabile per qualsiasi altra disciplina. È impossibile credere di poter giudicare un’opera esposta al Louvre o alla Fondazione Prada senza aver letto Michel Foucault o Rosalind Krauss. La moda, invece, si accontenta che i giornalisti che assistono a una sfilata ne parlino come di “primavera”, “freschezza” o “femminile”. Immaginate il destino di un giornalista che osasse parlare così di Jannis Kounellis o di Marlene Dumas.

Perchè la moda si accontenta di questo?
Perché questa attitudine ha colpito purtroppo le stesse grandi Maison, che hanno ancora difficoltà enormi a considerarsi come spazi di produzione culturale e non come semplici spazi di consumo e di affari. Il fatto che gran parte del patrimonio prodotto da Chanel o Margiela, McQueen o Kawakubo non sia oggetto di mostre o studi come può esserlo quello di Mies van der Rohe o di Fellini, mostra il cinismo criminale che le anima e che le distanzia dalle grandi gallerie d’arte, che sanno mescolare economia e cultura in maniera molto più virtuosa. Non è un caso se la dottrina diffusa nella moda è che investire in cultura significa sempre (quasi in forma di espiazione) finanziare pittura, architettura o scultura. Mai mostrare che la moda stessa è una forma di cultura in sé, non mescolandosi ad altre discipline.
Vedere la vita laddove gli altri vedono solo forme e colori: in che modo lo “sciamanesimo” di Alessandro Michele ha trasformato la moda, perché il suo impatto è stato così rivoluzionario?
È difficile riassumere i numerosi elementi che fanno di Alessandro Michele uno dei più grandi protagonisti della cultura contemporanea. Ne seleziono tre. Il primo è la rivendicazione dell’identità di moda e filosofia. Fin dalla prima collezione firmata in quanto direttore artistico di Gucci, nel febbraio 2015, Alessandro Michele ha accompagnato gli abiti con una serie di testi che possono essere definiti dei microtrattati di filosofia. Il primo iniziava e terminava con una citazione di Agamben e una di Barthes ed era una riflessione sul tempo: l’idea era che essere contemporanei non significa rifiutare e cancellare il proprio passato, introdurre una novità assoluta rispetto a ciò che siamo stati ma inventarsi un rapporto libero con il passato e restituire attualità a quei frammenti di passato che contengono ancora semi di libertà. In queste pagine, che ho voluto aggiungere al libro e che ne costituiscono la seconda parte, si citano Donna Haraway e Michel Foucault, la carte de tendre secentesca e l’antropologia novecentesca. È un modo per rivendicare il fatto che la moda è il luogo in cui la cultura, tutta la cultura, senza differenze di luoghi, di prestigio, di tempi, si stringe attorno a noi e diventa la nostra pelle.
E gli altri due elementi di novità?
Il secondo riguarda l’arte della ceramica (nel 2014 Alessandro Michele viene nominato Direttore creativo anche di Ginori, acquisito da Gucci l’anno precedente, ndr). La vera madre della moda infatti non è il design, che ha seguito la rivoluzione industriale, ma proprio l’arte della ceramica e della porcellana: quell’arte cioè che si annida negli oggetti più consueti e familiari (le tazze, i piatti, i ninnoli delle nostre stanze) per foderarle di storie, di visioni, di miti. La moda è la capacità di trasfigurare tutto il reale e di fare della storia e delle storie il nostro stesso volto, ma proprio per questo però anche la forza di liberarsene per raccontarne altrove. Il terzo elemento di novità assoluta è l’idea di genere.
In che senso?
Il sistema della moda contemporaneo aveva ereditato dal diciannovesimo secolo una concezione duale del genere: il maschile e il femminile. Questa dualità era stata formulata in maniera molto particolare: non si trattava di un’opposizione tra due forme o tra due palette di colori. Il maschile corrispondeva al neutro (il completo maschile) ovvero al grado zero di significazione che permetteva di non significare nulla a parte l’esclusione da qualsiasi significato. Il femminile coincideva con la totalità degli altri significanti. Ora, la moda non produce norme: produce delle glosse quasi invisibili che distorcono il senso della legge. Per secoli si è cercato di aggirare questa divisione attraverso il cross-dressing, l’inversione dei significanti di maschile e femminile. Ma si trattava di semplici inversioni locali, di licenze poetiche che non cambiavano la grammatica: si metteva un abito che significava “femminilità” sul corpo maschile. Affinché questa licenza avesse senso bisognava continuare a cogliere nella gonna il significato di femminilità. Un’altra via era quella del no-gender, dell’invenzione di abiti neutri. Ma come ho detto il neutro nella storia del costume coincideva con il maschile, quindi il no-gender significava costringere le “donne” a vestirsi come i “maschi” ovvero in fondo a rafforzare la logica del dominio di genere. Alessandro Michele inventa un’altra via, quella dell’ambiguità: creare abiti che fossero simultaneamente maschili e femminili. Ed è una doppia rivoluzione: in primo luogo l’abito non conferma né nega l’identità di genere ma moltiplica i generi, permette di mostrare più identità. E viceversa il genere di ogni corpo diventa multiplo.
Una rivoluzione tanto più inedita quanto più ha a che vedere, come spiegavi, con una riattualizzazione del passato. Qual è il ruolo della citazione? Mi vengono in mente il rapporto di Benjamin con la tradizione e la riflessione di Agamben sull’essere contemporanei come non coincidere col proprio tempo: il contemporaneo come intempestivo…
La moda ha una relazione singolare con il tempo: è l’unica che può permettersi di recuperare forme passate (gli anni Quaranta, gli anni Settanta) depurando quelle forme dal significato di antichità. Se un pittore dipingesse come si faceva negli anni Quaranta cercando di rendere riconoscibile questa appartenenza cronologica i risultati oscillerebbero tra il kitsch e la rivendicazione reazionaria di un rifiuto di ogni progresso delle arti. Nella moda la citazione del passato libera le forme dal loro marchio cronologico e libera il presente dalla necessità di coincidere con se stesso. Questo perché un abito è troppo vicino all’esperienza per poter significare solo il passato: è come se grazie ai vestiti tutto il passato delle forme avesse una chance di riempirsi di vita e di trovare un nuovo accento. E facendo questo la moda rende letteralmente impossibile la scrittura tradizionale della storia. L’arte diventa la liberazione di tutti i tempi.
Magia, alchimia, infanzia, luccicanza, rabdomanzia, animismo: il volume descrive una costellazione concettuale che va oltre la filosofia stessa. L’abito che divinizza la vita, l’abito come nume tutelare. Il couturier come alchimista, Mastro Geppetto dinanzi a Pinocchio, Victor Frankenstein di fronte al suo mostro. In che modo un abito riesce a fare tutto questo?
Un abito è una strana contraddizione dell’idea moderna del disincanto: l’idea che la nascita della scienza, la possibilità di comprendere razionalmente il mondo, abbia privato la realtà di ogni elemento magico, trasformando tutto in oggetto inanimato. In fondo ogni mattina, quando scegliamo cosa indossare, davanti al nostro armadio agli abiti non chiediamo un elemento decorativo: chiediamo di fornirci un supplemento di soggettività, la capacità di trasformarci in qualcosa che non possiamo essere attraverso le sole forze della nostra anatomia. E da questo punto di vista riconosciamo agli abiti la forza dell’incantesimo di Cenerentola: non sono solo pelli, sono soggetti dentro cui entriamo e attraverso i quali percepiamo diversamente il mondo.
«Impossibile essere ciò che si è o si vuole essere senza aggiungere qualcosa al nostro corpo». In che senso l’abito è libertà?
Il sistema della moda non prevede solo l’ideazione di abiti, prevede anche e soprattutto uno spazio co-creativo in cui ciascuna e ciascuno di noi è chiamato, ogni giorno, a reinventare il proprio volto, a inventare nuove identità in cui scivolare e di cui liberarsi la sera. Il rapporto che ogni individuo intrattiene con se stesso e con la propria identità prevede una libera manipolazione, una libera invenzione quotidiana. Questa è la libertà suprema.
Dicci del vostro incontro: come è avvenuto, com’è nata l’idea del volume?
Ci siamo incontrati grazie al compagno di Alessandro, Giovanni Attili, che insegna Teoria urbana a Roma. Abbiamo cominciato a parlare e non abbiamo più smesso. E l’idea del libro è sorta in modo naturale dalle conversazioni e dalle idee che emergevano in queste conversazioni.
Quale rapporto intrattiene questo capitolo del tuo pensiero con le riflessioni su natura e città e con la filosofia della casa? E quale sarà il prossimo?
Un abito è l’unico elemento domestico che ci segue ovunque: è una sorta di casa portatile, che si stringe sul nostro corpo e ci accompagna ovunque. Ma proprio per questo è molto più plastico e malleabile delle case costruite dagli architetti, che spesso sono in ritardo, assieme tecnologico e sociale, sui modi e le forme in cui noi pensiamo e viviamo il domestico, il proprio, l’intimo. La moda in fondo è l’architettura dell’intimità, l’arte di dare forma e struttura alla nostra identità assieme individuale e condivisa. Il mio prossimo libro, invece, sarà sulle nuove forme dell’amore, inteso però non solo come sentimento ma come forza capace di strutturare la società.
Durante la fashion week di Milano, a sorpresa, Alessandro Michele ha fatto uscire una collezione resort per Valentino, anticipando così il debutto che farà a settembre a Parigi. Cosa pensi di questi primi look? Cosa dicono del futuro di Valentino con Alessandro Michele?
Sono sublimi. È riuscito a coniugare la ricerca erudita con l’invenzione di una nuova contemporaneità. La sua collezione è la dimostrazione che la moda vive, è sempre imprevedibile e inconoscibile, e noi ne abbiamo bisogno più che mai.
