L’Italia ha da sempre rappresentato un pericoloso terreno da gioco per i grandi padri fondatori delle principali scuole della psicoanalisi. Sigmund Freud era un habitué del Bel Paese, memore dei Grand Tour franco-tedeschi dell’era romantica, ma Carl Gustav Jung, figlio di un pastore protestante, era talmente intimorito dalla varietà delle pulsioni psichiche che si aspettava di trovare a Roma da decidere di non visitare mai la città eterna. Cruciale fu, comunque, nel suo percorso intellettuale e biografico la città di Ravenna coi suoi molti mosaici, e sul finire della sua vita l’allievo eterodosso James Hillman tornò a interrogarsi a riguardo in lunghe conversazioni con Silvia Ronchey pubblicate a dieci anni dalla morte dello psicoanalista dei miti sotto il titolo L’ultima immagine.
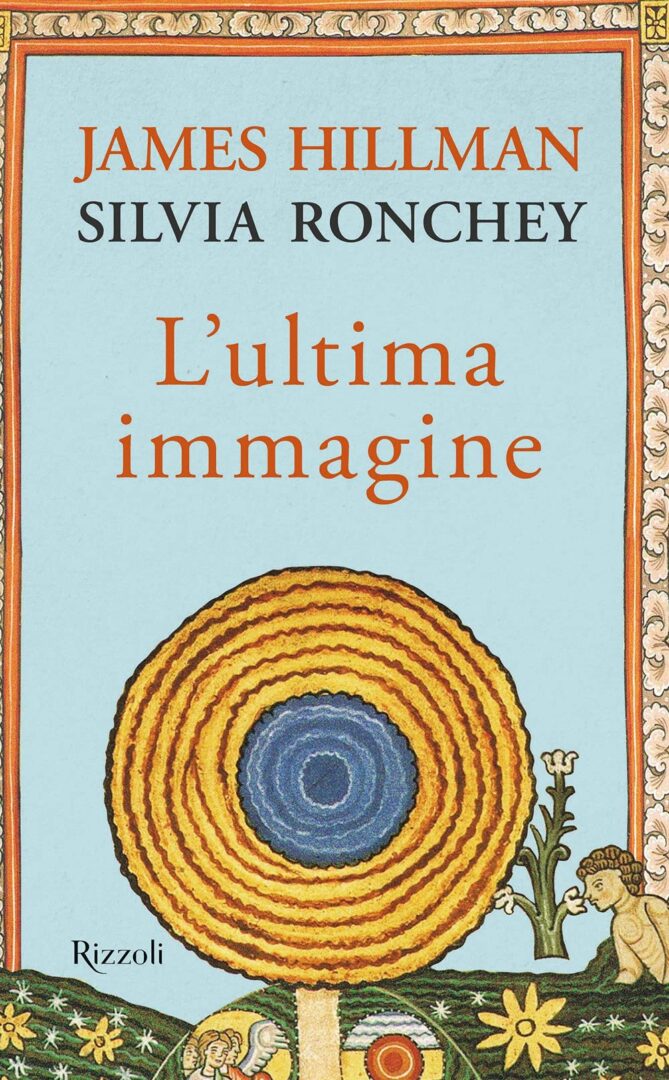
L’italianista e storica della psicoanalisi Marina D’Angelo ha recentemente dato alle stampe per Bollati Boringhieri il saggio I viaggi di Freud in Italia, ricco di scambi epistolari e appunti manoscritti inediti dello stesso Freud, che ricostruisce lungo tutto il lungo corso della vita del padre fondatore della psicoanalisi i molti viaggi nel nostro paese e il costante interrogarsi sulla cultura italiana, sulla civitas latina e sul retaggio psichico della tradizione cattolica. Fonte importante nell’analisi di D’Angelo sono i taccuini privati tenuti da Freud dal 1901 al 1915, a lungo considerati perduti per scelta deliberata di Freud come gran parte del suo materiale manoscritto per «non rendere la vita facile ai biografi»; poi sorprendentemente riscoperti nel 2009. Il legame tra Freud e l’Italia risale in realtà già all’ultimo scorso dell’Ottocento, prima ancora della pubblicazione dell’epocale Interpretazione dei sogni.
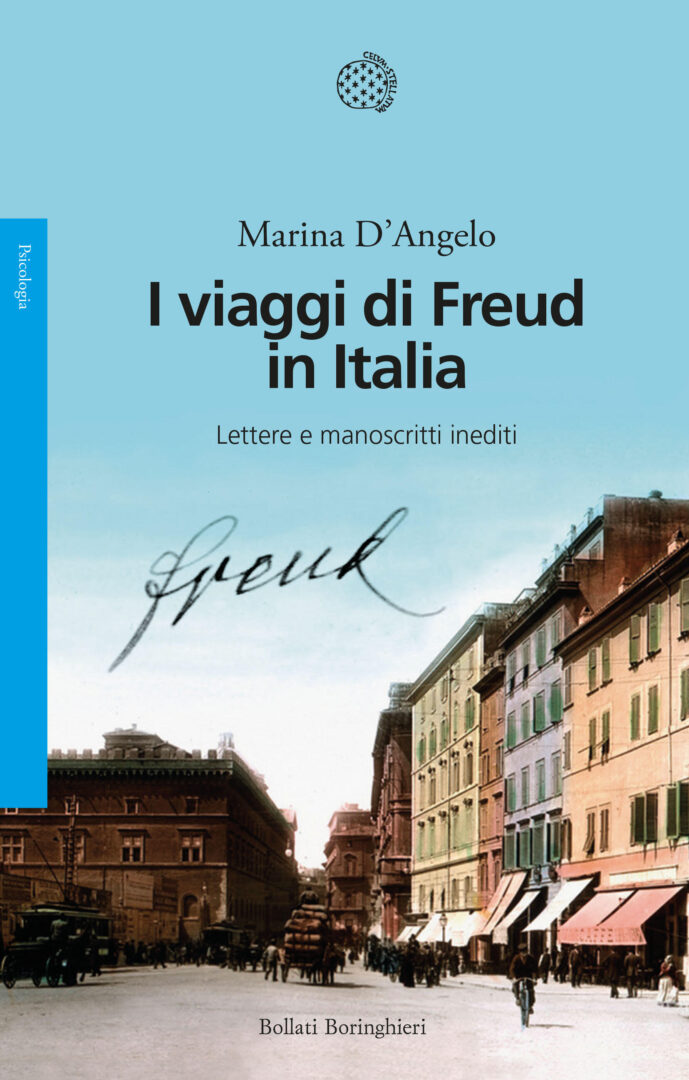
Agli occhi di Freud, all’epoca dei suoi primi viaggi nel Bel Paese quarantenne, l’Italia sembra essere una terra di ristoro dove cercare non solo riposo, ma anche nuove ispirazioni culturali per comprendere dal di dentro la civiltà occidentale. È molto esplicita a tal riguardo una lettera di Freud scritta nel 1897 da Siena a Wilhelm Fliess: «In Italia cerco, come tu sai, un ‘punch con Lete’, e ne sorbisco un sorso qua e là. Ci si ristora alla bellezza straniera e all’immane slancio creativo; ma in ciò trova il suo tornaconto anche la mia inclinazione per il grottesco, per le perversioni psichiche. Avrei molto da raccontarti». Anche Venezia lo lascia «stordito dalle nuove impressioni», tanto da fargli definire la città lagunare una «strana fiaba». Importante anche la visita nel Nord-Est, ad Aquileia e alle grotte di san Canziano, che definì «un vero Tartaro». Se, da buon austriaco, il Nord d’Italia gli sembrava quasi a portata di mano, più combattuta fu anche per Freud la discesa su Roma. Come scrisse in una lettera a Fliess di fine 1897: «Il mio desiderio di andare a Roma è profondamente nevrotico. È legato all’infatuazione che nutrivo da ginnasiale per l’eroe semita Annibale; e in realtà anche quest’anno, come accadde a lui, avvicinandomi a Roma, non sono riuscito ad andare oltre il lago Trasimeno», per poi concludere la missiva con una notazione a suo modo strepitosa: «da quando mi sono messo a studiare l’inconscio ho incominciato a trovarmi interessante».
Freud raggiunse Roma di persona solo nel 1901, e la visita della Città Eterna fu per lui, a tutti i livelli, un’epifania. «Dovrei scriverti di Roma, ma è difficile. È stata anche per me un’esperienza sconvolgente e, come sai, l’appagamento di un desiderio a lungo accarezzato. Sono rimasto un po’ deluso, come accade per tutte le cose attese per un lungo tempo, eppure è un momento culminante della mia vita», si legge in una lettera di Freud vergata durante il primo di vari soggiorni romani. Pochi mesi dopo, a marzo 1902, il fondatore dell’allora neonata psicoanalisi venne nominato dall’imperatore Francesco Giuseppe professore universitario straordinario – e anche tra questa nomina e il viaggio a Roma di poco precedente il pensiero di Freud seppe tracciare oscure convergenze. Nella stessa Interpretazione dei Sogni si dilungò a discutere «quattro sogni romani» pervasi di angoscia e di riferimenti alla morte del padre – e a ulteriore comprova dell’amalgama psichico che Freud riscontrava in sé stesso e negli altri a proposito di Roma e dell’Italia tutta, nell’Interpretazione c’è anche una disamina dell’attività onirica di una sua paziente in relazione a una fantasia di viaggio in Italia reinterpretati in chiave sessuale attraverso il gioco di parole gen Italien = genitali.
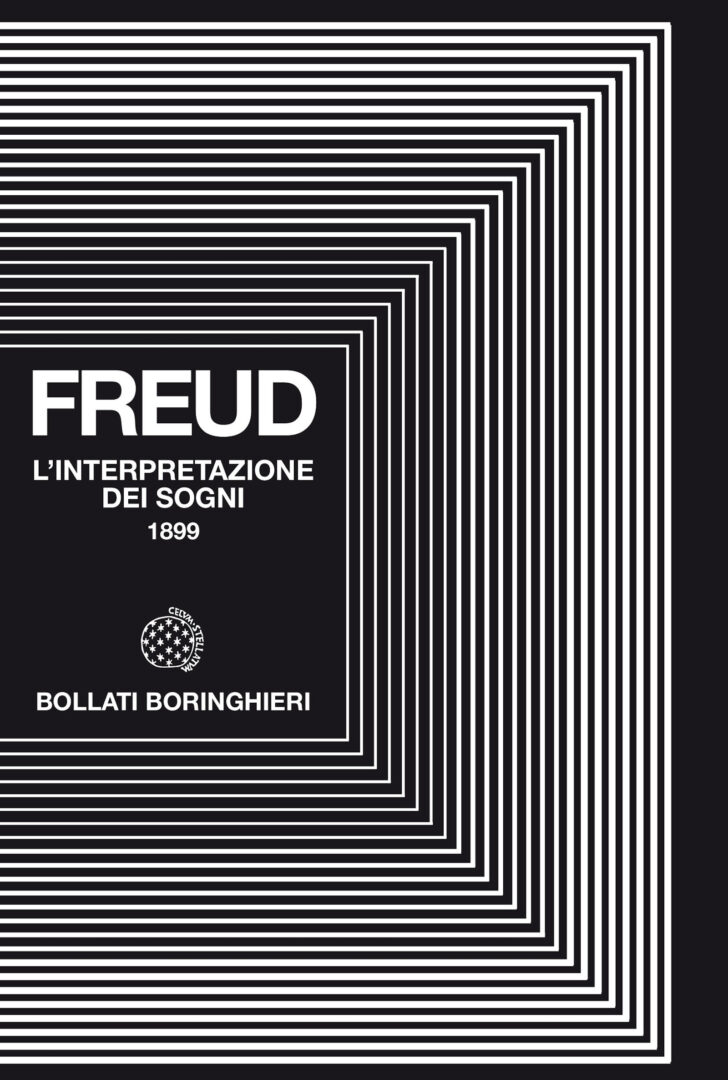
Nel 1902 Freud visitò finalmente anche Napoli e Pompei, la «città sepolta» che andava citando nelle sue metafore saggistiche sin dagli Studi sull’isteria del 1895 – «in questa prima analisi completa di un’isteria da me intrapresa, arrivai a un procedimento che in seguito ho eretto a metodo e introdussi deliberatamente un procedimento di svuotamento strato per strato, che ci piaceva paragonare alla tecnica del dissotterrare una città sepolta». Nel curioso esperimento di psicoanalisi letteraria sulla Gradiva ritornò ancora più esplicitamente sul tema: «Per la rimozione, la quale rende inaccessibile e contemporaneamente conserva qualche cosa di psichico, non vi è in realtà analogia migliore del destino subito da Pompei, che è stata sepolta ed è ritornata alla luce a opera della vanga». La Gradiva stessa di Wilhelm Jensen, una novella abbondantemente e quasi ossessivamente analizzata da Freud in chiave psicoanalitica, altro non era in partenza che una fantasia pompeiana. Anche la vista del Vesuvio e l’osservazione del ciclo del vulcano e della lava suscitarono in Freud non dissimili considerazioni e accostamenti psicoanalitici, in un crescendo di fenomeni clinici e relativi sintomi: nei suoi appunti si legge «rimozione – isteria; formazione reattiva – nevrosi ossessiva; irruzione [nella coscienza] – paranoia».
Via via che la fama della psicoanalisi si espandeva a livello internazionale, e il nome di Freud risuonava tra lodi, critiche, controversie e misinterpretazioni, l’Italia rappresentò sempre più spesso una via di fuga e una valvola di sfogo delle tensioni e aspettative che si andavano concentrando sulla sua persona. Nel soggiorno romano del 1907 Freud affrontò anche una crisi depressiva non lievissima, anche a seguito della decisione di sciogliere simbolicamente la Società del mercoledì che per anni si era riunita in casa sua per discutere ed espandere le intuizioni del maestro. Questa inquietudine si propagò anche per una successiva tappa ad Orvieto, dove i suoi taccuini testimoniano di una vera e propria fantasia di evasione in piena regola – «Viaggio come un re non incoronato, una sorta di Patesi» – il re-sacerdote sumero – «della psicoanalisi, in incognito, fantasia di abbandonare gli affari, libero dalla famiglia con l’esperienza del cinquantunesimo anno».
Fedele al motto goethiano secondo cui «l’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nell’anima», dopo aver consigliato già un viaggio sull’isola a vari pazienti e conoscenti come terapia contro certi malesseri della psiche, finalmente Freud vi approdò personalmente nel 1910 assieme a Sándor Ferenczi, il primo tra i non famigliari ad accompagnare il maestro in Italia. «La Sicilia è la regione più bella e ha conservato pezzi veramente unici della grecità scomparsa, reminescenze infantili che consentono di trarre conclusioni riguardo al complesso nucleare», fu il resoconto che ne diede per lettera a Jung. Qualche traccia mnestica la lasciò anche Firenze, tant’è vero che qualche settimana dopo il ritorno a casa Freud si trovò a sognare una maschera con le fattezze dell’eretico Girolamo Savonarola, ma è noto che di tutti i grandi monumenti italiani quello che più rimase impresso nella memoria e nell’immaginario concettuale freudiano fu il Mosè del Michelangelo più volte visitato negli anni a San Pietro in Vincoli – salendo la ripida scalinata che porta «dall’infelice via Cavour» alla facciata di una delle chiese più belle di Roma. Sulla statua di Michelangelo Freud si interrogò a lungo, vagheggiando e impostando anche un’idea di ‘romanzo storico’, poi le sue riflessioni confluirono in un saggio apparso originariamente anonimo in quanto «figlio non analitico» del suo pensiero, in realtà un passaggio chiave dell’opera freudiana per comprendere la sua visione delle religioni e il suo stesso rapporto con le proprie origini ebraiche. Da non sottovalutare neanche l’importanza di Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, che Freud stesso indicò a Louise von Salomè come uno dei suoi scritti migliori.
La Prima guerra mondiale interruppe la consuetudine dei viaggi in Italia. Freud compì un ultimo viaggio a Roma nel 1923, accompagnato dalla ventisettenne figlia Anna, poco tempo dopo l’apparizione dei primi segni del cancro alla mandibola che lo portò lentamente alla morte, e pochi mesi dopo la prematura morte del nipotino Heinz, soprannominato Heinele, uno dei più grandi shock emotivi della vita di Freud. Ormai anziano, sempre più spesso tradito da antichi seguaci, Freud si adeguò più che volentieri alla routine delle sue giornate viennesi, fino a quando l’avvento del nazismo e l’Anschluss dell’Austria non lo costrinsero a riparare, già moribondo, nell’allora neutrale Inghilterra.
A più di ottant’anni dalla morte di Freud, dopo tanto strutturalismo e post-strutturalismo francesi, teorie mimetiche girardiane, intuizioni neurologiche di Sacks & co., «ribellioni al padre» a opera di Jung o letture semiotiche della psicoanalisi targate Lacan sarebbe un gioco fin troppo facile meta-psico-analizzare Freud a partire dal suo complesso ma documentatissimo rapporto con l’Italia, la sua storia e le sue iconografie. In realtà il vero appiglio attraverso cui si potrebbe e dovrebbe leggere il rapporto tra Sigmund Freud e il nostro paese è più di impronta antropologica e linguistica, che psicoanalitica in quanto tale. Freud era un ebreo di lingua tedesca – non nascose mai le sue origini, pur ribadendo di essere un non credente rigorosamente positivista, e nella sua lingua aveva una prosa di tal gusto da sfiorare a più riprese il premio Nobel per la Letteratura. L’interesse di Freud per l’Italia non è il terreno giusto per un gioco di specchi psicoanalitica: lo si comprende meglio se si assume la prospettiva di un germano, nel senso storico, archetipico e per certi versi genetico del termine, nei confronti di un paese cattolico, nato da un impasto di civitas latina, cultura magno-greca e reminiscenze etrusche.
È il linguaggio forse il vero nodo nell’interazione tra Freud e l’Italia – il linguaggio e l’immaginario. La psicoanalisi, ai suoi albori, era una lingua in cerca di un linguaggio – c’è stata una pratica prima della teoria, una grammatica prima del lessico. Non per nulla Freud utilizzò in vari scritti, inclusa l’Interpretazione dei sogni, la citazione virgiliana Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo: «se non posso piegare le potenze superiori, muoverò gli inferi». È noto come Freud stesso, e tutti i suoi interpreti, critici e biografi dopo di lui, hanno visto nel sorgere del suo collezionismo una forma di compensazione psichica per la morte del padre Jacob, nel 1896. I suoi «vecchi e sporchi dèi», come affettuosamente li chiamava, lo accompagnarono fino all’ultimo giorno, nella dimora londinese che adesso ospita il Freud Museum. Le ceneri stesse di Freud, e di Martha, riposano in un’urna proveniente dall’Italia meridionale, un vaso greco del III o IV secolo a.C. donato al fondatore della psicoanalisi dalla principessa Bonaparte in occasione del suo settantacinquesimo compleanno.
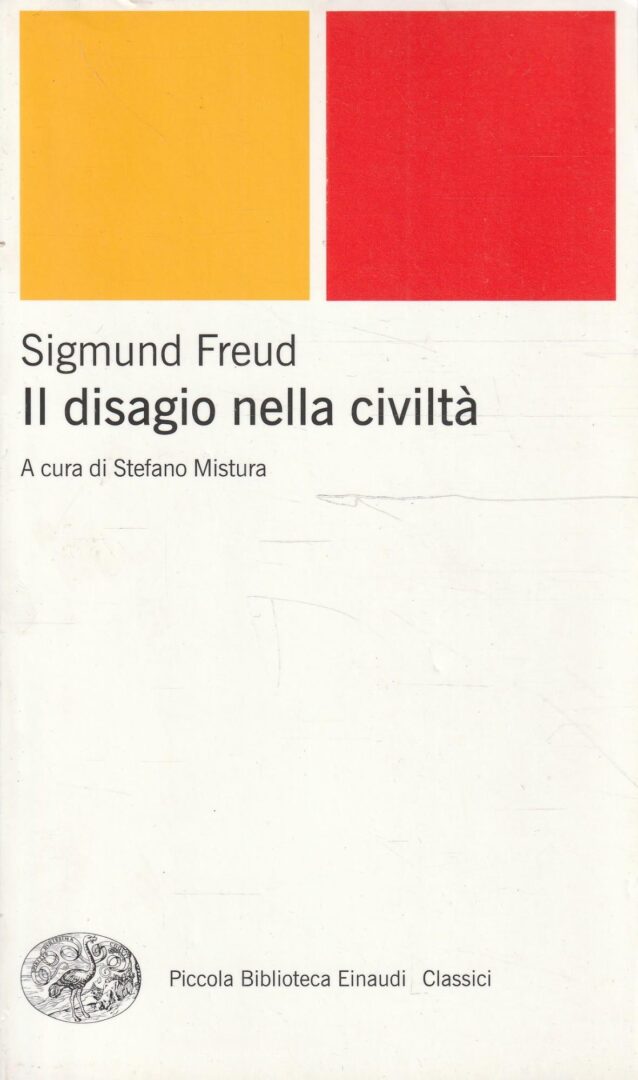
L’Italia era per Sigmund Freud il palcoscenico su cui visualizzare i concetti su cui lui si soffermava. Già nel 1902, durante una visita alla basilica di San Clemente a Roma, Freud aveva osservato che la caratteristica principale della psiche è che in essa tutti gli stati di sviluppo della mente umana sono conservati. Alla stessa maniera san Clemente affonda le sue radici architettoniche nel paganesimo, custodisce anche antiche catacombe cristiane, ma adesso così come agli albori del secolo scorso si staglia agli occhi del visitatore o del turista come una delle chiese più spettacolari di Roma. È proprio utilizzando la capitale come simbolo che Freud nel 1930 azzarda ne Il disagio della civiltà «l’ipotesi fantastica che Roma non sia un abitato umano, ma un’entità psichica dal passato similmente lungo e ricco, un’entità, dunque, in cui nulla di ciò che un tempo ha acquistato esistenza è scomparso, in cui accanto alla più recente fase di sviluppo continuano a sussistere tutte le fasi precedenti. Nel caso di Roma ciò significherebbe quindi che sul Palatino i palazzi dei Cesari e il Septizonium di Settimio Severo si ergerebbero ancora nella loro antica impotenza, che Castel Sant’Angelo porterebbe ancora sulla sua sommità le belle statue di cui fu adorno fino all’assedio dei Goti, e così via». La psicoanalisi ha rappresentato e rappresenta tuttora un unicum nelle scienze per il suo carattere trasversale, tra medicina e filosofia, tra individuo e comunità, tra storia e metafisica, tra analisi, critica e ri-soluzione. Non per nulla James Hillman si è dilungato sulle simmetrie tra psicoanalisi e alchimia. Per restare nelle scienze profane, è l’archeologia la disciplina che più si avvicina al metodo e alla teoria inventati da Freud e tuttora oggetto di uno dei più frastagliati dibattiti a livello accademico. Entrambe le discipline, psicoanalisi ed archeologia, sono accomunate da un pressante interrogarsi sull’Origine e da un perenne rifarsi a tracce, impronte, residui, scarti, rimossi. L’archeologia però è inevitabilmente rivolta al passato – solo la psicoanalisi ricerca l’Origine per dissodare il futuro.
