«Riderà al Sole
L’Impero crollerà
Forse ce ne andremo
Alla città»
Mannarino, L’Impero
L’ultima immagine, l’ultimo libro di James Hillman in dialogo con Silvia Ronchey da poche settimane pubblicato da Rizzoli, si apre con un accostamento vertiginoso. È il settembre del 2008, il grande psicoanalista junghiano e la grande storica bizantina sono seduti a un caffè di Ravenna, e commentano il crollo di Wall Street appena annunciato, «un trilione di dollari scomparsi nel nulla» – ma, per una deliziosa e comune deformazione professionale, nel giro di poche battute i due si trovano a rievocare il crollo dell’Impero Romano d’Occidente, nel 476 d.C. «È dal crollo che cominciamo. Dalla fantasia archetipica di tracollo presente in tutta la civiltà occidentale. Che cosa la permette, qual è il fondamento di quest’ansia costante che tutto stia per crollare?», si chiede Hillman nelle prime pagine dell’opera-dialogo postuma.
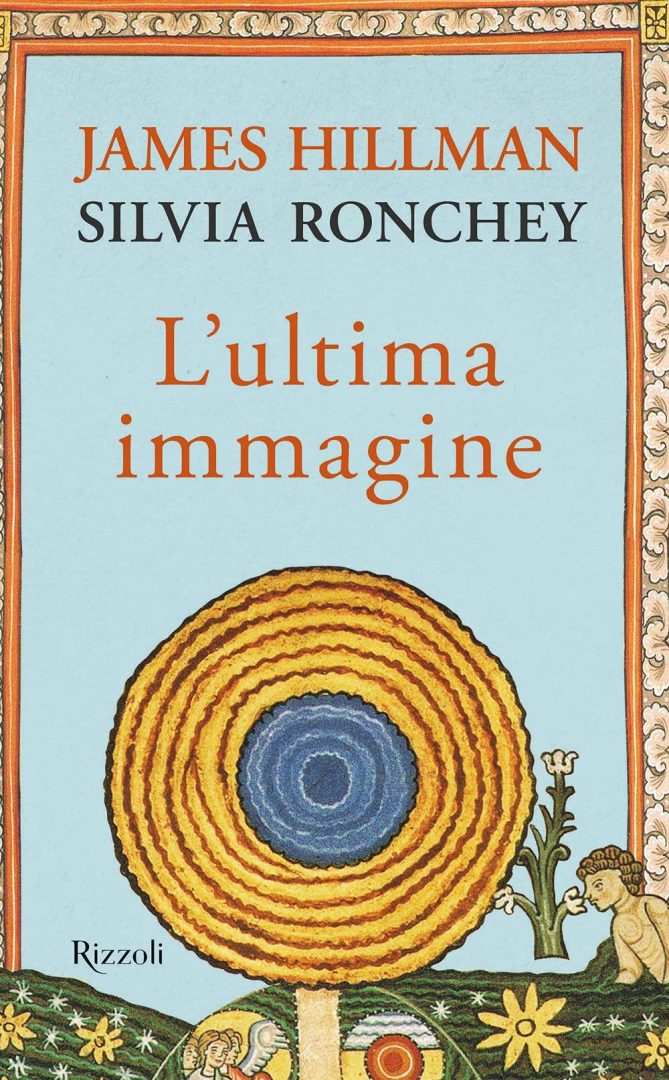
Siamo sempre negli stessi anni: è il 2011 e, in una delle edizioni più ricche del Festival di Cannes, viene presentato anche Melancholia di Lars von Trier. Il film è rigidamente scandito in due parti: nella prima, la giovane Justine, chiaramente affetta da disturbi depressivi, fa andare a monte il suo matrimonio il giorno stesso delle nozze, comportandosi in un modo irrazionale e del tutto scollegato di fronte all’ipocrisia dei parenti venuti a festeggiarla. Nella seconda, Justine e la famiglia della sorella Claire attendono il passaggio davanti alla Terra del gigantesco pianeta blu Melancholia (“Depressione” in inglese): quello che viene propagandato come un bellissimo fenomeno astronomico diventa però bruscamente la vera e propria fine del mondo, con Melancholia che si schianta contro la Terra. Mentre una visione di apocalittica bellezza si staglia davanti agli occhi degli spettatori, l’unica a mantenere la calma fino alla fine è Justine, che sembra quasi aver voluto attirare a sé il pianeta.

Torniamo indietro di qualche decennio al capezzale di Ernesto de Martino, forse il più grande antropologo italiano, morto prematuramente nel 1965 mentre stava ancora sviluppando la sua opera magna La fine del mondo: che testi incentrati sulla Fine del Mondo e sul Grande Crollo debbano uscire postumi è un criterio che accomuna de Martino ad Hillman. Certo è che le assonanze de La fine del mondo sono indubbie, tanto con L’ultima immagine quanto con Melancholia di Lars von Trier: ad accomunare de Martino al duo Hillman/Ronchey è una consapevolezza acuta della ricorrenza delle fantasie apocalittiche nelle civiltà umane; ad accomunare de Martino e Lars von Trier è l’accostamento tra l’apocalisse intesa come fine del mondo, come (fantasia di) distruzione in grande stile, e l’apocalisse psicopatologica che rappresenta invece un vissuto privato di scissione e di perdita di significato nel mondo che ci circonda. Per fare i suoi esempi di apocalissi psicopatologiche de Martino non ricorreva al cinema, bensì alla letteratura esistenzialista allora fresca di stampa, ai vari Sartre e Moravia: ma il modulo interpretativo demartiniano può essere fedelmente applicato anche al film di Lars von Trier, e del resto, in uno dei saggi pubblicati nel recente La lettera uccide, Carlo Ginzburg ha suggerito che de Martino sia stato avvicinato alla tematica apocalittica anche dalla visione del fim L’Eclisse di Michelangelo Antonioni, col suo disumano finale.

«Ricorre così spesso nella nostra storia la fantasia della fine del mondo. Il mondo di oggi offre un contesto storico perfetto all’idea di fine. È il sentimento dominante della nostra epoca», sentenziava Hillman a Ravenna, registrato dalla fedele Silvia Ronchey. Gli esempi raccolti da de Martino negli appunti per quella che rimase un’opera incompiuta testimoniano l’universalità sia geografica che temporale di questo motivo apocalittico – ma al tempo stesso, scritti in piena guerra fredda, concordano nel dire che il sentimento di fine si è fatto particolarmente attuale dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, tanto più che, in piena era della tecnica, gli uomini hanno perso quella dimensione rituale e comunitaria di risoluzione delle crisi collettive e individuali tipica del mondo rurale, che l’antropologo aveva investigato in Sud e Magia e in altri scritti precedenti.
Per indicare questo sentimento di fine, il lessico religioso – ma verrebbe da dire il lessico filosofico tout court, o, per certi versi, il lessico politico – ci suggerisce una parola particolarmente preziosa, da preservare in quella lingua greca in cui è nata: “eschaton”, letteralmente “l’ultimo”.
«L’eschaton: la fine, o piuttosto l’estremo, il limite, il termine, l’ultimo, ciò che viene in extremis a chiudere una storia, una genealogia, o semplicemente una serie numerabile», scrisse il filosofo di origini ebraiche Jacques Derrida, su cui presto torneremo. L’eschaton è, nella teologia cristiana, il tempo “ultimo” prima della fine dei tempi, ma talmente ultimo da coincidere di fatto con questa fine, con il Giorno del Giudizio: dopo l’eschaton, se questo Dopo ai limiti del paradosso si rivelerà, si consumerà finalmente l’avvento del Regno dei cieli, della Gerusalemme Celeste, di tutti quei “luogo concetti” a cui la tradizione cristiana ci ha già da tempo assuefatti. È chiaro però come, da un lato, il concetto di eschaton tenda a sfuggire a una sua applicazione unicamente religiosa, pretendendo una sua designazione filosofica più generale – e, dall’altro, il sottotesto spettacolare ed esplosivo che questo termine porta con sé sia così apocalittico e cruciale da finire per oscurare quanto di salvifico può seguire, a questo tanto temuto e tanto agognato eschaton.
Il concetto di ultimo ha la sua importanza primaria, nella tradizione di pensiero – e di vita – occidentale. Altrettanto importante della nozione di eschaton come ultimo (pre-)apocalittico, anche se meno vistoso, è il concetto di ultimità evangelica, che tanto ha mutato, sotterraneamente, la nostra civiltà. Ma qualcosa dell’eschaton in quanto concetto ultimativo, in cui l’attesa dell’apocalisse si sovrappone alla catastrofe che si identifica in fondo con l’apocalisse stessa anche quando strictu sensu ne è il preludio, qualcosa di questa strategia di pensiero sembra sopravvivere in quella nozione strepitosamente kantiana che è l’“idea regolatrice”. Dio, l’anima, una certa nozione di mondo: pochi, irrinunciabili concetti sono annoverati da Kant sotto questa nomea; ma idea regolatrice sarà anche quell’idea di fine della storia che, evocata più che altro al maschile da Hegel, è implicita in quel concetto spinoso della critica letteraria che è il post-moderno. In un altro senso, anche un’altra idea regolatrice condivide con queste la stessa tendenza ad essere eschaton: è quell’idea di Terra Promessa, di Eden si badi bene restaurato, di Paradiso raggiunto e di Temps Retrouvé che tanto l’escatologia cristiana quanto l’escatologia marxiana prefigurano, dopo le tribolazioni del Giorno del Giudizio o della Rivoluzione del Proletariato che sia. (Ad Ernst Bloch piace questo elemento). In fondo, se fra eschaton ed escape ci potesse essere più di una semplice assonanza fonetica tra le due lingue-chiave dell’Occidente, verrebbe da concludere che l’eschaton è quasi un punto di fuga, a metà strada tra concetto a sé e puro dispositivo logico, ricorrente in molti passaggi chiave del pensiero occidentale, sia sotto forma di un ideale, e quindi del contenuto, sia come strumento di contro-interpretazione, e quindi come struttura.
O archeologia o escatologia: nei suoi quasi tre millenni di storia, la filosofia occidentale si è saputa raramente affrancare da questi due poli. L’ἀρχή dei presocratici è solo l’altra faccia della medaglia di quel compimento della filosofia invocato da Hegel: al centro tra questi due estremi c’è un Dio cristiano che si permette di dire “io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine”. Adorno, Cioran, per certi versi anche Benjamin – ma anche e soprattutto Heidegger, o il nostro Severino, e in maniera diversa lo stesso René Girard. Da ambo i lati della filosofia del Novecento, tanto nella filosofia maggiore e accademica quanto nella filosofia “minore” di alcuni pensatori privati o comunque isolati, quella di apocalisse sembra essere una categoria di pensiero tanto silenziosa quanto ricorrente, sotto le parole d’ordine intrecciate di Decostruzione e di Ritorno alle Origini che, in forme molto diverse, sembrano reggere un’intelaiatura profonda di tutto il pensiero del Novecento.
Non è allora un caso se Jacques Derrida, forse il più esplicito esponente della Decostruzione novecentesca, nel 1983 abbia voluto scrivere un intero opuscolo per parlare Di un tono apocalittico adottato di recente in filosofia. Secondo l’autore de La voce e il fenomeno, che inizia la sua trattazione soffermandosi proprio sulla traduzione dell’ebraico galah nel greco ἀποκάλυψις, è grossomodo a partire dai tempi di Kant che la filosofia, iniziando ad analizzare meta- sé stessa anche in termini di stile, ha assunto un andamento apocalittico; ed è proprio con due occorrenze in Kant che si legge per la prima volta l’idea di una ferale “morte della filosofia”. Come rimarca bene Derrida non è però Kant a voler celebrare questo funerale: usa l’espressione unicamente per ironizzare contro «coloro che, per il tono che assumono e l’aria che si danno al momento di dire certe cose, mettono la filosofia in pericolo di morte e dicono alla filosofia o ai filosofi l’imminenza della loro fine». Ai tempi dell’Illuminismo, la filosofia sembra per molti versi più viva che mai – ma il sospetto della sua morte, subdolamente, inizia a farsi sentire, così come l’esigenza di uno sconfinamento della filosofia nella pratica politica.

Il campo di battaglia in cui, nella rilettura di Derrida, la filosofia si è effettivamente trasformata in escatologia, e in escatologia di sé stessa, è l’Ottocento – il secolo in cui, all’inizio, a metà e al termine, sono apparse rispettivamente le profezie di Hegel, di Marx e di Nietzsche. Questi sono tre filosofi da cui, dopo essere stata rinnegata da Kant, questa «veglia presso il corpo della filosofia» viene a vario titolo annunciata: come compimento, in Hegel; come suo prosciugamento nella praxis, in Marx; come suo fatale smascheramento, in Nietzsche. Con il Novecento, la situazione si è del tutto esautorata: e questo vizio di parlare della “morte della filosofia” si è trasformato in vezzo, presto diffusosi ad annunciare la fine di infiniti altri quid. Ironizza dunque Derrida:
«Ve lo dico in verità, non è soltanto la fine di questo ma anche e soprattutto di quello, la fine della storia, a fine della lotta delle classi, la fine della filosofia, la morte di Dio, la fine delle religioni, la fine del cristianesimo e della morale, la fine dell’uomo, la fine dell’Occidente, la fine di Edipo, la fine della terra, Apocalypse Now…»
Quasi rappando, Derrida elenca una lunga serie di escatologie ormai stereotipe, di obsoleti Discorsi della Fine, per poi concludere con fare meta-:
«E chiunque venisse a sottilizzare, a dire il fine della fine, cioè la fine della fine, la fine delle fini, che la fine è sempre già cominciata, che bisogna ancora distinguere tra la chiusura e la fine, quel tale parteciperebbe, che lo voglia o no, al concerto. Perché è anche la fine del metalinguaggio riguardo al linguaggio escatologico. Sicché si può domandare se sia un tono, l’escatologia, oppure la voce stessa.»
Anche se nel suo testo non si sbilancia ad indicare chi siano questi filosofi “apocalittici”, e gli unici pensatori a lui contemporanei che in Di un certo tono apocalittico cita esplicitamente, in positivo, sono Blanchot e Levinas, Derrida arriva qui a sfiorare l’identificazione tra certa filosofia moderna e l’escatologia tout court. Nell’impossibilità di una sortita radicale dalla tradizione che secondo alcuni è tipica del post-moderno – tanto impossibile che nell’aggettivo stesso di “radicale” è implicito il rimando alle radici – si assiste a un ripiegamento sui concetti di compimento, di fine e di morto come ultime attestazioni di un’attutita originalità per quei pensatori che si sono trovati a vivere al termine di un secolo fin troppo ricco. In questo fare apocalittico adottato dalla filosofia e, verrebbe da aggiungere, nel concetto di eschaton in generale, «l’imminenza non importa meno della fine. La fine è prossima, sembrano dire» questi caustici annunciatori, «il che non esclude che essa abbia già avuto luogo, un po’ come nell’Apocalisse di Giovanni».
Ma allora perché, prima ancora di iniziare tutto questo excursus che lo porterà indietro nel tempo fino all’Isola di Patmos di San Giovanni Apostolo, la conclusione di Derrida, anticipata in realtà già nelle prime pagine del saggio, è che «l’Apocalisse è essenzialmente una contemplazione»? Questo spoiler è uno dei passi più cifrati di tutto l’opuscolo di Derrida ma, viene da sospettare, anche uno dei più folgoranti. A quest’ultimo dubbio può risponderci, indirettamente, uno dei pensatori apparentemente più lontani che si possano immaginare rispetto alle costellazioni del pensiero derridiano – Martin Heidegger.
La parola apocalisse non è certo tra le più ricorrenti del lessico heideggeriano – ma può essere adottata come chiave interpretativa per rileggere alcuni dei passi più noti della sua intera opera. Innanzitutto, quella fine della metafisica rincorsa nel Nietzsche, fine che si identifica come compimento nell’opera del grande predecessore: ma se la fine della metafisica è il suo compimento nell’opera di Nietzsche, la fine della metafisica è la sua rivelazione sotto i colpi martellanti dell’antiplatonismo nietzschiano. Nietzsche, nella lettura di Heidegger, crede di uccidere la metafisica, invece ne è il rappresentante più estremo, il suo eschaton: l’ultimo pensatore a restare imbrigliato in quella rete che avvolge il pensiero occidentale almeno dai tempi di Platone – ma anche il primo, si potrebbe dire, a trovare se non una via d’uscita dalla metafisica, una lunga serie di punti di fuga, di cerniere da aprire abbandonando dogmi e bias. La fine della metafisica, che Nietzsche porta a compimento e che Heidegger dichiara ufficialmente morta anzi superata, equivale alla verità della metafisica; equivale, non per nulla, a una sua destrutturazione, a una sua spoliazione.
Il portato apocalittico della filosofia di Heidegger può essere colto anche nel suo notorio concetto di verità, o meglio nella Decostruzione ad originem che il filosofo, ne L’essenza della verità e in svariati altri passi della sua opera, compiva segmentando il corrispettivo termine greco ἀλήθεια. Verità, o il vero, τὸ ἀ-ληθές, ἀ-ληθές quindi, con l’alfa privativo: «i Greci intendevano ciò che noi chiamiamo il vero come il dis-velato, il non più velato; ciò che è senza velatezza e dunque ciò che è stato strappato alla velatezza, ciò che le è stato, per così dire, rapito». Verità come svelamento – o, come meglio Heidegger traduce il più delle volte, come “svelatezza”. È una cosa risaputa: come ricordato anche da Derrida nelle prime righe del suo pamphlet, anche apocalisse o meglio ἀποκάλυψις significa, in greco, rivelazione. Se Heidegger, indovinando la sfumatura come nessun traduttore prima di lui, propendeva per tradurre ἀλήθεια non con “svelamento” ma con un più fine “svelatezza”, l’apocalisse sembra essere quindi il processo che conduce a questa benedetta verità ultima. Ogni verità è a suo modo apocalittica – affermazione non per forza speculare, tanto più se davvero, come sotterraneamente ci viene da pensare, ogni apocalisse è, prima di ogni altra cosa, nichilista, anche quando è religiosa.
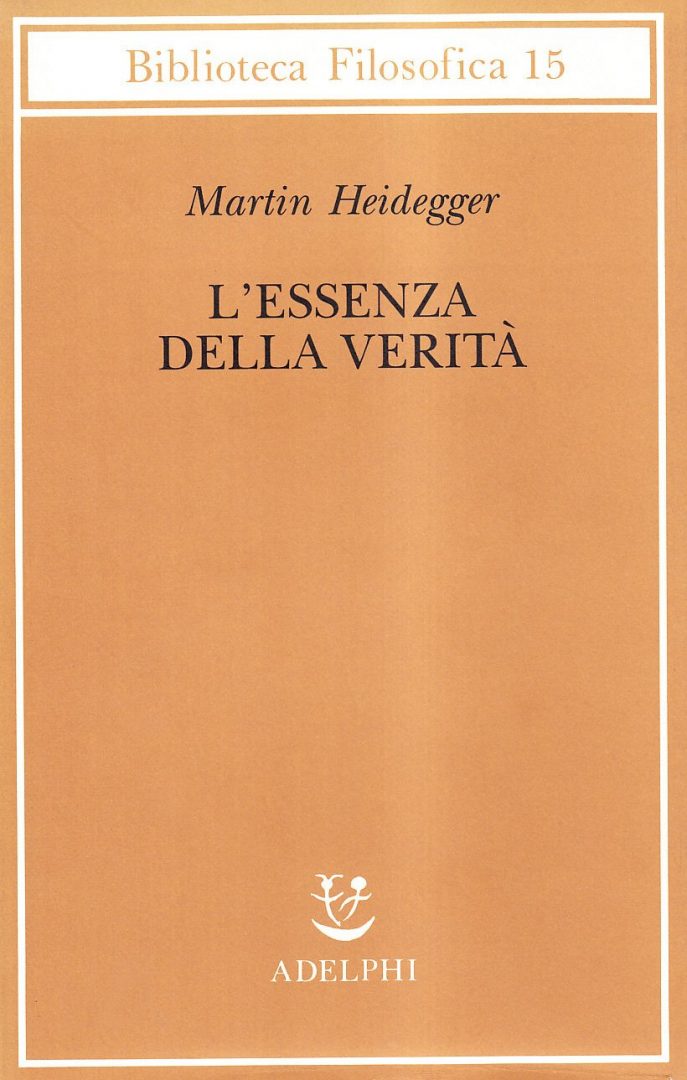
Un ultimo scalino adesso. Se, per restare in ambito greco, ricordiamo come, anche senza andare sull’iperuranio, la verità più alta fosse essenzialmente teoretica, una parola meravigliosamente irrisolta tra il “vedere” e il “conoscere” – si capisce perché Derrida sentenziava che l’apocalisse è essentiellement una contemplazione – uno sguardo – una tragedia – una rivelazione negativa che è anche uno smascheramento trionfale dei Poteri grigi che soggiacciono al mondo se non della Realtà tout court. L’apocalisse, forse, è una festa – epistemologicamente parlando – la festa della verità.
«La palma alla fine della mente,
Oltre l’ultimo pensiero, sorge
Nella scena bronzea,
Un uccello dalle piume d’oro
Canta nella palma, senza senso umano,
Senza sentimento umano, un canto strano»
Wallace Stevens, Del mero essere
Immagine copertina: Melancholia, Lars Von Trier
