Eumeswil (1977) non è solo il romanzo in cui si condensa la summa del pensiero di Ernst Jünger, ma anche il monumentale (e attuale) affresco di un mondo ‘postapocalittico’. Il libro si ambienta nell’omonima città «epigonale», in cui una civilizzazione esausta si trascina, alternando periodi repubblicani e democratici a tirannidi e dittature monocratiche. Il protagonista, Martin Venator, vive nell’epoca del tiranno soprannominato ‘il Condor’, presso il quale presta servizio come steward notturno. Una postazione fisicamente prossima ai meccanismi del ‘potere’, un punto di osservazione privilegiato. Di giorno infatti Martin è uno storico, assistente del professor Vigo. Proprio Vigo è una delle figure più interessanti del romanzo, per le numerose similitudini che lo avvicinano a Oswald Spengler, pensatore verso cui Jünger ha sempre proclamato il proprio debito, ma che in Eumeswil riceve un ritratto ad altissimi livelli. Il professor Vigo è un personaggio a tutto tondo a cominciare dal nome, non scelto a caso, in assonanza con quello di Giambattista Vico (1668 – 1744). Vico è in realtà un filosofo cui Spengler deve molto, ma che non nomina mai: particolare denso di significato, così come significativo è che Jünger scelga proprio lui per ritrarre Spengler.
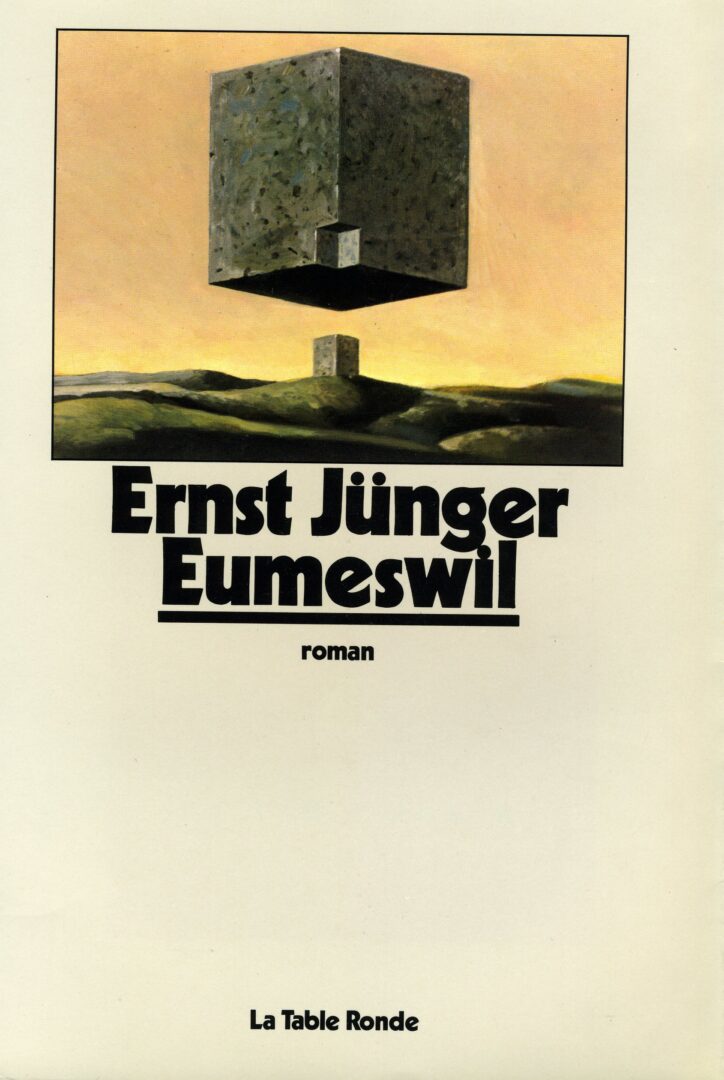
Il fratello e il padre del protagonista Martin Venator, repubblicani convinti, non approvano la vicinanza con il professore, e muovono a quest’ultimo le ben note accuse del leitmotiv antispengleriano: mancanza di scientificità, dilettantismo, stile da romanzo d’appendice. Difatti Vigo, dotato di uno sguardo da giardiniere e da botanico più che da cacciatore, procede diagonalmente e non cronologicamente attraverso il passato. La storia mondiale è per lui – come per l’autore de Il Tramonto dell’Occidente – un’immane tragedia, piuttosto che il gioco di ruolo con cui si baloccano politica e geopolitica. «La storia mondiale è un tragico destino» – tuonava Spengler negli appunti per la colossale opera che doveva rimpiazzare il Tramonto, mai terminata – «I suoi scenari sono campi di battaglia per inestricabili conflitti dell’anima. La sua eredità sono cadaveri e rovine». E infatti Vigo «come studioso», «non è altro che un frugatore di pergamene e di sepolcri»: «poi però pone la questione vitale, reggendo in mano il teschio». La questione dell’Essere e del Divenire: ecco il dilemma fatale della Storia intesa in senso superiore. In determinati momenti, allora, il professore jüngeriano è in grado di far cogliere con estrema violenza al proprio uditorio questo tormento e questa afflizione dello storico.
Proprio come Spengler, Vigo si serve di fonti che gli storici comuni non degnano, costruendo audaci analogie. In una sua lezione tipo, egli traccia la vicenda dell’emiro Musa e della Città di Rame, tratta da Le Mille e una notte. Vicenda tragica: la città abbandonata è costellata di esempi di caducità delle vicende umane; in particolare vi è un tavolo, al quale sono stati seduti migliaia e migliaia di re, tutti morti. Ubi sunt? La coscienza che generazioni di uomini potenti si siano succedute, ma che tutti popolino i sepolcri, porta alle soglie della pazzia il poeta Thalib e tutti coloro che ascoltano la traduzione delle iscrizioni; l’emiro Musa è scosso fino alle lacrime e arriva a svenire. Il presente ci oltrepassa rendendoci passato: è questa la tristezza che affligge lo studioso di rango. Avanzando ci illudiamo di procedere verso il futuro, quando in realtà ci affrettiamo a diventare passato. Le grandiose gesta che furono si rivelano allo storico nella loro caducità e svelano la finitudine umana: la penna trema tra le mani.
Vigo ne è profondamente consapevole; non a caso, il suo umore predominante è una fondata tristezza. Ma vi è una fondamentale differenza tra il professore e Spengler: mentre quest’ultimo intende cogliere nella storia mondiale, romanticamente e teutonicamente, la «grandezza nel dolore», Vigo, dinanzi alla morte della storia e alla contemplazione – ora possibile – di tutte le epoche storiche è condotto alla malinconia (Martin Venator, invece – e forse Jünger stesso – a un lucido, ‘anarchico’ disincanto). Un aspetto però accomuna Vigo e Spengler: il loro essere isolati. Vigo non è uomo adatto ai suoi tempi: «Che una persona di alta cultura si trovi in armonia con lo spirito del suo tempo, è stato sempre un caso fortunato, una eccezione rara». Proprio dal suo essere indecifrabile per il proprio tempo scaturisce la sua condanna, la proscrizione. La critica allo spirito del tempo «è talmente cifrata da riuscire di ardua penetrazione» (in realtà è la sua stessa ‘sostanza’ ad esserlo): ciò gli vale la damnatio del mondo accademico. «Là dove tutti si muovono, e per giunta nella medesima direzione, sia a destra che a sinistra, verso l’alto o verso il basso, chi se ne sta quieto disturba. È avvertito come un rimprovero, e poiché gli si urta contro, è ritenuto l’offensore».
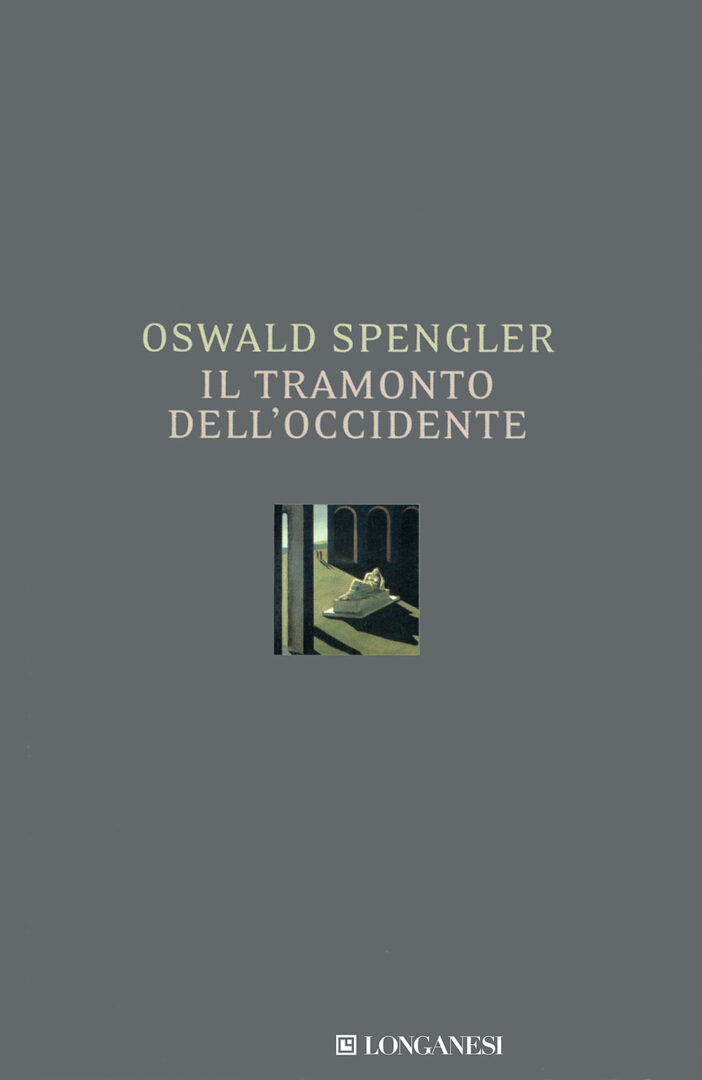
Con fine tecnica a sbalzo, la figura di Vigo risalta per contrasto con quella di Kessmüller (anche qui, nome tutt’altro che casuale). Accademico e tipico intellettuale stipendiato, di successo, alla moda, simile agli attori del mercato nietzschiano, passato indenne attraverso regimi anche contrastanti. Riesce a mutare idee secondo la direzione del vento, in virtù del fiuto che contraddistingue simili figure: «ha un istinto per il conforme e per irresistibili luoghi comuni, che stilizza pretenziosamente». Durante le proprie lezioni, sale sulla predella carnevalesca e come un comico consumato fa la caricatura di Vigo. In questo, non appare molto diverso da un noto parodista che recita poesie al porto «come se venissero … spremute fuori da uno che stia accoccolato sul cesso». Come ogni accademico e pensatore di successo, anche il professor Kessmüller ha il suo seguito di ratti fedeli, deputati a sbranare la vittima designata (in questo caso, Vigo). La serietà di Vigo fa sì che di queste persecuzioni egli se ne faccia un cruccio. Tiene per sé e per rari accoliti le sue grandi riserve, usandone solo una minima parte per le lezioni pubbliche. In compenso, organizza simposi serali per pochi eletti, durante i quali riesce a far balenare dinanzi agli occhi dei presenti la vertigine e il dolore della storia. Ma la sua stessa passione lo consuma e lo conduce alla spossatezza; la notte si conclude con un laconico «Ragazzi, lasciatemi solo».
Immagine di copertina: Matthias Brandes, Interno cina
