La storia dell’umanità è una storia di migrazioni. Singoli e popolazioni si sono sempre spostati sulla terra e per mare alla ricerca di una vita diversa, per necessità, alla ricerca di nuove risorse, ma anche per curiosità, spirito di avventura, umanissimo desiderio di cambiamento e attrazione per l’ignoto. La contemporaneità sembra però aver rimosso la memoria ancestrale di un comportamento che ha sempre caratterizzato la specie umana. I paesi occidentali attraversano in questi anni una fase di violentissimo rifiuto del fenomeno migratorio, della sua inevitabilità, della sua umanità. Si costruiscono barriere di diversa natura: fisiche, con i muri e la militarizzazione delle frontiere; legali, creando apparati burocratici ostili e quasi inestricabili; e mediatiche ed emotive con una propaganda aggressiva che racconta l’immigrazione come una minaccia. Eppure al di là dei respingimenti e delle deportazioni, dei mancati soccorsi che causano stragi, dei campi di prigionia e di tutti gli orrori, i crimini e le violazioni in cui si esprime questo rifiuto esiste anche chi continua a credere in un paradigma diverso e a lavorare per offrire accoglienza con professionalità e dignità. Alle storie di accoglienza è dedicato CASA LORO, un podcast realizzato dall’attrice, autrice e podcaster Natalie Norma Fella e prodotto da Bottega Errante Edizioni. Natalie mette la sua esperienza di narratrice e professionista dell’audio al servizio di un progetto che racconta come proseguono le storie di migrazione dopo lo sbarco, dopo l’arrivo. Protagoniste sono le voci delle persone migranti e delle operatrici e operatori di Oikos, un ente che si occupa da tanti anni di accoglienza sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Per raccontare questo progetto ne abbiamo parlato con la sua creatrice, Natalie Norma Fella.
Cominciamo dal principio, come è nato il progetto di questo podcast?
Casa loro nasce da “Prassi intermedia”, un progetto precedente, del 2023, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia a cura di Oikos. Lo scopo era la prevenzione della radicalizzazione, in tutte le sue forme e di tutte le parti in causa, tramite la formazione ed era rivolto a forze dell’ordine, dipendenti della pubblica amministrazione e giornaliste e giornalisti. Al progetto aveva partecipato anche la casa editrice Bottega Errante, che curava in quel caso la pubblicazione del Glossario delle migrazioni, uno strumento distribuito nel corso del progetto, ma gratuito e accessibile a chiunque. Bottega Errante mi contattò per propormi di realizzare anche un podcast all’interno di “Prassi intermedia”. Non ero particolarmente esperta sul funzionamento dei sistemi di accoglienza per persone migranti, ma ho iniziato a studiare e conoscere di più a partire da quella prima collaborazione, che ha dato vita ad Albergo Roma, un podcast in puntata singola che racconta, da diversi punti di vista, la Comunità per minori stranieri non accompagnati di Fagagna, in provincia di Udine. C’era la storia dell’edificio, la percezione della comunità locale attraverso la voce del sindaco e il racconto di uno degli ex minori che erano stati accolti lì.
Nel 2024 Oikos ha ottenuto il finanziamento dalla Regione FGV per “Pratica Logica”, un nuovo progetto di prevenzione della radicalizzazione rivolto anche alle scuole, che prevedeva una nuova produzione audio. Ragionando insieme e facendo un po’ di riflessioni anche a partire da come stavano andando le cose dal punto di vista politico ho proposto di lavorare non a un episodio singolo, ma a una serie più lunga, di alcune puntate, per raccontare il sistema di accoglienza e come stava cambiando.
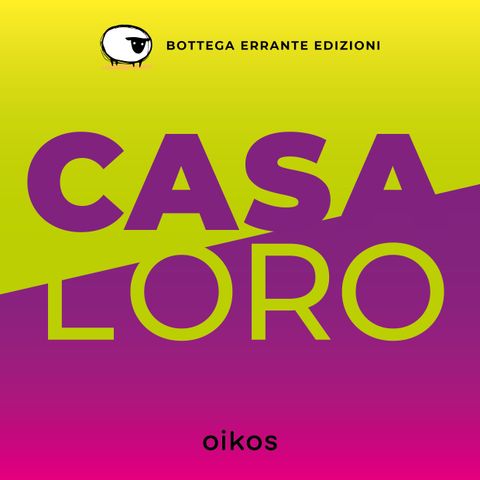
Nell’ascolto, uno degli aspetti che mi ha colpito di più è la resa chiara della confusione. Leggi e regolamenti che cambiano continuamente, sigle, enti e istituzioni che si sovrappongono, giurisdizioni che confliggono, questioni tecniche complesse, contraddittorie. Tu sei riuscita a fare una narrazione lineare, ordinata e concisa della realtà dell’accoglienza però allo stesso tempo e in apparente contraddizione, capace di restituire questo senso di confusione con cui si confrontano le persone che «la praticano, la ricevono e l’attraversano», come dici nel podcast. È stata una sfida? Come ci sei riuscita?
Per prima cosa ho cercato di farmi spiegare tutto quello che non capivo. Ho l’impressione che le uniche persone informate sul sistema dell’accoglienza siano quelle che con i suoi meccanismi si confrontano tutti i giorni, perché cambia continuamente. Tante tante volte mi è capitato di chiedere una precisazione e di ricevere una risposta del tipo: “Non ti so rispondere in questo momento perché questo procedimento è stato cambiato l’altro ieri”.
Nella seconda puntata, Stare alle regole, quella dedicata appunto ai regolamenti, ho cercato di mettere in fila le informazioni che sono riuscita a raccogliere. All’inizio faccio un elenco di acronimi, di leggi italiane, di accordi internazionali e regolamenti europei, di classificazioni delle richieste, di forme di accoglienza e altro ancora. Questo pezzo non dà forse delle informazioni dettagliate sul sistema, ma dà una sensazione precisa di quanto sia confusionariodel fatto che sia continuamente cangiante e che starci dentro significhi abbracciare un grandissimo caos, in cui però bisogna essere molto precisi, perché se non lo sei, il rischio è che le persone accolte si ritrovino in una situazione complessa. Probabilmente viene fatto anche apposta: rendiamo l’accoglienza molto difficile sperando di disincentivare le persone che arrivano. Era importante dare almeno all’inizio di quella puntata quella sensazione di grandissima confusione, per poi entrare negli aspetti più tecnici.
Per cercare di rendere questa confusione è stato importante il confronto con un’altra persona, qualcuno che non era continuamente coinvolto negli incontri e nelle interviste. La collaborazione con Jonathan Zenti, l’editor, mi ha aiutata a lavorare sui meccanismi narrativi e a riorganizzare i materiali per offrire una spiegazione di come funziona l’accoglienza spero chiara e lineare, spalmata nel corso delle quattro puntate, a seconda dei temi.
Uno dei messaggi più forti del podcast è qualcosa di evidente eppure che non avevo mai sentito esplicitare nella narrazione mainstream: in Italia non c’è un modello di accoglienza, perché la migrazione è trattata come un fenomeno emergenziale e transitorio anziché come una questione strutturale quale di fatto è. È una cosa banale ma che mi ha stupito, dandomi una prospettiva nuova, che porterò con me. Che cosa invece ha stupito te nel corso del tuo lavoro di ricerca?
Una delle cose che mi ha colpito di più nella fase di interviste è la differenza nell’accoglienza di persone bianche e non. Le persone in arrivo dall’Ucraina, per esempio, rientrano in un sistema d’accoglienza a parte, perché il loro tipo di permesso ha regole diverse che comportano un certo tipo di possibilità e prospettive economiche. Il limite di reddito massimo che richiedenti asilo di altra provenienza non devono superare per poter restare all’interno del sistema di accoglienza ha una soglia così bassa che di fatto alimenta il mercato nero sia del lavoro che immobiliare.
Questo limite di reddito per chi è accolto nei CAS Ucraina non c’è, o almeno non c’era fino al momento in cui ho fatto le interviste. Non avere questo limite genera la possibilità di costruirsi una propria autonomia, dignitosa, al di fuori dei centri di accoglienza con tempi e mezzi il più adeguati possibile.
C’è un problema diffuso sempre più grande dal punto di vista abitativo e tocca anche il ceto medio basso italiano e le generazioni più giovani. Tutte queste lotte si intrecciano e possono essere anche molto molto vicine, simili, solo che le persone migranti molto spesso non hanno nemmeno il lusso di poter lottare, perché sono troppo dentro a questioni vitali e problematiche.
Mi soffermo su quello che hai detto, sul fatto che il modello di accoglienza italiano nega che le migrazioni siano strutturali, che nega la sistematicità. Non si nega il fenomeno, ma lo si accoglie solo come emergenziale. Lavoriamo in emergenza, come se pensassimo che poi il problema passerà, quando invece ci sarebbe da cambiare il paradigma. È forse una modalità diffusa di affrontare fenomeni che sono grandi, penso anche al cambiamento climatico. Occorrerebbe decidere di cambiare proprio la visione delle cose, di destrutturare tutta una serie anche di aspetti culturali forse. Ci vorrebbe una posizione forte dal punto di vista politico e molto coraggiosa nell’accettare anche una fase iniziale di difficoltà.
Il pubblico in senso ampio è certamente abituato a vedere storie che hanno a che fare con la migrazione nei servizi dei telegiornali e più di recente anche al cinema o a leggere reportage. Qual è il valore aggiunto che secondo te può portare la forma dell’audio alla narrazione di questo fenomeno nello specifico?
L’audio è uno strumento molto potente per dare voce direttamente alle persone coinvolte. Mi emoziona un po’ questo aspetto. In molti dei lavori che ho fatto c’è stata la volontà di contribuire con un pezzetto alla costruzione di uno spazio di parola. A volte questo spazio è mediato da una narrazione esterna o dalla scrittura, ma in CASA LORO, diversamente da altri progetti in cui raccontavo la mia esperienza sul campo, io intervengo solo per essere utile a chi ascolta nel capire in che situazione si trova chi parla, a che punto è del suo percorso migratorio e dell’iter giuridico che lo scandisce. Quando a parlare sono operatrici e operatori fornisco informazioni in più, che loro magari tendono a dare per scontate.
Dal punto di vista mediatico si parla tanto degli arrivi, da tutti i punti di vista, si parla degli arrivi via mare – via terra forse un po’ meno – e di tutti gli aspetti più problematici. Di quello che succede dopo invece, di quando le persone sono qui, si sa un po’ meno, perché è un casino e perché è più difficile parlarne. Continuo a dire che CASA LORO è un progetto “non sexy” perché per avvicinarti al tema dell’accoglienza devi essere tu che ascolti a dire: “Ok, fammi capire un attimo come funziona”. La potenza dell’audio è che crea questa vicinanza, questa sensazione che la persona che parla stia parlando a te, proprio a te, ti stia parlando nell’orecchio, ti stia raccontando. E se non sta parlando direttamente a te è come se stessi origliando qualcosa che sta accadendo in quel momento, anche se sai che non è così, che è una registrazione. La tua immaginazione riempie il vuoto di tutto ciò che non vedi, quindi metti qualcosa di tuo in quello che stai ascoltando. Chiaramente lo fai anche quando leggi, ma nel libro manca quella parte emotiva legata alla voce, quella parte che ti permette di avvertire le emozioni che attraversano la persona che parla.
So che a un certo punto della lavorazione Jonathan Zenti, lo story editor di CASA LORO, ti ha detto che mancava qualcosa e tu hai fatto un altro viaggio, sei tornata sul campo e sei rientrata, per usare le parole di Jonathan, con il golden tape. Senza svelare di che cosa si tratta per non rovinare la sorpresa a chi sicuramente correrà ad ascoltare dopo aver letto questa intervista, quali sono le difficoltà nella raccolta delle testimonianze? Come hai selezionato quali includere negli episodi?
In quel caso abbiamo proprio cambiato il tema della puntata. Il piano di lavorazione prevedeva un altro argomento per il terzo episodio, che doveva essere dedicato alla salute mentale e al benessere emotivo sia delle persone accolte sia delle persone che lavorano nell’accoglienza. È un tema su cui c’è tantissimo da raccontare e soprattutto su cui ospiti dei centri e personale hanno tantissimo da dire. Per la struttura di CASA LORO però era giusto e importante che il terzo episodio si concentrasse invece sulle prassi dell’accoglienza. Questo cambio è nato dal confronto con Jonathan e anche dalla riflessione che, dal momento che l’episodio precedente è dedicato alle regole, era importante raccontare come si riesca a far funzionare l’accoglienza nonostante il restringimento di queste regole. Sono tornata sul campo per intervistare persone che non avevo incontrato in precedenza. Le difficoltà nella fase di raccolta dei materiali stanno proprio nella ricerca delle persone da incontrare e nella selezione. La raccolta dei materiali può essere infinita. Per raccontare temi enormi come migrazione e accoglienza puoi fare veramente tantissime interviste. Per individuare chi intervistare io faccio una ricerca e mi appoggio al supporto di altre persone, in questo caso di una delle operatrici di Oikos. Per CASA LORO andava capito chi aveva una storia che si prestava per ricostruire le buone pratiche e chi aveva un livello di italiano abbastanza buono da poter parlare in prima persona, perché lavorando con l’audio non posso mettere i sottotitoli e avrei avuto anche bisogno di un mediatore o di una mediatrice per fare l’intervista.
Nel caso delle persone intervistate per il terzo episodio, è stato un po’ come quando gli amici ti fanno un match: eravamo già pronte all’incontro, preparate e desiderose di farlo e quindi si è subito costruita una relazione, che ha permesso anche che loro si potessero fidare di me. È molto importante quando raccogli delle testimonianze o fai un’intervista che si riesca a costruire quello spazio di fiducia per cui la mia figura non risulta predatoria, che sia uno spazio di dialogo e che ci sia quindi poi anche la possibilità di dire: «Te l’ho detto mentre registravamo, ma ci ho ripensato», soprattutto con persone in una situazione vulnerabile da tanti punti di vista. In particolare per quell’intervista, del terzo episodio, non sono stati fatti i loro nomi reali e alcuni aspetti della loro storia, del loro percorso migratorio e delle motivazioni per cui l’hanno intrapreso non sono rientrati in puntata perché non c’entravano con il tema, per quanto potrebbero essere succosi narrativamente. Per quanto potesse essere interessante da ascoltare, quella parte della loro storia era molto delicata per loro e quindi nella puntata non c’è.
Tu sei riuscita a raccontare l’accoglienza con calore, ma in modo concreto e pragmatico, evitando pietismi, sentimentalismi e sensazionalismi. In un’epoca in cui la comunicazione e l’informazione sono caratterizzati così fortemente dalla spettacolarizzazione e influenzati dalle modalità dell’intrattenimento, quanto hai lavorato per discostare il tuo modo di raccontare da quello a cui siamo abituati da sempre e in cui siamo immersi?
Il tentativo di scardinare quel meccanismo di pietismo è una cosa che cerco e spero di fare anche in altri progetti. Non è che sia semplice tutte le volte. Non escludo che possano esserci degli scivoloni di cui magari mi accorgerò riascoltando. A volte correre il rischio di fare uno scivolone ci sta, ma con l’obiettivo di provare a costruire uno spazio di parola.
Per la narrazione mi ha aiutato avere a che fare con operatori e operatrici di un ente che si occupa di accoglienza e che alla base non ha uno sguardo pietista sui propri ospiti. La professionalità e la formazione danno una dignità sia alle persone che lavorano sia alle persone che vengono accolte, nella consapevolezza che il percorso che fanno insieme deve essere un percorso transitorio. Una cosa che ripetono è: «Il nostro obiettivo è diventare inutili». Intervistandoli mi è stato detto da molti di loro, è proprio la visione di Oikos (e sicuramente di altri enti simili): diventare inutili significa che la persona si è resa autonoma, che il suo percorso e la sua storia di vita possono proseguire in autonomia. Anche tutti i progetti extra che cercano di fare non hanno lo scopo di prolungare l’accoglienza, ma è tutto è volto a fare in modo che quando escono dal sistema le persone migranti siano veramente autonome e non si ritrovino per strada perché il rischio è questo quando si esce dal sistema di accoglienza, se non c’è una progettualità, di vita della persona migrante, e di società, da parte della comunità accogliente nei confronti della persona migrante. Altrimenti sarebbe un parcheggio: le persone stanno lì per un tot e non ci interessa poi dove vanno. Invece l’idea è: “Stai arrivando a casa mia e ti vuoi costruire la tua, inteso non solo come casa, ma come tuo percorso di vita. Va bene: io ti accolgo, ti do uno spazio, condivido degli strumenti perché tu poi possa costruirti la tua casa accanto alla mia e lo facciamo insieme”. Il senso è renderci conto che se anche trattassimo il sistema di accoglienza come se fosse solo un parcheggio di fatto non può esserlo, perché coabitiamo degli spazi, condividiamo una società, condividiamo delle pressioni e una prospettiva di futuro.
Consigli di ascolto da Natalie Norma Fella
Storia di A., sogni e battaglie di un minorenne migrante solo in Italia di Marco Stefanelli
TOTALE di Jonathan Zenti (in particolare l’episodio LAVORO TOTALE)
Fino all’ultimo respiro di Lorenzo Sangermano e Leonardo Pini
Teatri di guerra di Graziano Graziani ed Enrico Baraldi.
Inside Kabul di Caroline Gillet and Marwa and Raha (in lingua inglese)
Missing&Murdered di Connie Walker (in lingua inglese)
Photo credits
Copertina – Foto di Natalie Pedigo su Unsplash
