In Ohio a una bambina di dieci anni rimasta incinta da una violenza sessuale è stato negato l’aborto. Il fatto è successo tre giorni dopo che la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza Roe v. Wade, rendendo effettive le cosiddette trigger laws, leggi designate per limitare l’aborto nel momento in cui la Corte ne avrebbe decretato l’incostituzionalità. L’Ohio è uno degli Stati che hanno meglio preparato il terreno per il divieto d’aborto, stabilendo come termine ultimo per interrompere la gravidanza la presenza del battito fetale, che si può percepire intorno alle sei settimane. La legge non prevede eccezioni per lo stupro o l’incesto, ma solo per il grave pericolo di vita della donna. La bambina così ha dovuto spostarsi fino in Indiana per poter mettere fine alla gravidanza.
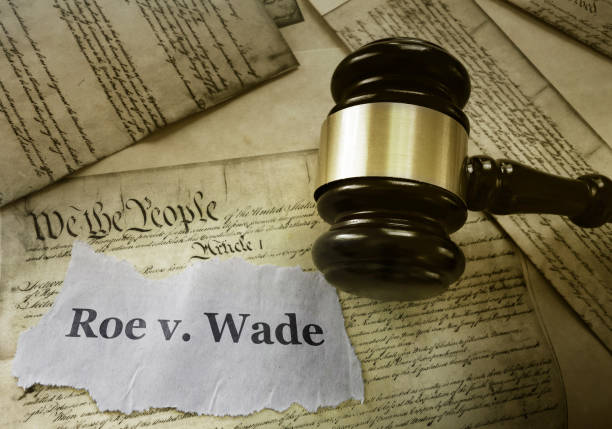
Non è il primo caso in cui l’insensatezza e l’ottusità del divieto d’aborto si scontra con la realtà dei fatti, anche se sentire questa storia provenire dagli Stati Uniti e non da qualche Paese in cui le donne sono prive dei diritti più basilari fa un certo effetto. Queste storie di vite spezzate, in cui al trauma si aggiunge altro trauma, sono importanti perché è difficile che lascino indifferenti. Escludendo i più intransigenti difensori del “diritto alla vita” – solo quella del feto, naturalmente – che hanno avuto il coraggio di dire che questa gravidanza era “un’opportunità” per la bambina, esiste una massa di persone, forse la stragrande maggioranza, che nei confronti dell’aborto ha un atteggiamento ambivalente. Non sono favorevoli (aggettivo comunque inadatto, è come dire di essere favorevoli a un trapianto), ma nemmeno contrari. Finché la cosa non li tocca, magari non si pongono nemmeno troppe domande. Di solito queste persone propendono per un diritto all’aborto condizionato: quando ci sono casi gravi, come quello della bambina dell’Ohio, l’interruzione di gravidanza è giustificata, anzi necessaria; ma per tutti gli altri resta qualcosa di brutto, di doloroso se non di sbagliato.
Nei giorni successivi alla sentenza della Corte suprema, abbiamo letto decine di commenti di questo tenore: la scelta è della donna, ma è sempre una scelta dolorosa. Non si può non pensare all’aborto come a una macchia indelebile, come l’evento – per dirla con Annie Ernaux – più determinante della vita della donna. Chi si è imbarcato in qualche discussione con gli antiabortisti in questi giorni, si è affidato proprio a quei casi estremi, sperando forse di suscitare nell’interlocutore una qualche empatia: bisogna pensare alle donne stuprate, alle vittime di incesto, alle minorenni, alle vittime di violenza domestica, a quelle che portano in grembo bambini con malformazioni gravissime, e così via. È vero e innegabile: queste donne sono quelle che soffriranno le conseguenze peggiori per un aborto negato e una gravidanza imposta. Ma non ci sono solo loro. Ci sono anche le donne che molto più semplicemente vogliono interrompere una gravidanza perché non sono pronte, perché non è il momento, perché di figli non ne vorranno mai. Perché la scelta è loro, insindacabile e libera.
Come spiega la psichiatra Alessandra Piontelli nel libro Il culto del feto, per la maggior parte della storia il feto è stato considerato come una specie di appendice del corpo della gestante. È solo con l’avvento dell’Illuminismo prima e della tecnologia diagnostica poi che il feto comincia ad assumere uno status di autonomia e si viene a configurare un vero e proprio conflitto tra donna e feto, in cui la prima viene considerata la responsabile dell’eventuale morte o malattia del secondo. Un ruolo determinante l’ha avuto lo scandalo della talidomide, un farmaco che negli anni Cinquanta veniva prescritto per combattere la nausea gravidica ma che causava importanti malformazioni fetali. Il farmaco fu ritirato nei 1961 dopo più di 10mila casi di focomelia, ma per la prima volta si stabilì una correlazione diretta tra un comportamento sbagliato della madre (sebbene consigliato da un medico) e una conseguenza negativa sulla gestazione. L’idea che la donna possa causare, volontariamente o indirettamente, la morte del feto in conseguenza alla sua condotta negativa prende sempre più piede, fino ad arrivare alla codificazione del reato di feticidio. Anche da prima del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade, negli Stati Uniti una donna corre il rischio di essere imprigionata se, ad esempio, fa uso di sostanze stupefacenti da incinta o se ha un aborto spontaneo in circostanze sospette.
È proprio in questo clima, in cui il feto assume culturalmente e giuridicamente le sembianze di una persona e la donna viene resa responsabile della sua integrità, che l’aborto comincia a essere considerato sempre più un omicidio. Prima a pensarlo erano solo i cattolici, appoggiando la posizione espressa da papa Pio IX nel 1869 secondo cui anche il feto ha un’anima. Poi quest’idea si è radicata anche fra i laici e fra i fedeli di altre confessioni, come i cristiani evangelici che sono diventati il cuore dell’antiabortismo americano. Si crea così una catena di colpa: non solo la donna è colpevole di uccidere un bambino, ma in prima istanza è colpevole di essere rimasta incinta.
Se un tempo la fertilità era un meccanismo abbastanza misterioso, oggi il fatto che vi siano maggiori conoscenze sull’argomento è un motivo in più per cui attribuire alla donna la colpa di essere rimasta incinta (sebbene sia ancora necessario l’intervento di un uomo, che in questi casi non è mai pervenuto). In molti commenti, anche non necessariamente contrari all’aborto, si sottolinea come nel 2022 una gravidanza indesiderata sia comunque inaccettabile, perché “ci si doveva pensare prima” o “bisognava stare più attente”. A differenza dei casi di violenza, in cui la gravidanza è un esito accidentale, nei casi “ordinari” di aborto c’è sempre un concorso di colpa della donna che avrebbe dovuto almeno prendere la pillola del giorno dopo, almeno usare i contraccettivi ma soprattutto almeno “chiudere le gambe”.
Ma al di là di tutte le sovrastrutture ideologiche che possiamo inventarci, l’aborto resta un’esperienza incarnata, esattamente come il sesso. Non c’è una storia standard di come si incorre né di come si interrompe una gravidanza: nella maggior parte dei casi accade e basta, per sfiga, ma anche per distrazione, disattenzione e ignoranza. Per tutte quelle cose che succedono nelle nostre vite e che non sempre riusciamo ad avere sotto controllo. Tutte queste storie sono valide così come validi sono i motivi per non voler proseguire la gestazione. Come giudicheremmo un medico che si rifiuta di curare un paziente con un cancro ai polmoni perché quella persona fuma tre pacchetti di sigarette al giorno? Tutte le persone hanno diritto a ricevere un trattamento sanitario a prescindere dal loro comportamento, e questo vale anche per l’aborto.
I casi estremi come quello dell’Ohio ci ricordano a quale livello di violenza possono arrivare leggi che hanno la pretesa di salvare vite. Ma non dobbiamo dimenticarci della realtà e della normalità dell’aborto: se non siamo disposti a lottare per quello, se di fronte a un diritto negato la prima cosa a cui pensiamo è che quella persona non doveva cacciarsi in quella situazione, allora non siamo davvero a favore dell’aborto. La legge 194/78, per quanto imperfetta e ormai obsoleta, un merito ce l’ha: quello di non porre condizioni – se non quelle terapeutiche – alle ragioni per cui si ricorre all’interruzione di gravidanza. Come si è visto negli Stati Uniti, i diritti delle donne sono fragili. Per questo è importante saperli maneggiare, anche se siamo convinti di stare già dalla loro parte.
Illustrazione di copertina di Rebecca Fritsche
Immagini nel testo tratte da iStock
