Nel maggio dello scorso anno ero ai Dialoghi di Pistoia, seduto a un tavolo in una meravigliosa piazza del centro a sorseggiare un vino con Anna Gilardi e visto che non sentivo Marc Augé da più di due anni le ho chiesto se lo avesse sentito recentemente, visto che sapevo bene della loro amicizia ventennale. Purtroppo anche lei non lo sentiva da parecchi mesi e entrambi ci siamo salutati dicendoci che al più presto gli avremmo scritto per sapere come andavano le cose a Parigi e se la sua salute fosse migliorata.
Ho avuto la fortuna di conoscere Marc nel per me lontano 2008, quando iniziai a lavorare nella casa editrice milanese Elèuthera, che tra i tanti libri dell’antropologo francese, grazie al sesto senso di uno dei fondatori della casa editrice, Amedeo Bertolo, era stato pubblicato nel 1993 quello che diventerà il celebre libro Nonluoghi. Sappiamo tutti e tutte che i nonluoghi sono quegli spazi dell’anonimato sempre più numerosi e frequentati in tutto il mondo (aeroporti, supermercati, stazioni, centri commerciali e via dicendo); oggi è scontato ma dobbiamo ricordarci che sono stati codificati per la prima volta trent’anni fa, proprio da Marc Augé, in maniera così geniale da essere entrati nel nostro linguaggio e nel modo di descrivere le nostre esistenze.
Molto spesso il concetto esposto da Augé viene banalizzato o criticato senza aver compreso bene la sua teorizzazione sui luoghi e i nonluoghi. Per questo riporto una sua precisazione, presente nella nuova prefazione che scrisse per i vent’anni dall’uscita del libro:
«Bisogna ricordare che non esistono dei nonluoghi nel senso assoluto del termine. Ho definito ‘luogo antropologico’ ogni spazio in cui è possibile leggere delle iscrizioni del legame sociale (ad esempio quando vengono imposte a tutti regole rigide di residenza) e della storia collettiva (per esempio nei luoghi di culto). Tali iscrizioni sono chiaramente più rare negli spazi marchiati dal sigillo dell’effimero e del passaggio. E tuttavia nella realtà non esistono, nel senso assoluto del termine, né luoghi né nonluoghi. La coppia luogo/nonluogo è uno strumento di misura del grado di socialità e di simbolizzazione di un dato spazio».

Nel 2008 stavo finendo la mia specializzazione in antropologia all’università di Genova ed ero ovviamente entusiasta di avere il privilegio di lavorare sui suoi nuovi libri, e la mia prima esperienza fu l’anno successivo con un bel testo dal titolo Che fine ha fatto il futuro?, edito da Elèuthera. Dal 2012 però il mio rapporto con Augé diventa più interessante e profondo, perché per il ventennale dall’uscita dei Nonluoghi ho la fortuna di introdurlo in un ciclo di conferenze in Italia e questo mi porta inevitabilmente a conoscerlo meglio e a capire che oltre ad essere un grande antropologo era una persona modesta, capace di ascoltare e dare i giusti consigli – che per un giovane antropologo come me erano veramente fondamentali.
Tra i tanti momenti passati insieme in festival e fiere del libro non dimenticherò mai la mattina del 6 giugno del 2012 a Milano; ho il compito di andarlo a prendere in macchina, accompagnarlo in hotel e poi portarlo a mangiare e bere un bicchiere di vino in una buona osteria milanese. La conferenza con Giulio Giorello e Marco Aime è programmata alla NABA nel quartiere ticinese nel tardo pomeriggio, abbiamo tempo. Così decidiamo insieme a Marc di fare un giro a piedi dopo aver parcheggiato la macchina: voleva che gli raccontassi quel vecchio quartiere milanese, la sua storia e i suoi cambiamenti, la sua turistificazione e il relativo processo di ‘gentrification’. Dopo una passeggiata di un’ora approdiamo alla storica osteria la Madonnina: appena entra, Marc è entusiasta e mi guarda negli occhi con un sorriso: «Grazie Andrea, questo sì che è un luogo!».

Per scrivere questo mio ricordo molto personale di Marc sono andato a ripescare i miei taccuini, ogni volta che passavo delle giornate con lui prendevo appunti. Che si trattasse di un pranzo, una cena, una fiera o una passeggiata, erano sempre momenti importanti di confronto, anzi più che altro di ascolto di un grande antropologo noto soprattutto per i Nonluoghi ma autore di testi fondamentali per la formazione di tante antropologhe e tanti antropologi come Il dio oggetto (mimesis), L’antropologo e il mondo globale (Cortina), Il senso degli altri (Bollati Boringhieri), giusto per citare i principali lavori.
Un libro al quale sono molto legato è Le forme dell’oblio (Saggiatore). Tra le pagine Augé analizza le funzioni culturali dell’oblio e le sue diverse forme di ritualizzazione, poiché l’oblio è strettamente correlato al ricordo ed è altrettanto necessario per l’identità sociale e personale. Ricordare e dimenticare hanno un rapporto di interdipendenza simile a quello tra la vita e la morte: per vivere, sia l’individuo che la società devono poter dimenticare alcune esperienze passate.
Analisi e riflessioni quanto mai attuali in questi tempi di cambiamenti e mutazioni nell’identità e nella mobilità delle persone, tempi di nuove politiche e modi di fare politica. In questo testo del 2000, l’antropologo francese combina le questioni della transculturalità con approcci cognitivi, semantici ed etici. Augé ci parla del dovere di ricordare per le generazioni successive, mentre ci sarebbe un dovere di dimenticare per coloro che hanno subìto certi orrori, la cui presentificazione permetterebbe loro a malapena di vivere:
«Una certa ambiguità è legata all’espressione ‘dovere di memoria storica’ così frequentemente utilizzata oggi. In primo luogo, sono soggetti a tale dovere evidentemente coloro che non sono stati testimoni diretti o vittime degli avvenimenti che questa memoria deve conservare. È chiaro che i sopravvissuti all’Olocausto o all’orrore dei campi di concentramento non hanno bisogno che gli venga ricordato questo dovere. Anzi, al contrario, il loro dovere ha saputo sopravvivere alla memoria, sfuggire, per loro, alla presenza costante di un’esperienza incomunicabile. Da bambino ero colpito dalla riluttanza di mio nonno a evocare la vita in trincea, e mi sembrava di poter riconoscere nei ricordi conservati dai sopravvissuti ai campi di sterminio, il lungo intervallo che coloro che finalmente hanno scelto di evocare ciò che avevano vissuto, la traccia della stessa convinzione: che chi non è stato vittima dell’orrore non può immaginarlo, per quanta volontà e compassione eserciti; ma anche che chi l’ha subito, se vuole rinascere e non solo sopravvivere, deve saper fare spazio all’oblio, abbrutirsi, in senso pascaliano, per ritrovare fiducia nella quotidianità e controllo del proprio tempo».
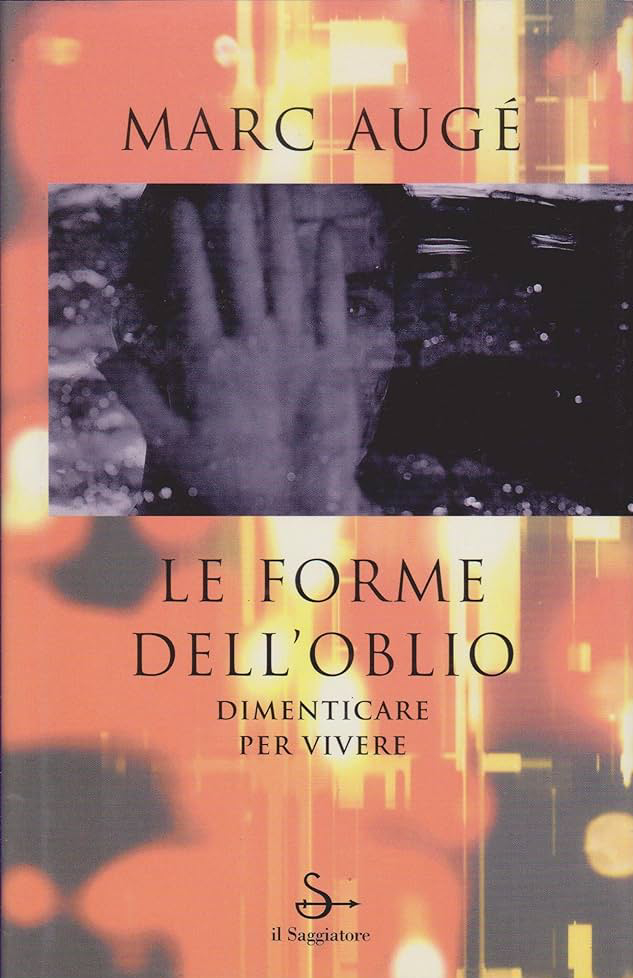
Per concludere questo mio ricordo, voglio riportare una conversazione-intervista che ho avuto con Marc nel 2015, durante la prima edizione di BookPride a Milano ai Frigoriferi Milanesi dove ho condiviso con lui, Marco Aime e Franco Farinelli una conferenza dal titolo Antropologia della differenza e umane geografie. Tra le domande che ho posto a Marc, una gli chiedeva perché trovasse importante che l’antropologia non si occupi soltanto di popoli lontani ma anche delle ‘nostre’ società. La sua risposta fu chiarificatrice:
«È importante perché viviamo in un mondo che si muove, e questo vale tanto per le società cosiddette ‘tradizionali’ quanto per l’Occidente moderno. Questo movimento sovverte le vecchie distinzioni e non permette più di distinguere fra differenti tipi di studio e di sguardo. È sempre stato così, ma lo è sempre di più».
Mi chiedevo, e mi chiedo spesso, se l’antropologia possa aiutarci realmente a capire il complesso mondo contemporaneo e soprattutto se possa trovare risposte possibili per muoverci meglio e con più consapevolezza nella società. L’antropologia non propone soluzioni particolari, ma al contrario, proprio grazie al fatto di porre continuamente domande, ci aiuta a indagare, con angolazioni diverse, il nostro presente. Una puntualizzazione importante che mi fece su questa visione fu: «Sì, ma precisamente analizzando quello che si muove e criticando le categorie create dalla prima etnologia: cultura, tradizione, comunità, e via dicendo».
Le angolazioni diverse sono centrali per noi antropologi, il mondo è scosso da quello che la stampa chiama, dal mio punto di vista erroneamente, uno scontro di civiltà, o di religioni. Chiesi a Marc se ci potesse aiutare a fare chiarezza nella confusione creata dai media e la sua risposta fu tranchant: «A mio avviso viviamo oggi le ultime convulsioni (ma può anche durare a lungo!) della forma più totalitaria del senso sociale: la religione».
Ma come uscirne, allora? Osservavo questo Maestro, il suo pensiero si muoveva in continuazione, insieme al gesticolare delle mani e al movimento vivace degli occhi. Gli chiesi: «Marc, però gli sguardi altri possono essere un tentativo di condividere alcune possibili letture dei punti di rottura che segnano la nostra società, e quindi di trovare soluzioni condivise?» La sua risposta fu, come sempre, significativa:
«È complicato, Andrea: infatti, oggi più che mai, è difficile postulare l’esistenza di sguardi culturali differenti e coerenti. Penso che l’analisi critica possa essere feconda solo concentrandosi sulle tre dimensioni dell’essere umano: individuale, culturale e generica. Essa deve chiedersi come conciliare il ‘senso’ sociale (la necessità della relazione con l’altro) e la libertà dell’individuo».
Senso sociale e libertà dell’individuo: Augé aveva visto in grande anticipo le tensioni che si stanno affacciando sul mondo oggi, dall’Ucraina a Gaza, passando per l’Africa sub-sahariana che ben conosceva. Mi sembra di poter dire che proprio in questo risiede la grandezza di un pensatore che ha sempre saputo leggere la società e i suoi meccanismi, anticipandone le tensioni e guardando sempre al futuro con speranza.
Uno sguardo, quello di Marc, che anche dopo la sua scomparsa continua ad essere attraversato da quello stesso sorriso che gli vidi in volto quel lontano giorno nella trattoria milanese, mentre i suoi occhi avevano finalmente visto ‘un luogo’.
Immagine: foto bella di Marc Augé
