Sono uscito dal corpo di mia madre nel maggio del 1967 e in tutto il mondo usciva Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles, mentre a San Francisco in perfetta sintonia esplodeva la psichedelica Summer of Love. Sotto lo sguardo sempre attento di Lawrence Ferlinghetti, già responsabile dell’antecedente “San Francisco Renaissance” (insieme a Gary Snyder, Philip Lamantia ed altri), stava esplodendo una vera rivoluzione culturale. La “generazione giovane” chiedeva di essere ascoltata e reclamava i propri diritti. Dall’ingresso della sua libreria-casa editrice City Lights Books (nome preso in prestito dal celebre film di Chaplin, col suo personale permesso), il coraggioso editore benediceva la transizione della Beat Generation in qualcosa di nuovo. La Beat, anche se disciolta nei 60’s, avrebbe profondamente influenzato il nascituro movimento di protesta. Certamente condividevano molti temi comuni e tutto confluiva nella nuova ondata hippy. In questa trasformazione verso la cultura underground, i concetti a lui tanto cari come pace, amore, libertà e uguaglianza erano diventati le parole chiave di un’intera generazione.
Tornando a me, qualcuno potrebbe legittimamente pensare che sia solo una coincidenza, ma io penso che quell’energia cosmica, quel flusso ormai diventato un’onda globale che stava contagiando il mondo intero, fosse arrivato fino alla clinica di Brescia dove senza troppi complimenti mi stavano scodellando al mondo e avrebbe dato un imprinting al mio carattere, influenzando il mio percorso umano e artistico, come ho scritto nella mia autobiografia Angelo ribelle edita da La nave di Teseo. Nasceva così la controcultura e il buon Lawrence, particolarmente attento alle evoluzioni della società fino ai suoi ultimi giorni, usava accompagnare col suo sguardo benevolo anche questa ondata di giovani, che mettevano fiori nei fucili dei militari e si opponevano fermamente alla guerra in Vietnam. Una generazione sfiorata dalla Beat Generation e dai suoi scrittori, che Ferlinghetti impavido ospitava e pubblicava e che gli valsero addirittura un arresto nel 1956, per aver pubblicato Howl di Allen Ginsberg, il grido dei Beat.
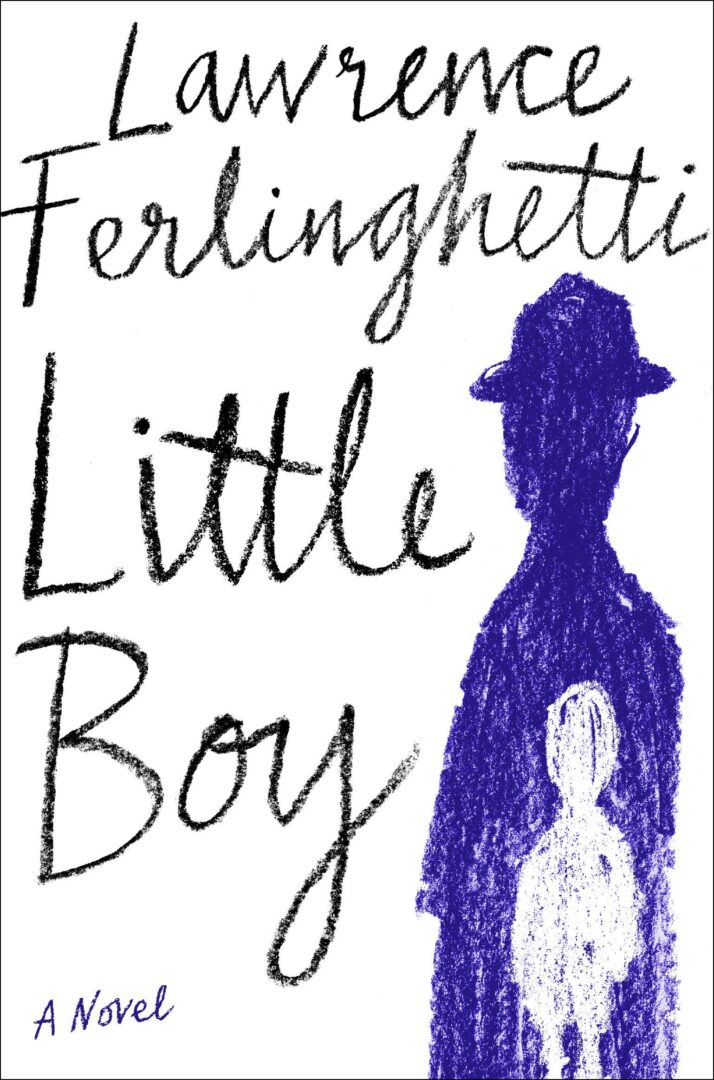
I primi sintomi di questo benevolo virus si manifestarono in me nel 1996 quando, all’apice del successo con i Timoria, decisi tra lo stupore generale di prendermi una pausa dalla band per pubblicare un lavoro solista. Era un’urgenza profonda, avevo l’intenzione di dedicarmi ai “miei americani”, quelli per intenderci da Hemingway in poi, arrivati a noi grazie al lavoro appassionato di Fernanda Pivano (santa subito!). L’urgenza creativa scaturì in me nell’apprendere la notizia della morte per overdose di River Phoenix, un giovane attore che mi aveva molto ispirato in quegli anni, e così nacquero, nelle tre settimane più tossiche e alcoliche della mia vita, le session che diventarono lo stralunato disco Beatnik, il mio primo album solista. Leggendo alcune fonti per le ricerche delle liriche appresi, improvvisamente illuminato, che Ferlinghetti aveva probabilmente origini bresciane. Come paese natale della famiglia Ferlinghetti alcuni indicavano la città di Chiari (che ha dato i natali anche al mio caro amico Mauro Pagani). Un altro segno del destino? In ogni caso quelle sono le prime tracce lasciate dal “furbo bresciano”, come Ferlinghetti Jr. definiva il padre Carlo, morto prima della sua nascita, che nel 1894 aveva rocambolescamente cambiato il cognome in Ferling al momento di imbarcarsi nella traversata atlantica, così da nascondere le evidenti origini italiane che avrebbero potuto attirare qualche antipatia e non pochi pregiudizi al momento dello sbarco in America (la fonte è Giada Diano, nel volume Io sono come Omero, edito da Feltrinelli). Sarà Lawrence stesso a riprendersi il cognome originario in età adulta.
Fu così che l’anno successivo recitai una sua poesia nel disco Eta Beta dei Timoria, “orchestrato” da Pino Pinaxa Pischetola, riportando un po’ in auge la vecchia abitudine beat di proporre dei reading letterari anche durante i concerti. Fu nel 2001 che, grazie all’aiuto di un grande uomo di cultura, il compianto Antonio Bertoli (che fu anche poeta, attore e performer), che aveva da pochi anni inaugurato a Firenze la prima libreria City Lights, ottenni il primo contatto epistolare con Lawrence, per chiedergli se avesse voglia di leggere una sua poesia in un disco dei Timoria. Con mio sommo stupore ne fu entusiasta, e in meno di un mese ricevemmo in sala prove un nastro con la sua voce che declamava uno dei suoi capolavori, What Is Poetry. Fu un’emozione indescrivibile. E non volle un dollaro. Stavo forse sognando? La nostra musica con la sua voce: toccavo il cielo con un dito. Per dirla con Joyce, fu un’epifania.
La intitolai Ferlinghetti Blues, e la incidemmo nel disco El Topo Grand Hotel. Fu allora che incontrammo uno dei personaggi più colti (e bizzarri) che io abbia mai incontrato: si trattava di Francesco Conz, agitatore culturale veronese, figura di spicco del movimento Fluxus e grande amico e sodale del poeta italoamericano. Quando io ed Enrico Ghedi arrivammo in leggero ritardo a Verona per conoscerlo, Conz ci aspettò indispettito nascosto dietro la finestra di casa sua al primo piano e, al nostro arrivo, pensò bene di bersagliarci con oggetti contundenti di ogni tipo, tra cui un vaso di fiori che mi mancò di poco. Un artista vero e spontaneo del quale, inutile dirlo, ci innamorammo subito. Fu nel 2002, mentre il nostro disco era già un successo trascinato nelle radio dal singolo Sole spento, che il Conz, aiutato dall’amico fotografo bresciano Walter Pescara (al quale va il merito di aver seguito e immortalato spesso Ferlinghetti e di essersi guadagnato la sua amicizia) e da qualche volonteroso amico, ci invitò a partecipare a una performance Fluxus a Brescia, dove in quegli anni organizzavo una tre giorni di contaminazioni artistiche chiamata Brescia Music Art. Dal palco, mentre Lawrence dipingeva su tela la declinazione del verbo fluxare, avrei suonato il piano e la chitarra per creare una colonna sonora improvvisando col maestro Ghedi, il poeta Igor Costanzo e Conz stesso. Avevamo a disposizione dei pianoforti scordati che facevano parte dell’immensa collezione del nostro nuovo amico veronese, che sarebbero stati poi dipinti da Ferlinghetti. Fu un vero e proprio happening: il teatro era stracolmo, Brescia poté tributare un saluto affettuoso al suo celebre figlio (in realtà nipote) ed io, come in uno stato di trance, stentavo a credere che stesse accadendo veramente. Lawrence aveva già 82 anni ma mi colpì particolarmente per la sua energia e il suo dolcissimo sorriso. E poi, quegli occhi che avevano visto così tante cose…

Dopo quella performance capii immediatamente che Lawrence aveva in cuor suo una missione importante: cercare le sue radici italiane. «Cerco il mio vecchio, che non ho mai conosciuto», ci disse. Tornò puntuale anni dopo per scoprire con grande emozione la casa del padre, che fu individuata grazie a un lavoro certosino dei discendenti di Chiari e dell’artista G. Morandini, fortunatamente impiegato all’anagrafe, che trovò l’atto di nascita di Carlo Ferlinghetti nella città della leonessa d’Italia, in pieno centro storico, contrada delle Cossere.
Lui, il grande editore-poeta, era felice come un bambino. Il viaggio omerico era finalmente giunto alla sua Itaca. Da quel primo incontro presi contatto con lui e lo risentii in varie occasioni, come quando nell’estate del 2012 gli fu dedicata una giornata a Rocca Imperiale (nell’alto Ionio cosentino), il “paese della poesia”, con una mostra di suoi quadri. In quell’occasione, nel castello di probabili origini federiciane, suonammo, cantammo, recitammo e chiacchierammo. C’era con noi l’editore Giuseppe Aletti, che organizzava la serata e che in seguito pubblicherà un bellissimo libro-catalogo. A un certo punto, sul grande schermo montato per l’occasione, apparve lui in collegamento Skype. Che ammirazione vederlo, ultranovantenne, usare con dimestichezza le nuove tecnologie. Fu proprio allora che pensammo di chiedergli come avesse fatto a sopravvivere agli eccessi della Beat Generation e ad essere ancora così in forma alla sua età. Rispose: «Accudivo i miei amici scrittori e li pubblicavo, stavo con loro anche qualche notte e mi divertivo, ma non eccedevo in nulla, perché al mattino presto toccava a me alzare la saracinesca e vendere i libri, mentre gli altri dormivano sul divano». Scoppiò un grande applauso. A intervistarlo con noi c’era Giada Diano, scrittrice calabrese, sua biografa e amica intima: parlammo della mostra, gli dedicai un paio di canzoni, ci soffermammo sul significato dei suoi dipinti, ispirati alla figura di Ulisse.
Continuo a pensare a quel collegamento, alla sua forza. Il pubblico fremeva, e a un certo punto Lawrence fece la sua apparizione indossando una maschera carnevalesca, con il volto della Statua della Libertà. Dopo un attimo di disorientamento, notammo che pareva divertirsi un sacco: sembrava un bambino, un bambino di novantadue anni. Pensai allora che probabilmente quella leggerezza dovesse essere uno dei suoi segreti per vivere così a lungo e con quella serenità che ci stava mostrando, e mi venne in mente il suo motto ricorrente, che del resto recitava così: «Mangia bene, ridi spesso, ama molto».
“Little Boy”, così lo chiamavano tutti, restò coerente a se stesso fino all’ultimo istante della sua vita. Quella sera ci raccontò molte cose sui libri, sulla poesia e sulla pittura, ma ciò che più mi colpì fu l’immenso uomo di cultura dotato di grande umiltà e che sapeva prendersi in giro, proprio un gran burlone. Nel 2015 ripetemmo l’esperimento e lui recitò una sua poesia-manifesto nel mio nuovo disco Che ci vado a fare a Londra?, pubblicato dalla Universal. Si trattava della fantastica Poetry as Insurgent Art, tra i cui frammenti cita i miei tre poeti preferiti di sempre: Pier Paolo Pasolini (fu proprio lui a tradurlo e pubblicarlo in America), Pablo Neruda (avete capito perché mio figlio si chiama Pablo?) e Vladimir Majakovskij (che ho portato a teatro nelle mie tournée letterarie). Coincidenze? Non ci credo.

Di lì a poco, purtroppo, il mio cuore malandrino mi ha giocato uno dei suoi soliti scherzi e sono stato costretto a un nuovo intervento chirurgico. Cercavo di farmi forza, ma mi sentivo demoralizzato mentre giacevo nel lettino attendendo l’anestesia. Fui improvvisamente destato dal suono di una mail e lanciai un’occhiata al telefono (che poteva, chi lo sa, essere l’ultima), quando scoprii d’aver ricevuto un nuovo messaggio. Era Lawrence. Giada lo aveva avvisato del mio incidente di percorso, e lui aveva voluto scrivermi due righe di conforto che non dimenticherò mai: «Caro Omar, ti sono vicino. Sappi che ho affrontato da pochi anni un intervento al cuore e sono ancora vivo: se ce l’ho fatta io alla mia età, sono sicuro che ce la farai anche tu». Chiesi un minuto in più, al chirurgo e a Dio, per rispondere. Il permesso mi fu accordato e digitai, un po’ tremante: «Grazie maestro, ma sappi che se non dovesse andare bene, il solo ricevere un tuo scritto indirizzato a me rende questo momento magico e indimenticabile. E ne sarà valsa la pena».
Naturalmente, come sempre, aveva ragione lui. Me la sfangai anche quella volta. Nel 2016 ricevetti una chiamata a un orario insolito da parte di Giada, che nel frattempo era diventata mia grande amica. Mi chiamava da San Francisco mentre era in compagnia di Lawrence, che mi spiegava di aver scritto una poesia con un cantante country che sembrava una canzone ma aveva bisogno di più musica. Naturalmente mi offrii e così nacque Desperation Horse, pubblicato nel disco Come se non ci fosse un domani nel 2017, proprio l’anno dell’elezione alla Casa Bianca di quel Donald Trump che riaccese in lui la miccia del combattente rivoluzionario, mai veramente sopita. Poche settimane dopo l’elezione ricevetti una mail che aveva inviato probabilmente a tutti i suoi contatti. Suonava più o meno così: «Trump sta inserendo i militari nel suo nuovo governo. Vi ricordo che è la prima mossa che deve fare un presidente quando è fascista».
Capii che quella reazione rifletteva un altro suo segreto di lunga vita, il segreto di chi vive le proprie passioni e i propri credo, difendendo sempre le proprie idee, fino alla fine, fino in fondo. Così, ammirandolo per quell’impetuoso impegno civile e politico nonostante l’avanzare dell’età, interessarsi alle cose comuni non può che insegnarci qualcosa di importante nel sintonizzarci tutti sulle frequenze delle nostre vite. È così che, grazie a Lawrence, ho imparato che si può morire giovani anche a centouno anni.
