Prologo
Torino è una città misteriosa; misteriosa e indolente. Tale indolenza la si può avvertire dappertutto; nei caffè storici del centro, nelle piazze spesso deserte; deserti circondati da portici, lunghissimi portici con centinaia, migliaia di persone che vi si incamminano in silenzio come a una processione; tuttavia è sui mezzi pubblici che la tocchi con mano, quell’indolenza allo stesso tempo metropolitana e metafisica. Un autobus a Torino non è un modo per spostarsi da un punto all’altro del mondo, no, è un mondo che racchiude tutti gli interrogativi fondamentali dell’esistenza e che spesso, non sempre, ritrovi nei libri: vivere, amare, soffrire.
Seduto in un 68 assai affollato, concentrato nella lettura del Corso di filosofia in sei ore e un quarto di Witold Gombrowicz (Bompiani), preparavo le ultime battute del mio corso al Liceo francese quando è avvenuto il fatto seguente.
A bordo due passeggeri di una cinquantina d’anni, una signora e un signore, in piedi una di fronte all’altro; alla fermata con conseguente liberazione di un posto a sedere, alla portata di entrambi, dopo averne costatato la cosa, si sono guardati dritti negli occhi per pochi istanti, prima che l’un# dei due passeggeri rivolgesse un cenno all’altr# per cedere l’ambita seduta. Fin qui nulla di particolarmente significativo: un segno forse di cavalleria d’altri tempi che nulla toglierebbe alla mala educación seppur aggiungendovi un seme di speranza quanto ai tempi che corrono; di questo certo si sarebbe trattato se a cedere il posto fosse stato l’uomo e non la donna come invece era stato il caso. La questione, in realtà, non era affatto di genere ma di numero, degli anni, una questione d’anagrafe, risolta dalla risolutezza e prontezza della donna che pur appartenendo alla stessa classe, dichiarava il suo interlocutore più anziano di lei, attestazione che sarebbe stata confermata da lui se avesse accettato l’invito; le cose però non sarebbero affatto andate in quel modo, dal momento che l’uomo aveva declinato con aria stizzita l’invito, con un’espressione del volto che avremmo potuto tradurre con la frase: ma ti sei vista allo specchio, vecchia stronza!
Ho allora distolto lo sguardo che, prima di immergersi nella lettura del Gombro, ha potuto per qualche istante, grazie alle potenti lenti da lettura che inforcavo, scorgere sul finestrino l’immagine riflessa della mia faccia che portava evidenti segni di appartenenza alla leva calcistica dei due passeggeri. In altre parole, vi avevo scorto chiara e distinta la mia età. Il primo riflesso era stato quello di togliere gli occhiali come la cosa bastasse a fare sparire il dolore; quel dolore che accompagna il guado da una riva abitata da chi deve cedere il posto all’altra in cui dimorano quanti a quel posto hanno diritto.
La seconda cosa che ho fatto è stata di rimetterli per riaprire il libro. Ed è così che mi sono imbattuto nella frase d’ouverture:
«Il vero realismo di fronte alla vita è sapere che la cosa concreta, la vera realtà, è il dolore.»
Le trompe-l’œil: un paio di occhiali
Si parla sempre di Anna Maria Ortese come di un autore realista; dal suo esordio, ufficialmente nel ’37, con Angelici dolori pubblicato dall’editore Bompiani. Dolore, una parola che non solo nei titoli adottati come nel caso del Cardillo addolorato, permea l’intera sua opera, da Il mare non bagna Napoli, fino a L’iguana, ma ne orienta le storie al punto di costituirne il tema maggiore, la cosa concreta.
Il realismo di Anna Maria Ortese,eppure, lo si potrà cogliere solo a condizione di esplorarne il pensiero che è alla base della narrazione, la portata filosofica delle storie.
È solo allora che la realtà, la dolente realtà diventa concepibile razionalmente, ovvero trasmutata nelle sue variazioni fantastiche; il realismo romanesque come trasfigurato dal dolore assume i tratti del racconto filosofico. Se nel caso di Gombrowicz si tratta di una scelta stilistica annunciata, come quando scrive che «Ferdydurke è una parodia del racconto filosofico alla Voltaire», in Anna Maria Ortese questo accade in modo naturale, attraverso le forme del racconto breve, gli apologhi, le riflessioni filosofiche poste a corollario delle vicende vissute dai suoi personaggi e condivise dall’io narrante con i lettori. È attraverso la cognizione del dolore che l’opera accede ai sensi più reconditi dell’esistenza, della vita pura e nuda, concreta, e se per Gombrowicz sarà possibile grazie a una vera e propria fede filosofica, in Anna Maria Ortese, autodidatta, tale traduzione è guidata da un naturalismo di tipo panico.
Di sé scrive nel magnifico Autodizionario degli scrittori italiani, a cura di Felice Piemontese e pubblicato da Leonardo nel 1990:
«Motivazioni profonde non ne trova: se non lo scontento, del resto comune, e spesso l’indignazione, davanti a ciò che si chiama “reale”. E questo sentimento – che resta – le impedisce adesso di preoccuparsi se qualche futuro lettore potrà farsi di lei un’immagine più o meno vicino alla “realtà”. Di “realtà” – uno che sia in polemica eterna col reale – non può averne. Difficile soprattutto dal di dentro, capire chi sia veramente, o che voglia, uno che non accetta – non ama – quanto è “reale”. Anna Maria Ortese non sa cosa ha voluto, né chi è.»
Tale rivolta al reale trova il manifesto in uno dei suoi racconti più belli, Un paio d’occhiali, che apre Il mare non bagna Napoli. Eugenia è una ragazzina ipovedente, quasi cecata, che rischia di perdere la vista per sempre se non ottiene quei due pezzi di vetro che sua zia Nunzia ha deciso di regalarle. Eppure, prima che ciò avvenga la vediamo spensierata percorrere timidamente ogni gesto di un’infanzia che sembrerebbe felice, non pervasa dal male, dalle passioni tristi che ne determinano tutt’intorno il paesaggio: i soldi, i tradimenti, le prese in giro. Queste cose Eugenia non le sente perché non le vede ed esprime in una lingua imperfetta e vitale tutta l’energia della propria innocenza, l’adesione a una realtà ben distante dalla verità. È solo verso la fine, nel gran giorno, quando sua madre rincasa con un paio d’occhiali, che la metamorfosi avrà luogo; il volto della piccola si trasforma in una «una specie d’insetto lucentissimo, con due occhi grandi grandi e due antenne ricurve». La realtà è un pugno in faccia, uno schiaffo di rara violenza, e il dolore un non so che di nitido e cristallino che sgorga dalla visione dell’inferno.
«Come un imbuto viscido il cortile, con la punta verso il cielo e i muri lebbrosi fitti di miserabili balconi; …le foglie di cavolo, i pezzi di carta, i rifiuti, e, in mezzo al cortile, quel gruppo di cristiani cenciosi e deformi, coi visi butterati dalla miseria e dalla rassegnazione, che la guardavano amorosamente. Cominciarono a torcersi, a confondersi, a ingigantire. Le venivano tutti addosso, gridando, nei due cerchietti stregati degli occhiali.»
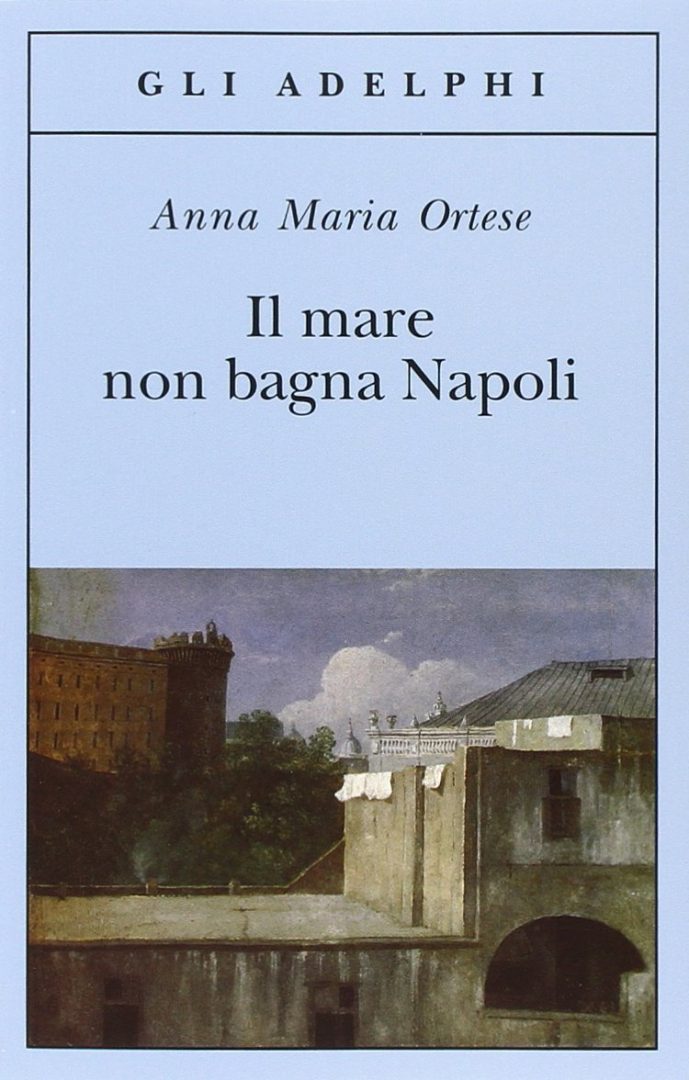
Twitter (cinguettìo)
I due passeggeri sono scesi da un pezzo. Il posto è rimasto vuoto. In questo lungo viale defilato dal centro si sente nitido e chiaro il canto degli uccelli. Richiudo il libro di Gombro e in maniera inaspettata ho come una rivelazione. C’è un legame strettissimo che non avevo mai colto fino ad allora tra il racconto appena evocato e il romanzo Il cardillo addolorato, sempre di Anna Maria Ortese. Il piccolo volatile, da vivo e da morto, tormenta il destino della protagonista, Elmina. Ora si sa che il cardillo canta meglio se accecato; per poterlo vendere al miglior prezzo taluni commercianti li fanno crescere al buio dopo averne bruciato le pupille con aghi roventi. Ecco che solo dopo aver dato alla vita un’altra forma, la si potrà cantare; solo una visione obnubilata o distorta potrà far cedere al falso che è misura e supporto della verità. Proprio quello che succede in una delle scene del romanzo, quando, riuniti alla Reggia di Caserta grazie a un potente cannocchiale, si riuscirà a scorgere l’interno misero di una casa del Pallonetto e scrutare l’inconfessabile segreto di Elmina. Quale sarà allora la relazione tra bellezza e cecità, tra il male che si subisce e quello che si compie, ma soprattutto il posto che il dolore occupa in tutto questo. Un canto d’uccelli è quel che rimane dopo il diluvio. Non si tratta di un’ennesima prova di rinascita ma di sopravvivenza pura e dura. C’è una necessità dolente nel canto degli uccelli che devono costruirsi un nido lontano da terra.
Cahiers des doléances
C’è un racconto poco noto di Anna Maria Ortese che amo particolarmente. S’intitola Dolente splendore del vicolo, pubblicato in due parti da Pasquale Prunas sulla rivista Sud nel giugno del ‘46 e nel gennaio dell’anno seguente. Sud è la rivista che ho la fortuna di dirigere, in una nuova versione, dal 2003, grazie alla presenza di antichi collaboratori della stessa come Antonio Ghirelli, Carla De Riso, Francesco Rosi, alla partecipazione come partner europeo della rivista francese l’Atelier d Roman, guidata da Lakis Proguidis, e la fondamentale adesione di Renata Prunas, sorella di Pasquale e memoria storica di quella straordinaria stagione del dopoguerra, la giornalista Nora Puntillo e Giuseppe Catenacci, presidente dell’Associazione ex allievi della Nunziatella, la scuola militare di Montedidio tra le cui rosse mura la rivista era nata nel ‘45.
Il racconto dal titolo che racchiude l’ossimoro, di fatto, del dolente splendore, ci fornisce una chiave di quella stretta relazione tra opera e dolore da cui siamo partiti. Un tema che unito alla riflessione sul bene e sul male di Anna Maria Ortese ne costituisce il suo canto più autentico e disperato.
Dolente splendore del vicolo presenta una messa a nudo della mutazione antropologica del vico; la guerra ha strappato gli abitanti dalla loro infantile innocenza, sia nel linguaggio ormai contaminato dall’inglese di liberatori e occupanti, sia nell’universo delle relazioni condannato dalla spietata ricerca di soldi, tanto per i poveri che per i più ricchi.
Questa mutazione è percepita dalla narrante attraverso l’assenza del canto: certo le persone non si parlano più ma, cosa ben peggiore, nessuno canta più. Eugenio Santillo, un piccolo delinquente e sua sorella sono i soli a resistere al frastuono del vicolo, alla mostruosità delle voci di quei miserabili. È il racconto di un dolore, di una giovane madre per la perdita del figlio, una processione infinita di Madonne toccate e accarezzate dalle puttane del quartiere, pronte a coprire di soldi la statua in cambio di un perdono. Nel finale, Anna Maria Ortese descrive l’irruzione, nel silenzio affamato del vicolo, di un’allegra brigata di giovani ubriachi e fintamente felici:
«a notte, quando già molte finestre si erano spente sulla vergogna o la solitudine delle anime, gruppi di giovani tra la vecchia e la nuova generazione, sazi e tuttavia inquieti, svegliavano il quartiere con una serie di canti che dovevano evocare la città di un tempo e dire la bellezza dell’amore puro. […] loro gridi scivolavano su muraglie cieche d’apatia, cadevano in pozzi di desolazione».
È quella felicità il male; l’inferno è l’indolenza, l’apatia, l’indifferenza. La vita senza aggettivi.
Le trompe-l’œil:un paio di calzini
In francese esiste un verbo antico per dire dolere, doloir. Il verbo latino dolere si declina nelle due forme del soffrire e far soffrire, ma anche deplorare, lamentarsi. Uno dei protagonisti del Cardillo, il padre di Elmina e sua sorella, ugualmente alte, impettite, belle e insopportabilmente mute, è guantaio. Doler les peaux, dicono i francesi per acconciare le pelli; c’è una ferita che brucia nella storia di Almina, una ferita che potrà salvarla. Una colpa originaria. Quel dolore è insopportabile ma con Anna Maria Ortese e le sue creature ne esploriamo l’insondabile mistero:
«“Credete, dunque, che il Cardillo nuoccia a chi lo ama?” con una cupa ansia che gli era nuova, il principe aveva chiesto ed è Ferrantina a rispondergli: “È così…Distrugge chi lo ama… Perché è la nostra memoria, signore…il desiderio dei giorni belli…i giorni impossibili, che tutti abbiamo incontrato…almeno una volta nella vita.” »

Un interrogativo mi trascino dalla prima lettura di Il mare non bagna Napoli: perché Anna Maria Ortese decide di assassinare i suoi amici di un tempo in uno dei racconti che compongono questo capolavoro del Novecento, intitolato Il silenzio della ragione? Chiunque abbia dedicato una parte della propria vita alla creazione di una rivista letteraria sa bene quanto conti l’amicizia votata a una causa comune, la fedeltà all’idea. Del resto, le riviste chiudono non quando a mancare sono i soldi, ma quando viene a mancare quell’amicizia, insieme al sentimento condiviso di farcela anche senza il becco d’un quattrino. Le ragioni economiche vengono sempre evocate come causa maggiore ma è un’invenzione, una menzogna per quanto nobile.
Il racconto descrive la vita intellettuale, ma in realtà soprattutto la fine del sodalizio all’origine della rivista Sud, attraverso una sequenza di ritratti degli scrittori che avevano partecipato al miracolo su carta, quando carta in quel misero dopoguerra non ce n’era, una ricostruzione dell’idea di civiltà in mezzo alle macerie. Come viene suggerito dal titolo, Anna Maria Ortese traduce in letteratura la visione sconcertata di Goya. La galleria del reportage ha lo stesso tono grottesco e la contraddizione fondamento definita dalla doppia forza di creazione e distruzione si rivela particolarmente in due immagini.
Quando arriva nella casa di Domenico Rea la cronista nota i panni stesi sul balcone di fronte.
«Guardando in alto, vidi una fila di terrazzini bianchi, con delle cordelle tese da un muro all’altro, come già nella casa di Luigi, e da quelle pendevano un po’ di biancheria, dei calzini. Una goccia, che non era di pioggia, mi cadde su una mano. Era mezzogiorno, e non si sentiva un grido, una voce. Caddero altre gocce: era la biancheria.»
L’immagine del bucato steso al sole ritorna spesso nel racconto, per lo più associato alle idee di sole e colore. Eppure Napoleone l’aveva ben detto che il y a des histoires qui font que le linge sale ne doit se laver qu’en famille, anche se è a Napoli che la senti da piccolo la magica formula della felicità familiare: E panne spuorche ‘ e lavammo in famiglia.
Questa immagine gioca un ruolo importante nella scena che seguirà poco dopo e che dal punto di vista letterario è tra le più riuscite del racconto. Anna Maria Ortese entra nel palazzo dopo aver lanciato un ultimo sguardo alla balconata. Ha un momento di esitazione prima di suonare; sta per tornarsene indietro sui propri passi ma ci ripensa, decisa di proseguire questo suo viaggio nel passato. La sposa dello scrittore gli apre la porta e sullo sfondo scorge Domenico Rea “freddo e immobile” come un chiodo. Viene fatta accomodare in cucina dove stavano pranzando. C’è anche Vasco Pratolini e dopo un breve e distaccato scambio di battute sulla letteratura e sugli amici, si spostano nello studio per cominciare l’intervista. Tutto sembra svolgersi come da copione quando a un tratto il suo sguardo viene catturato da un dettaglio, del tutto insignificante. Rea non ha smesso di provocarla, di rimproverarla di non “amare il popolo”, come adesso che le si è seduta accanto:
«Sorrise. Un pensiero straordinario gli era passato per la mente e, senza più curarsi di Vasco, guardandomi sottecchi, cominciò a sfilarsi le scarpe, e mi spiava per vedere se questo fatto riusciva a turbarmi. Aveva certe calze di filo, azzurrine come i calzoni, macchiate di giallo in punta.
“Ti piacciono queste calze?”»
Anna Maria Ortese si limita a chiedergli quanto gli erano costate perché sa già che quanto è successo è impagabile, mettere nero su bianco quanto ha appena visto può più che bastare per consegnare la pagina ai posteri. Come giustamente ha scritto Raffaele La Capria in un articolo uscito nel 2008 in occasione della riedizione del Mare. (Il Corriere della Sera, 30 maggio 2008, Napoli alza la voce, ma l’Italia è sorda):
«Con lo stesso sguardo nel capitolo «Il silenzio della ragione» ella rivide i suoi amici d’una volta e li descrisse con sottile ma penetrante crudeltà, notando ogni loro difetto fisico e morale. Oggi si può dire che quello di Compagnone e quello di Rea sono i più bei ritratti della letteratura italiana contemporanea?»
Luigi Compagnone, Raffaele La Capria, Pasquale Prunas, Gianni Scognamiglio, (l’unico ad essere citato con il cognome della madre, Gaedkens) cadono sotto la penna dell’antica amica e gli antichi amici non glielo perdoneranno, non subito, non tutti. Anche lei redattrice di Sud, che come spesso accade per le esperienze più avanguardistiche, i progetti visionari, rimarrà meno nota ai più del Politecnico, fabbricato a Milano e diretto da Elio Vittorini. Imperdonabile la sua violazione di domicilio e non solo dei corpi ma delle anime di tutta la città. Come ricordato dalla mia amica Renata Prunas, Anna Maria Ortese non tornerà a Napoli che molto tempo dopo e senza scalfire il muro che era stato eretto tra lei e Napoli.
Ma perché? La ragione forse è proprio in quel passaggio del Cardillo addolorato che abbiamo citato: distruggere chi si ama perché è la memoria dei “giorni felici”, di un’epoca che non esiste più.
Dovendo scegliere tra la narrazione indolente della spasa di panni lindi, bianchi, ai balconi e la calza ingiallita in punta dello scrittore, Anna Maria Ortese non ha avuto dubbi, su quale cosa concentrarsi, per fortuna, aggiungiamo noi.
Epilogo
Il vero nemico del dolore è il male; il male è la felicità che l’indolenza, come cultura o anche solo come carattere, assicura grazie a questo “non sentire” al dolore; sintomo di una malattia molto più grave della sofferenza perché è preludio della morte dell’anima. Bisogna credere alla letteratura quando al contrario si fa dolente, criminale, violenta, in tutto e per tutto colpevole. Scrittori come Anna Maria Ortese, Witold Gombrowicz sapevano fin troppo bene che soltanto la coscienza di essere allo stesso tempo vittime e persecutori poteva affrancarli da quella terribile condizione.
Soltanto il Dolore, l’unico, è in grado di unire attraverso il tempo e lo spazio, solo il Dolore riduce le generazioni ad un comune denominatore, ha scritto Witold Gombrowicz.
Ora guardo il posto lasciato vuoto sul mio autobus. E non posso fare a meno di pensare che i migliori libri sono quelli che appartengono a una letteratura da stato d’assedio. Una sedia passeggera.
Questo articolo, precedentemente apparso su L’Atelier du roman, è stato tradotto dal francese all’italiano dall’autore stesso.
