Simone Weil è una delle figure più straordinarie della storia del pensiero moderno. Non solo per il rigore con cui ha condotto la sua instancabile indagine interiore e per la rara lucidità con cui ha costantemente rimesso in discussione le proprie conquiste filosofiche, ma per la sua parabola esistenziale, che dalla militanza vissuta fino alle estreme conseguenze la vide raggiungere, dopo la sua celebre conversione, una dimensione ascetica che non è esagerato accostare a una sorta di laica santità («la santa degli esclusi», la definirà André Gide).
Parliamo non solo di una mente eccezionale, ma soprattutto di un’anima sublime: il grande Albert Camus, forse unico pensatore coevo a lei accostabile per profondità e onestà nella ricerca, a cui dobbiamo la sua opera omnia, la definì «il solo grande spirito del nostro tempo».
In appena trentaquattro anni di una vita tormentata da una salute cagionevole, causa della sua precoce scomparsa, questa apparentemente gracile e timida occhialuta professoressa parigina ha vissuto molte vite, col coraggio di una guerriera e la devozione alla verità di una mistica gnostica.
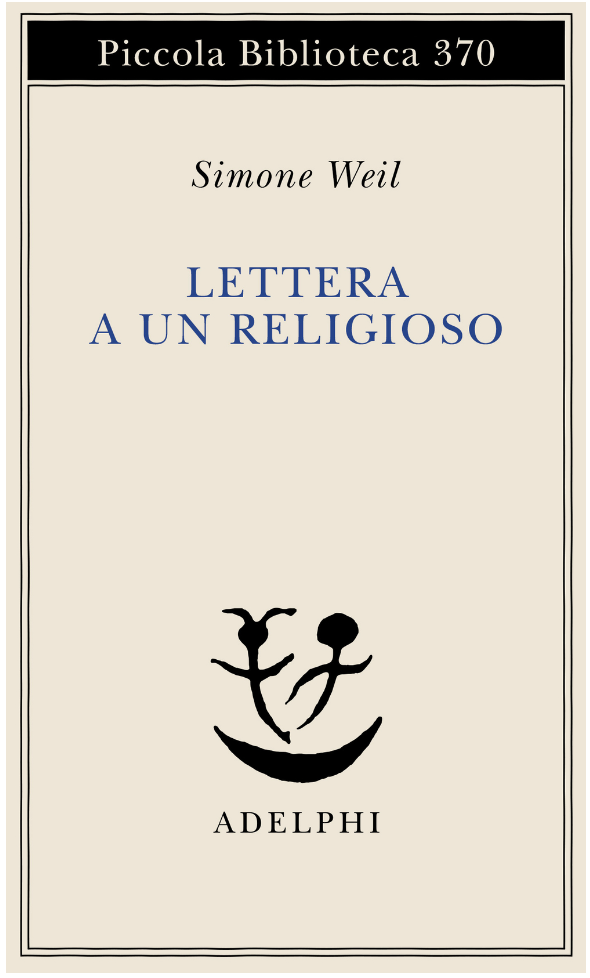
Fin dai miei sedici anni, quando ebbi in dono da Daniele Capuano la sua Lettera a un religioso (Adelphi), testo destinato a divenire una sorta di mio vangelo filosofico e faro della mia ricerca, ho considerato Simone Weil il più grande filosofo del Novecento.
Qualche anno fa Alfonso Berardinelli l’ha definita esattamente così in un suo articolo su Il Foglio, ora consultabile su minima&moralia, e il fatto che l’abbia chiamata così per motivazioni diverse da quelle che mi hanno indotto alla stessa conclusione non fa che rendere ancora omaggio alla grandezza e al valore trasversale del pensiero di Weil.
Recentemente ho avuto ulteriore conferma di questa sfuggente complessità, partecipando a due incontri sulla sua figura: uno a Padova, invitato da Davide Susanetti e Davide Antonio Pio, nella rassegna Il resto a voce, come relatore, in cui ho affrontato, in particolare, il suo rapporto con la gnosi (i saggi sui Catari e la concezione teologica), la qabbalah (il concetto di “decreazione” così affine, senza che lei ne fosse consapevole, a quello di tzimtzum, ovvero la ritrazione di Dio nell’atto di creazione) e il pensiero greco (i saggi sull’Iliade, sulla Grecia e le intuizioni precristiane, sul Neoplatonismo); uno a Roma, da uditore, ascoltando un intervento di Roberto Paura durante l’incontro Guarda al futuro con gli occhi di Simone Weil, incentrato sulla critica del lavoro automatizzato e del concetto marxiano di alienazione (da lei elevato su una dimensione spirituale).
A uno sguardo ignaro, sarebbero potuti benissimo apparire, per vastità di temi e complessità di analisi, incontri dedicati a due pensatrici distinte: eppure, nella folgorante parabola di poco più di un decennio di attività intellettuale ufficiale, esiste un filo rosso, un’evoluzione coerente nella sua ricerca.
Weil ha attraversato, senza essere avvinta dalle loro «manette della mente» (per citare Blake), i più importanti movimenti di pensiero del suo tempo, con strabiliante precocità e innegabile preveggenza.
Questo suo percorso sarà scandito filosoficamente dal paradosso ed esistenzialmente dalla sventura, due dei poli della sua riflessione: lei, mente geniale, si sentirà quella meno intelligente della famiglia, rispetto al fratello André, uno dei più grandi matematici del Novecento (Adelphi ha pubblicato il loro vertiginoso carteggio col titolo L’arte della matematica); lei che per tutta la vita sarà ispirata, illuminata, sconvolta dall’Amore, cristico prima che cristiano, sarà paralizzata nelle manifestazioni d’affetto da una fobia per gli abbracci (instillata dalla madre per motivi di salute); allo stesso modo non solo il suo rapporto con la sessualità fu complesso e traumatico (fu vittima da giovane di un esibizionista), ma col suo stesso aspetto fisico, con la sua femminilità: per alcuni era bella come una modella di Murillo e avrebbe dovuto fare del cinema, per Bataille era «brutta, visibilmente sporca, malsana», vestita sempre di nero, da uomo (il preside della scuola dove insegnava la definì sardonicamente «vergine rossa»); questo contrasto verrà consacrato in poesia da Elsa Morante, che la definì: «bellezza del Cantico dei Cantici camuffata in quei tuoi buffi occhiali da scolara miope». Significativamente l’unica volta che si truccò in vita sua fu per farsi assumere in fabbrica. Fedele, infatti, fino alle estreme conseguenze alla sua volontà di incarnare la sventura, volle vivere La condizione operaia (pubblicato da SE), sottoponendosi, con la sua fragile salute, a turni massacranti pur di avere il “privilegio” non solo di poter condividere la condizione degli oppressi, ma anche di poter offrire un corpo di riflessioni dal valore testimoniale diretto.
Simone Weil parlava da un punto di vista che ancora non esisteva, scavalcando a sinistra il sindacalismo rivoluzionario, arrivando a posizioni prossime all’anarchismo: insomma, era a più a sinistra di quelli che venivano espulsi dai movimenti marxiani perché troppo radicali.
Erano gli anni in cui lavorava a quello che considerava il suo opus magnum,Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale (sempre Adelphi), pubblicato a venticinque anni (1934), geniale decostruzione dei dogmi marxiani e profetica lettura della deriva totalitaria. L’anno prima aveva ospitato a Parigi l’esule Trotskij, contestandolo da trotskijsta (!), tenendogli testa, per lo stupore dalla moglie del rivoluzionario, inchiodandolo alla responsabilità del massacro della Rivolta di Kronštadt.
Già al liceo aveva sfidato un altro futuro mito del pensiero di sinistra, l’altra grande Simone del pensiero francese del Novecento, ovviamente, De Beauvoir, che nelle sue Memorie di una ragazza per bene (Einaudi) ricorderà la reputazione di “grande intelligenza” che fin da ragazza accompagnava Weil e ammetterà di invidiare «cuore capace di battere attraverso l’universo intero». Lo scontro fra le due delinea simbolicamente la spaccatura che animerà la dialettica all’interno dei movimenti progressisti nel secolo successivo (e che scontiamo ancora oggi): sconvolta dalla notizia di una carestia devastante in Cina, la giovane Weil dichiara che l’unica Rivoluzione che le interessa è «quella che avrebbe dato da mangiare a tutti», De Beauvoir, di un anno più grande, risponde che il problema era di dare un senso all’esistenza, non di rendere gli uomini felici. Weil conclude seccamente: «Si vede bene che lei non ha mai sofferto la fame». Com’è noto, quello sarà l’unico e ultimo scambio fra due delle pensatrici più influenti del Novecento.
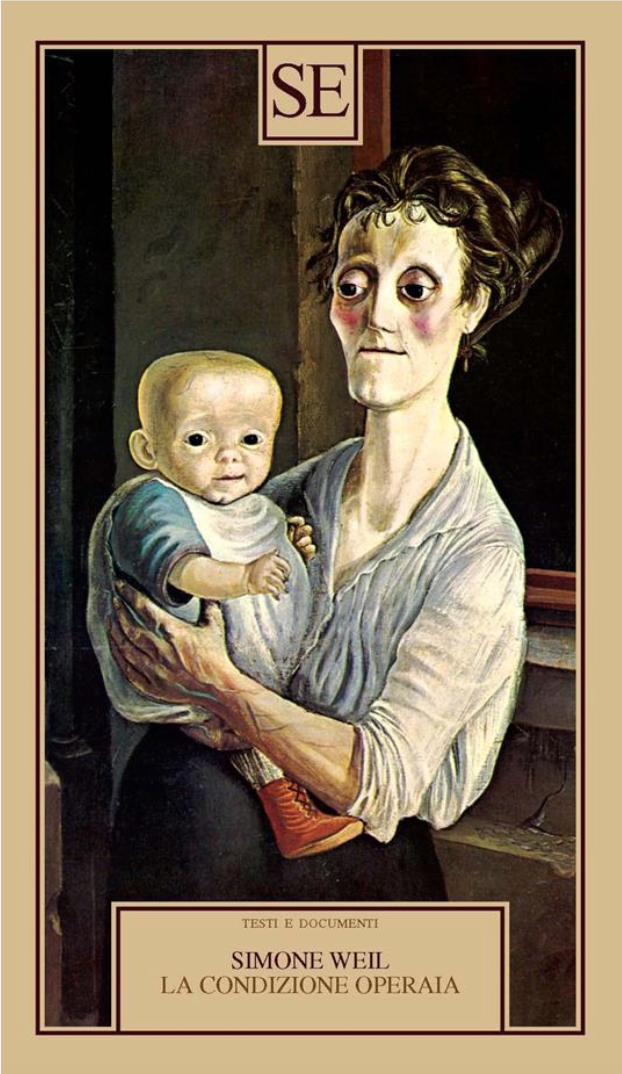
Il culmine della paradossale solidarietà con gli sventurati di Weil sarà la celebre adesione alla Brigata Durruti nella Guerra Civile di Spagna nel ‘36.
Anche in questo frangente emergono tutte le caratteristiche peculiari della figura weiliana: la poetica incapacità di adattarsi alla violenza (non essendo in grado di maneggiare le armi, viene relegata ai lavori in cucina e maldestramente si ustiona un piede rovesciandosi addosso una pentola di acqua bollente); l’intelligenza suprema di cercare il dialogo ed esprimere ammirazione con intellettuali schierati sul fronte opposto (la celebre lettera a Georges Bernanos); lo sguardo razionalmente spietato ma ispirato da compassione spirituale, come nell’episodio con Trotskij, nel testimoniare e denunciare i torti della “propria” parte (nella citata lettera scrive: «Ho incontrato invece dei francesi pacifici, che fino ad allora non disprezzavo, i quali non avevano alcuna intenzione di uccidere di persona, ma che stavano immersi con visibile piacere in quell’atmosfera intrisa di sangue. Per questi d’ora in avanti non potrò mai più avere alcuna stima. Un clima simile cancella subito il fine stesso della lotta, poiché non si può formulare un fine se non riconducendolo al bene pubblico, al bene degli uomini – e qui gli uomini non hanno alcun valore.»).
Dopo l’ennesima delusione ideologica, parallelamente alla lotta politica, Weil aveva già reso cosciente a livello di indagine intellettuale la sua ricerca spirituale, esemplare per apertura mentale e sensibilità archetipica, che avrà il suo punto di svolta nell’episodio mistico, e nella successiva conversione al Cristianesimo (non al Cattolicesimo), avvenuto nel ‘37 in Italia: sentendosi trascinata da una forza sovrumana, si inginocchierà nella cappella della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Eppure, anche qui, paradosso e sventura: pur sentendo fisicamente il desiderio lancinante di accogliere il Corpo di Cristo nell’eucarestia, rimarrà sempre al di là della soglia della Chiesa, sancendo nel 1942 nella già citata Lettera a un religioso (padre Marie-Alain Couturier, che tentò in ogni modo di battezzarla) trentacinque obiezioni alla dottrina cattolica, riassumibili nel passo vertiginoso: «Ogniqualvolta un uomo ha invocato con cuore puro Osiride, Dioniso, Kṛṣṇa, Buddha, il Tao, ecc., il figlio di Dio ha risposto inviandogli lo Spirito Santo. E lo Spirito ha agito sulla sua anima, non inducendolo ad abbandonare la sua tradizione religiosa, ma dandogli la luce – e nel migliore dei casi la pienezza della luce – all’interno di tale tradizione».
Weil, infatti, aveva anche iniziato a studiare la sublime tradizione orientale, Bhagavad Gita e Upanishad in particolare, studiando il sanscrito con René Daumal, come raccolto nell’interessantissimo volume La rivelazione indiana (Le Lettere), a cura di Sabrina Moser e Marco Vannini (punto di riferimento sul pensiero di Weil e la mistica “negativa” in genere).
Ora Adelphi meritoriamente ripubblica Attesa di Dio, definito da Cristina Campo, grande anima sorella di Weil, «un immenso libro», in cui tutte le meravigliose contraddizioni della ricerca instancabile fin qui descritta trovano quiete nell’arresa mistica: «L’incarnazione del cristianesimo implica una soluzione armoniosa del problema dei rapporti fra individuo e collettività. Armonia in senso pitagorico: giusto equilibrio dei contrari. È precisamente di questo che gli uomini hanno sete oggi». E anche qui, ribadisce con splendida lucidità la sua scelta, paradossalmente (come sempre) coerente con una comprensione più profonda dell’ortodossia, di rimanere fieramente eretica:
«Il cristianesimo deve contenere in sé tutte le vocazioni senza eccezione, perché è cattolico. […] tradirei la verità, cioè quell’aspetto della verità che io scorgo, se abbandonassi la posizione in cui mi trovo sin dalla nascita, cioè il punto di intersezione tra il cristianesimo e tutto ciò che è fuori di esso. […] C’è un ostacolo assolutamente insormontabile all’incarnazione del cristianesimo, ed è l’uso di due brevi parole: anathema sit. […] Mi schiero al fianco di tutte le cose che, a causa di quelle due brevi parole, non possono entrare nella Chiesa, ricettacolo universale.».
Assieme al quasi gemello L’Ombra e la Grazia (selezione dai suoi diari nel ‘40-’42, che meriterebbe una lunghissima riflessione a parte), Attesa di Dio (autunno ‘41- primavera ‘42, pubblicato nel ‘49) è una testimonianza dal nitore assoluto del livello abissale di scavo interiore della pensatrice e mistica francese. Come scrive Maria Concetta Sala nel saggio introduttivo, Il promontorio dell’anima, in queste pagine ardenti di sapienza «la via della conoscenza e quella del distacco intersecano quella dell’amore»; risponde Giancarlo Gaeta, indiscussa autorità sul pensiero weiliano, in quello conclusivo Un infinitamente piccolo: «Ciò che Simone Weil ha cercato di indagare e porre in evidenza negli scritti degli ultimi anni della sua breve vita è dunque sì un cristianesimo mistico, ma in cui la dimensione verticale , e perciò necessariamente personale, del rapporto con Dio, ha un’incidenza profonda sulla dimensione comunitaria, che ritrova il suo carattere propriamente religioso».
Un testo fondamentale, di una delle più grandi voci filosofiche e spirituali, degli ultimi secoli, che contiene, se non le risposte definitive, almeno le domande urgenti per iniziare ad affrontare la crisi spirituale, morale e politica di questo agonizzante Kali Yuga.
Illustrazione di copertina di Francesca Lippa (@vecchiajane)
