Shawarma e beaver-tail. No. Tourtière e bagel. No no.
Minime sono le Ricette semplici che Madeleine Thien vassoia per 66thand2nd edizioni, esportando prelibatezze il cui nerbo para-culinario l’Italia attendeva dal 2001. Sono racconti laminati, sono l’esordio inedito della premiata autrice canadese (Vancouver, 1974; Non dite che non abbiamo niente valse nel 2017 diverse corone) adorata da Munro. Il caprice des dieux qui non contiene caseina ma appartiene all’uzzolo – furia, ira, depressione, catarsi – del destino, sulla cui crosta molle i protagonisti pattinano.
I fornelli, solo l’inizio. «In casa nostra i soffitti erano ingialliti dall’unto. Perfino l’aria ne era impregnata. Ricordo che mi piaceva quel peso, denso dell’aroma di innumerevoli pasti preparati nella minuscola cucina, tutti quegli odori di buono che sgomitavano per trovare posto». Scrive Thien. E si tratta di abili alibi per esporre la famigliarità, a pancia sazia – di riso bollito, di chilli kepeting. Liberi animali in gabbia, i protagonisti delle Ricette hanno facce appese proprie a padri violenti, madri inette, amiche interrotte, mariti liquidi.
Sei storie diversamente tracciate, con una colleganza sinistra a cordonarle. Ovunque appaiono capelli accarezzati (il manto del ludibrio), genitori irrisolti o disgraziati («Una volta, in piena notte, nostra madre Irene si sedette sul letto vicino a noi ed elencò tutte le sue forme di infelicità») o incuranti («Erano presi dal lavoro, dalla necessità di sbarcare il lunario, e a stento si accorgevano se c’ero o no»). Esiste un male da «soffiare via» come pulviscolo, entro alternative manichee: «Emergere altrimenti sparire», scappare altrimenti «affogare»; non di meno la redenzione esula i corpi («Fuggire non mi aveva mai salvato, come speravo»), anzi li àncora. A un tempo combusto («Adesso oppure mai, prima oppure poi»), a speranze confuse che agognano il bene quanto il male, e a condensazioni aleggianti – tra verità, tra bugie – sopra calendari scomposti. Tante le case dalle quali prima andare poi venire. È la tragedia del luogo: «Trovarsi sempre nel paese sbagliato al momento sbagliato, nella patria che non ha bisogno di te quanto tu hai bisogno di lei». Il simbionte dell’incompiutezza, questo, descritto con dolente ripetitività carveriana; va tutto male, anche nel richiamo istintuale caro al soddisfacimento di desideri piccoli, appunto «semplici». Le vicende abbattute che Thien deraglia somigliano neanche al reale, tanto annunciano da principio la cattiva fine contro al lieto. Invero non stancano, mai avviliscono l’osso di una speme che ha a che fare col puro sentire, col sogno (si sogna sempre, perfino quando non si vuole) – «Immaginai un posto di enorme abbondanza. Pesci nel mare e una tremenda bellezza». C’è da udire il battito di un cuore di scorta, pulsare basso, pallidamente genitalico e soavemente carnivoro. C’è da vedere una luce che indossa a misura stanze-prigioni.
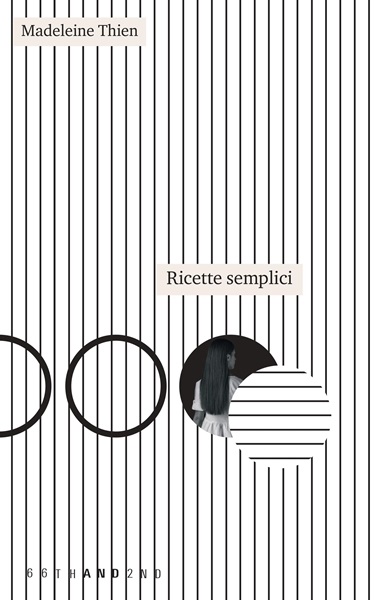
Dietro lo stile della narrazione, immancabilmente smunto, sormonta il lavoro estetico: togliere, levare, infine cancellare. Poche parole restano, volentieri ripetono, sotto ai colori mai squillanti di un’ossessione calma. Si fanno strada, su carta, le strade stesse del Canada, con la loro fittizia pace inerte e la magnifica quiete del nulla continuo. Spesso il vocabolario ha in sé l’aspra congestione di ghiaccio e neve, alle volte regge la solitudine d’interminabili spazi. Lo fa vestendosi poco, battendo i denti; ci riesce mediante una lucidità funerea, il travaso di verosimiglianze panoramiche ritoccate per difetto. A Thien piace lasciare sprovvisti di fiato, senza preoccuparsi se l’apnea risulti o meno letale. Femminile, fredda, esige la rilettura dei dettagli, delle tracce uterine dolcemente dissimulate nel sangue (nella violenza) di una psicologia a grana grossa, maschia. Mentre descrive stati cronici d’inerzia o psicosi tramite scultorea ineluttabilità, è come se soffiasse tranquilla la propria lullaby – ogni cosa va a rotoli, ogni cosa è vento.
