Figlio di un nobile senese e di una facoltosa tedesca, l’archeologo e politico Ranuccio Bianchi Bandinelli nacque all’alba del secolo scorso, il 19 febbraio 1900.
L’amore smisurato per i libri lo accompagnò in un’adolescenza solitaria trascorsa per lo più tra stucchi neoclassici, affreschi e decorazioni a soggetto mitologico. Verrebbe automatico supporre che cominciò lì l’interesse per le antichità classiche, invece all’inizio Bianchi Bandinelli voleva dedicarsi a ben altro, studiare Ingegneria. La guerra, però, gli scombinò i piani. Anche lui nel ’18 fu chiamato alle armi e il contatto con l’età adulta fu brusco. A conflitto terminato, avrebbe potuto benissimo crogiolarsi nelle rendite e nel ruolo di aristocratico proprietario terriero, ma credeva già allora nell’ideale comunista, in una società di uguali.
«La ricchezza ereditaria è cosa terribile. […] Per farsi perdonare la ricchezza bisogna mettersi in qualche modo al servizio dell’umanità, assumere su di sé ogni più pesante dovere umano. Io oggi non ho più la ricchezza; ma ho pur sempre la comodità; e della ricchezza ho ancora l’apparenza. Bisogna farsi perdonare anche quella.»
Andò a Roma per studiare Archeologia. Forse fu una scelta consapevole, oppure no. Del resto chi sceglie consapevolmente a diciannove anni, ieri come oggi? Nonostante la giovane età, Bianchi Bandinelli nutriva molti dubbi verso una disciplina così imbevuta di collezionismo. Disprezzava l’idea che fosse solo un passatempo per ricchi dotti e si adoperò molto per renderla una scienza storica, capace di scoprire gli archivi materiali del passato.
Dopo la tesi sulla Chiusi etrusca e la laurea a pieni voti, si sposò, pur nutrendo incertezza sia per la sua carriera che per la deriva politica del paese.
«È terribile vedere così lo sfacelo di una civiltà. […] Tutti noi, tutti quelli che pur pensano con un barlume ancora di equilibrio e indipendenza, barlume conservato vivo a fatica in questi tristissimi tempi, tutti noi abbiamo colpa in questo stato di cose, che pure non ci ha trovato consenzienti, ma che ci ha trovato inerti, passivi, accomodanti, per la tranquillità personale e per l’egoismo di ‘classe ’.»
Aborriva l’idea di diventare anche lui un ottuso “erudito locale”, non voleva essere imbrigliato in una rete di interessi provinciali. Per affermarsi in un panorama accademico assai feroce, cominciò a viaggiare. Groningen, Cagliari, Pisa. Qui nel ’33, occupò la cattedra di Archeologia, intesa più che altro come una Storia dell’Arte antica grecocentrica. Credeva che il compito di un professore non fosse quello di fornire agli studenti dogmi o verità inappuntabili, ma instillare il dubbio, suscitare delle domande. «È proprio questo dubbio che porta a dei cambiamenti di rotta, a nuovi orizzonti.»
Una visione all’avanguardia che, tuttavia, gli attirò le antipatie di molti colleghi; antipatie che crebbero quando nel ’38 venne incaricato direttamente dal Ministero di accompagnare Hitler nel suo viaggio di tre tappe: Napoli, Roma, Firenze.
Provò a svincolarsi proponendo altri nomi, che erano stati già scartati. Bianchi Bandinelli restava la scelta più ovvia: parlava fluentemente tedesco, aveva una vasta cultura e una precisa disinvoltura nobile-borghese. Era perfetto, insomma, solo che lui non voleva farlo. Gli fu risposto che gli avevano chiesto un favore, ma potevano benissimo ordinargli di farlo. Bianchi Bandinelli volle che glielo ordinassero e l’ordine arrivò puntuale, il 2 aprile ’38. Il Führer era atteso il mese dopo.
Da quel momento prese a girare per musei per rinfrescarsi la memoria e calcolare i tempi della visita, e parallelamente si insinuò in lui una pericolosa fantasticheria. Una persona estranea, priva di sospetti, che sarebbe stata seduta in automobile tra i due dittatori, che avrebbe potuto ordinare un rallentamento lungo il percorso con la scusa di osservare un tal monumento: non era forse l’occasione perfetta per un attentato?
La fantasticheria divenne possibilità quando si rese conto di non essere sorvegliato dalla polizia. C’era un unico problema: lui era un antifascista generico senza direttiva politica, soprattutto senza appoggi. Anche volendosi immolare per la causa imbottito di esplosivo, dove lo avrebbe trovato? E, se pure fosse riuscito a procurarsi un’arma, non era certo che sarebbe bastato decapitare due regimi per farli crollare.
«Ma poi, in effetti, si lascia dirigere la storia? Questo, dico a mio rossore, il dubbio più assillante e più distruttivo di quei giorni.»
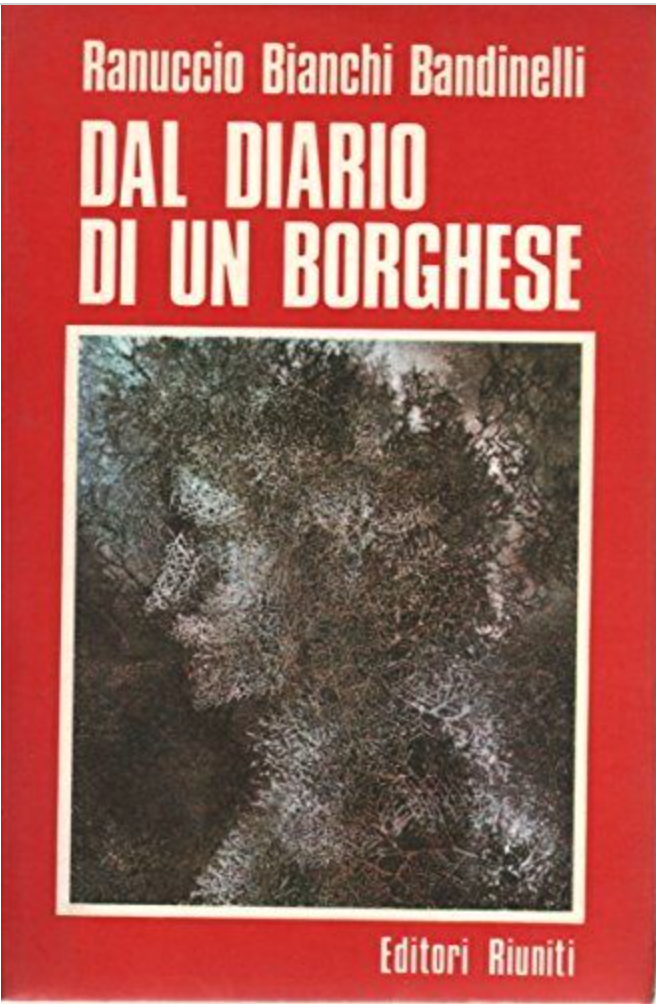
Venerdì 6 maggio calò in Italia Hitler che, col suo largo seguito di alte cariche tedesche, insieme al Duce si preparava ad attraversare lo Stivale. Bianchi Bandinelli annotò tutto in un taccuino che sarebbe stato pubblicato con un titolo esplicativo, Intermezzo agli Inferi (Dal Diario di un borghese e altri scritti, edizione Editori Riuniti, 1976).
«Veduti Mario e Silla. Impressione prima e sorprendente di Mario: grottesco e bruttissimo. Cammina come un burattino, con curve e mosse oblique del capo, che vorrebbero mitigare la sua massiccità, ma sono soltanto goffe e sinistre. […] Silla è, nell’aspetto primo, meno repulsivo. Composto, ordinato; quasi modesto. Quasi servile, anche. Una personalità di aspetto subordinato: qualche cosa come un controllore del tram. Viso vizzo. Mario, invece, lo ha turgido, lucido, dalla pelle grassa.»
Per la ripugnanza di pronunciare i nomi veri, si era inventato due pseudonimi: Mario-Mussolini, Silla-Hitler. Accantonata l’idea di un attentato, aveva cercato di viversi quella manciata di giorni come un osservatore della Storia. Non aveva, però, fatto i conti con la nausea di trovarsi in una combriccola male assortita che dietro sorrisi di circostanza nascondeva pugnali affilati. Toccò con mano l’odio insito tra le alte gerarchie del Reich, l’istrionismo del Duce, la facilità con cui Hitler piegava qualsiasi cosa che gli veniva detto per i propri scopi. Terminò l’incarico sulla porta di Palazzo Vecchio, anche se i tedeschi cominciarono a tormentarlo con inviti ufficiali, conferenze e interviste. Gli fu chiesto di replicare nel ’40 per un’altra visita del Führer. Disse di no.
«Questa nuova avventura non mi interessava. Ormai la curiosità era stata appagata, e troppo sangue era già corso: non rimaneva che avversione e disgusto.»
L’episodio sarebbe stato usato contro di lui nel Dopoguerra. A Siena comparvero manifesti contro il “Conte Rosso” e, addirittura, un quotidiano locale arrivò stupidamente a sostenere che era colpa sua se la Germania nazista aveva manifestato certi voraci appetiti artistici.
Ma Bianchi Bandinelli si ritrovò comunque al centro del ciclone. Era l’aprile ‘44, ed era appena stato ammazzato Giovanni Gentile, il filosofo del Fascismo. Ormai inquadrato politicamente tra le file del PCI, Bianchi Bandinelli venne arrestato e trascorse un mese alle Murate con l’accusa di aver appoggiato l’assassinio di un uomo che conosceva da anni, anche se i rapporti si erano raffreddati per divergenze d’opinione. Nel suo Diario scrisse che la richiesta di incarcerare dieci professori antifascisti per pareggiare i conti era venuta dal partigiano Bruno Farinacci, in seguito ritenuto uno dei mandanti dell’omicidio.
«Ci presero in tre soli (i più ‘ghiozzi’); e poi non ci fucilarono. Non fucilarono nessuno, quella volta. (Forse qualche anima pia oggi rimpiange che non mi abbiano fucilato; forse anche qualche spirito liberale).»
Le autorità non avevano elementi per condannare a morte i prigionieri e, vista anche la posizione della famiglia Gentile, furono liberati. Nonostante ciò, l’ombra lunga dell’omicidio gli restò appiccicata addosso per anni.
Però la vita continuava e anche quella di Bianchi Bandinelli continuò, divisa tra l’insegnamento a Firenze, gli impegni delle sue proprietà nel senese e l’attività politica nella capitale. Poi giunse la vecchiaia e il tempo dei bilanci.
«Se fai un bilancio della tua vita, non lo fai di ciò che hai compiuto, ma solo di quella finzione che hai prescelto e hai eseguito. Si tratta soltanto di vedere se l’hai seguita bene e con tua e altrui soddisfazione, insomma, se hai recitato bene.»
Non lo sorprese la diagnosi di leucemia e accettò la fine con stoicismo. Non gli interessava ciò che sarebbe accaduto dopo, pensava che il culto dei morti fosse «una barbarica sopravvivenza di età preistoriche.» Si spense il 17 gennaio ’75 senza tardive conversioni.
Il fascino e l’unicità di Ranuccio Bianchi Bandinelli è da ricercarsi nella personalità paradossale di un comunista aristocratico, l’affascinante protagonista di un Bildungsroman tutto italiano. Enrico Caria nel documentario a lui dedicato L’uomo che non cambiò la storia (2016) non gli rende appieno giustizia. Perché uno dei più importanti archeologi del ‘900, un politico e libero pensatore, non aveva bisogno di sparare a Hitler e al Duce per cambiare il mondo, lui, a modo suo, lo stava già cambiando.
Photo credit
Immagine di copertina: frame trailer di L’uomo che non cambiò la storia (2016) di Enrico Caria
