«Si produce solo merda e per produrre la merda bisogna mangiarla», così diceva in una delle sue ultime interviste Enzo Mari denunciando l’autoscatologia dell’arte contemporanea e così sembra ripetere a ogni suo libro Francesco Permunian, che col padre del design italiano condivide molto: l’etica severa del lavoro artistico, un certo cattivismo profetico e soprattutto, dote ormai rarissima, la capacità di contestare o perlomeno problematizzare il proprio settore rimanendoci magari non al centro ma sicuramente al vertice estetico.
In Teatri minimi della Valpadana (Quodlibet), caustico libretto a metà tra le Vite brevi di idioti di Cavazzoni e La sinagoga degli iconoclasti di Wilcock, un Vasari di paese di nome Florestano Fregoso del Cedro, di mestiere agente di salumi, raccoglie le vite di personaggi paesani venetoemiliani, racconta, spettegola e sa tutto di tutti perché è andato a letto con tutte dalla bella trattoraia coi capelli rossi tinti anche sul letto di morte alle dominatrici sessuali anzianotte armate di punteruolo.
Il risultato sono francobolli in prosa, epitaffi preventivi di singolarissima vivacità espressiva. Un dirigente scolastico schiavo emicranico della burocrazia si fa mostro delle vecchiette e accoltellando gli passa il mal di testa, la moglie inchiavata di un ranaiolo mette al mondo un bambino macrocefalo così arrapato a priori che va tenuto al guinzaglio pubico con un campanellino testicolare, nei ristoranti dell’Appennino toscoemiliano si consumano risse teologiche tra rutti montanari e sputo libero per spegnere il fuoco dei presunti peccati.
Appartato sulle sue famigerate sponde pettegole del lago di Garda, come le apostrofa spesso, Permunian vive nella clausura senza dio della pagina scritta, presenta poco e quando si presenta lo fa solo per portare la sua indignazione, non interviene sui supplementi culturali i cui contributi peggiori chiama affettuosamente pastoni, ma è un instancabile conversatore epistolare e con la scusa poetica del suo ultimo libro abbiamo deciso di confrontarci in una sorta di breve dialogo agostiniano ateo sui temi decisivi della sua opera: la sua idea di romanzo o non romanzo, il rapporto tra lo scrittore e la sua lingua, l’anticlericalismo rissoso, le scuole di scrittura ricreativa e la brutta fine della letteratura al tempo dell’eccezionalità di massa.
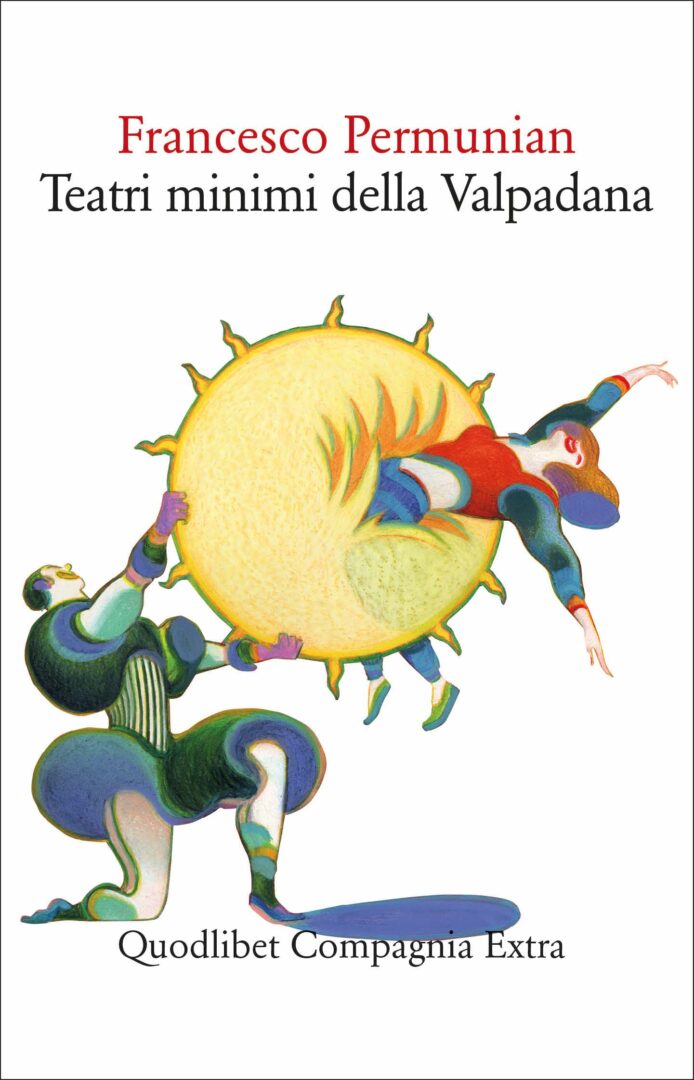
La pubblicazione del tuo Teatri minimi della Valpadana con la collana quodlibetiana Compagnia Extra, che secondo la definizione controeditoriale del suo curatore Cavazzoni pubblica il comico, l’irregolare e mai e poi mai il romanzone, a mio avviso ribadisce ulteriormente una certa tua idea di letteratura in qualche modo minima. Oggi più il romanzo non conta niente e più lo scrittore letterario prova a metterci tutto, a scrivere anzi a strascrivere il grande romanzo massimalista, spesso cosmopolita, a sette voci e ambientato in dodici epoche storiche diverse compresi il futuro e l’aldilà. Tu invece scrivi perlopiù frammenti, raccolte di francobolli in prosa, prediligi testi piccoli ambientati nel piccolissimo. Come e da dove nasce questa tua poetica?
Il più importante e trasgressivo scrittore francese oggi in circolazione – Régis Jauffret – nel 2007 pubblicò la sua prima raccolta di microracconti (splendidi e crudeli “coriandoli narrativi”) intitolandola Microfictions. A cui, provocatoriamente, pose il seguente sottotitolo: “Romanzo“.
Per quanto mi riguarda, sono anni che io mi affanno a scrivere e a riscrivere “francobolli” rivolgendomi direttamente ai morti. Ai fantasmi del mio passato. Lavoro sulla memoria, l’unica “realtà” data e concessa a uno scrittore. Cosa faccio? In sostanza, costruisco una trama di deliri individuali, tanti fili narrativi tenuti saldamente in pugno da un’unica “voce” spesso occulta a prima vista. Non di rado sordida e irriverente. Comunque sempre istrionesca e beffarda.
È la voce di un dominus occulto che di tanto in tanto, quando è necessario per lo svolgimento della trama, li mette in relazione facendoli dialogare tra loro, questi miei ossessi. Questi poveri attori che sgambettano comicamente sul palcoscenico impolverato della mia allucinata provincia mentale.
E perché lo faccio? Lo faccio nell’illusione, un po’ patetica e romantica (lo riconosco), di scrivere delle lunghe “lettere” ai trapassati affrancandole di volta in volta – ecco il punto! – con dei regolari francobolli postali, pena il rischio che quelle balbettanti missive non giungano mai a destinazione. Ovverosia nelle mani dei nostri morti. Ai quali, si sa, è concesso di rivivere una seconda vita solo quando ricevono – magari per sbaglio o per dolo – qualcuna delle nostre lettere. Qualcuna delle nostre preghiere. Qualcuna, insomma, di quelle strampalate fanfaluche in grado di farli ridere resuscitandoli così, anche solo per qualche istante, dal sonno eterno del loro oblio.
E dunque, cos’altro posso dire in proposito? Che dire di questo impossibile e umanissimo tentativo di comunicare con l’incomunicabile (e l’innominabile) attraverso i miseri e scalcagnati strumenti della letteratura? Io non ho una risposta, mai avuto una. D’altronde io non sono filosofo o teologo, né un opinionista televisivo. Ho però un presentimento. L’impressione cioè di stare scrivendo da anni un’unica serie infinita di francobolli per un’eternità di cartapesta. Il che, francamente, da una parte mi scoccia e addolora. Ma, al tempo stesso, mi rasserena e rassicura sul mio destino di oscuro scrivano per l’aldilà.
In una conferenza su Kundera, Massimo Rizzante riferisce di un dibattito tra lo stesso Kundera e Brodskij sul rapporto tra lo scrittore e la sua lingua. Secondo Kundera lo scrittore sarebbe i suoi temi, per Brodskij sarebbe la sua lingua. Secondo Brodskij perché uno scrittore non sia più uno scrittore gli si deve togliere la lingua, per esempio esiliandolo, mentre secondo Kundera uno scrittore smette di essere scrittore quando non può più usare i suoi temi: Kafka sarebbe ancora Kafka se scrivesse in francese ma non sarebbe più Kafka se non potesse più scrivere del padre.
In una stagione letteraria in cui gli stessi scrittori italiani sono in un certo senso stranieri nella loro lingua perché si formano quasi solo su stranieri o al massimo su italiani formatisi su stranieri, mi sembra che la tua pagina sia una delle ultime ancora concepite in italiano, è una pagina in cui si sente la tradizione italiana proprio a livello sintattico, di partitura grammaticale, è una pagina indiscutibilmente contemporanea ma si sente dentro Manzoni. Come sei arrivato a trovare questa pagina, come la ritrovi a ogni libro e qual è secondo te il rapporto tra lo scrittore e la sua lingua, insomma dai ragione a Kundera o a Brodskij?
E quindi, secondo te, nella mia scrittura si sentirebbe Manzoni… Ma se anche così fosse, non sarebbe di certo il Manzoni che mi hanno insegnato a scuola, quel “santino” approntato dalla tartufesca morale cattolica che ha imperversato per più di un secolo in tutti i programmi scolastici italiani, dio ce ne liberi!
Se Manzoni deve essere, che sia almeno quello – tragico e nichilista – che emerge dagli scritti di Leonardo Sciascia, in primis. E poi dagli studi e dalle indagini filologiche di Salvatore Silvano Nigro e di Ermanno Paccagnini i quali hanno dimostrato, una volta per tutte, l’importanza fondamentale della Colonna infame nell’economia e nella struttura narrativa dei Promessi sposi.
Quanto alla prima parte della domanda, io mi schiero convintamente dalla parte di Brodskij. A mio avviso, si è scrittori solo quando si possiede una lingua letteraria, con la quale si è in grado di trattare e sviluppare qualsiasi tema. Non è mai il tema o l’argomento il vero ago della bilancia tra scrittore e scribacchino, bensì la sua lingua. Il suo stile. In una parola: il suo canto che, alla fin fine, è sempre un dono (ma anche una condanna…). E che pertanto non si può imparare in nessuna scuola di scrittura, essendo esso dato unicamente dal caso e dal destino.
Da qualche parte nelle Centoventi giornate Sade scrive che il bello non ha bisogno di altri aggettivi mentre il brutto va descritto. Chiunque può scrivere del bello ma per scrivere del brutto ci vuole talento, il brutto costringe a scrivere sul serio, scatena la compulsione sinonimica e in effetti nei tuoi libri l’orrore paesano e soprattutto cattolico diventa barocco, generativo, enciclopedico.
Secondo te visto il secolo ormai secolarizzato si può ancora scrivere male del cattolicesimo senza risultare anacronistici o peggio pittoreschi e non pensi che se continuiamo a dare per morente il cattolicesimo poi non c’è più nessuno che si prenda la briga di farlo fuori davvero una volta per tutte e tutti?
Per me parlar male del cattolicesimo, in fondo, è una questione di affetto. È uno dei pilastri portanti del mio mondo perduto, quello dell’infanzia. Un’infanzia solitaria vissuta nelle campagne del Polesine nel corso degli anni Cinquanta. In terre palustri e poverissime, veri e propri granai di una fede religiosa che spesso e volentieri sconfinava nella superstizione. In pratica: grandi serbatoi di miseria, di alcolismo e di immigrazione.
Per fortuna quei tempi ora sono finiti anche laggiù, tra le sponde dell’Adige e del Po e quindi anche quel cattolicesimo è tramontato. Ciò nonostante essendo state quelle le mie vere radici – la mia vera linfa materna – per tale ragione io non posso fare a meno di scrivere e di pensare ancora alla religio della mia infanzia. Contribuendo così, paradossalmente, a mantenerne perlomeno le vestigia. Le sue lacere vesti di fantasma. Il quale, beffardamente, si ostina a svolazzare ancora nei miei sogni.
Ma d’altronde, come pretendere di essere veri scrittori se non si riesce a dialogare veramente con i fantasmi del proprio passato?

Al momento gli scrittori italiani si dividono più o meno in due categorie: chi insegna scrittura e chi insegna che la scrittura non si insegna ma alla fine la insegna lo stesso, mentre tu ti collochi più o meno a metà e per conto tuo, perché da un lato non vuoi fare il maestro di scrittura e dall’altro sei forse tra gli ultimi scrittori a aver avuto dei veri maestri di scrittura, mi riferisco a Zanzotto e Corti, di cui hai scritto spesso, come in Viaggiatori dal cielo, il volume dedicato a Maria Corti e curato da Benedetta Centovalli.
Al di là dei parossismi grotteschi di certi tuoi passaggi comunque sacrosanti (penso soprattutto a Giorni di collera e di annientamento ma non solo), a tuo avviso cosa c’è di specificamente sbagliato o problematico nella teoria e nella prassi delle scuole di scrittura di oggi e in cosa la tua decennale e irregolarissima scuola di scrittura con Zanzotto e Corti era diversa e come ha contribuito a renderti lo scrittore che sei?
Il fatto è che, caro mio, un tempo si andava a bottega! Si imparava a maneggiare i ferri del mestiere presentando i propri scritti a qualche riconosciuto maestro in quel campo. A qualche titolare, per così dire, di qualche celebre “boutique” poetica o romanzesca. Poi, se i tuoi scritti risultavano di un qualche interesse, ecco che venivi cooptato in quella specie di società letteraria che ormai non esiste più da decenni. E là dentro – tra apprendisti e maestri d’ascia – ci rimanevi fino alla tomba sopra la quale, se eri fortunato, ti erigevano un piccolo altare postumo in memoria. Oppure ti dedicavano una piazza o qualche via secondaria nel tuo paese d’origine.
Al contrario, oggi non si va più a bottega, visto che le botteghe di un tempo hanno chiuso i battenti. In compenso, si va al supermercato! Ossia si va a bussare alle porte di quei supermercati delle lettere che sono le cosiddette Scuole di Scrittura, dove si iscrive chi non sa trovare da solo la propria voce. La propria lingua, ammesso e non concesso che ce ne abbia una…
Parlando del mio caso, io ho imparato i rudimenti delle tecniche di scrittura assorbendoli direttamente dalla lettura dei miei autori prediletti. Perché se non sei un buon lettore, difficilmente diventerai un bravo scrittore. La lettura è l’altra faccia della scrittura, sono le due facce della stessa medaglia. Per questo, ieri come oggi, io continuo a leggere. Con gioia e profitto. E siccome i romanzi italiani mi annoiano da morire, preferisco dedicare il mio tempo – ieri come oggi – nel leggere o rileggere poesie, diari, epistolari, taccuini, microsaggi… Ad esempio il Taccuino per stenografia di Emil Cioran uscito di recente per Mimesis a cura di Antonio Di Gennaro, oppure le Poesie della torre di Friedrich Holderlin tradotte e finemente curate dal poeta Vincenzo Ostuni per Ponte alle Grazie. Ma anche gli Escolios di Nicolas Gomez Davila, impavidamente e magnificamente allestiti e proposti da Luigi Mascheroni. E infine, quando non trovo più niente per soddisfare questi miei gusti particolari, allora ritorno a sfogliare quello scrigno di scritture brevi e fulminanti che sono Scrittori italiani di aforismi, i due Meridiani Mondadori in cui Gino Ruozzi ha raccolto e commentato, da par suo, il meglio della produzione di quel genere.
In tempi fascisti o clericali la censura funzionava per qualità, si sceglieva chi e cosa far sparire, mentre adesso sembra che la censura funzioni per quantità: la libertà espressiva universale zittisce per eccesso di chiasso ciò che è davvero significativo. Se tutti sono scrittori non lo è più nessuno e, paradosso nel paradosso, gli scrittori famosi per essere scrittori non hanno quasi mai un’opera perché sono troppo impegnati coi podcast e coi festival a fare, citando Berto, i padreterni dell’antifascismo.
Come se ne esce se se ne esce, lasciamo fare al tempo tiranno giusto o ci vuole una rivoluzione disarmata non dico per cambiare le cose ma anche solo per poterle immaginare diversamente?
Per quanto riguarda la nostra romanzeria nazional popolare, sempre più dedita ad autopromuoversi in festival e fiere letterarie, ti posso rispondere con le parole di Alfonso Berardinelli contenute in quell’aureo libretto uscito da Donzelli nel 2006 che aveva per titolo: Sul banco dei cattivi. A proposito di Baricco e di altri scrittori alla moda.
Mi sembrano ancora di un’attualità sconcertante, eccole dunque: «Vent’anni fa gli intellettuali si trasformavano in personaggi, star mediatiche, interpreti teatrali di se stessi. Gli autori, per essere letti e avere più audience, dovevano anzitutto farsi conoscere come icone pubbliche. Gli scrittori giovani, in attesa di entrare in scena, furono molto impressionati da questa nuova estetica gestuale della comunicazione. (…) La letteratura si sposta così verso la dimensione delle arti performative, come la musica, la commedia, il ballo, l’acrobazia, il contorsionismo, il mimo. Queste cose lo scrittore quarantenne di oggi le sa così bene che punta decisamente sull’autopromozione. Non pensa certo all’opposizione. Semmai usa i mezzi della provocazione e dell’esibizione. Chiede attenzione. Disprezza la critica, ma la vuole al suo servizio».
Copertina: Autoritratto, Otto Dix
