Cosa sarà mai, tutto questo, ora? Quelle famiglie raggomitolate davanti ai bancomat in fila proprio dietro l’angolo di una strada o di un boulevard; loro così piccoli, appena protetti da coperte di fortuna, di lana annerita dai marciapiedi, candide all’origine e bordate di linee regolari e più scure. Chi saprà dirci della vecchia signora distesa su un fianco, come un modello di Delacroix, testimone impassibile di passanti distratti e presi dalla Bastille immersa nel traffico. Lei, sì proprio lei, degna proprietaria dello sguardo – talvolta sorride ma d’un sorriso grave – vestita dei colori del suo continente, tiene in grembo il sopravvissuto al lungo viaggio per mare, un muro d’acqua invalicabile.
Di che si tratta, quando vediamo scendere dai treni che attraversano frontiere, file di uomini, per lo più, e donne, tra i ranghi di doganieri con fasce sgargianti al braccio, senza che i loro passi nella neve lascino tracce del passaggio?
Ma allora cos’è, il vecchio appostato tra i banchi del metrò aggrappato alle ossa e al silenzio come a un pezzo di legno un naufrago che abbia visto affondare, impotente, i propri sogni da ragazzo. E il nome, lo sapremo mai del piccolo, l’ennesimo trovato inanime su una spiaggia greca o turca? In quale mondo siamo? Chi potrà mai dirci qualcosa di tutto questo?
Dickens, naturalmente.
L’universo descritto in ogni suo minimo dettaglio di personaggi secondari, figuranti smarriti nella nuova civiltà del mercato globale, una catastrofe polifonica che soltanto la visione catartica del romanzo può contenere grazie a un potente gioco di specchi e di sguardi. Del resto, l’intera poetica di Dickens, il successo decretato da lettori di ogni dove, risiedono proprio in questa abilità narrativa in grado di permettere una visione d’insieme senza sacrificare la singolarità di mille umanità, spesso dimenticate, oltraggiate, oltre ogni umanità.
In un poema intitolato Possibilità, Wislawa Szymborska aveva scritto in proposito:
«Preferisco Dickens a Dostoevskij.
Preferisco me che vuol bene alla gente,
a me che ama l’umanità.
Preferisco avere sottomano
ago e filo».
Capire in fondo l’opera di Dickens è percorrere con le dita la stoffa dei personaggi, seguire la trama delle cicatrici dei suoi antieroi. Il siciliano Tomasi di Lampedusa ha scritto a proposito di Dickens:
«È di questi personaggi secondari di Dickens che bisogna parlare adesso: intendo dire di quelli veramente secondari, delle semplici comparse. In migliaia di romanzi di migliaia di autori potremmo leggere una frase di questo genere: “Il commendatore Attilio Gattoni scese dal taxi all’ingresso della stazione e, pagato l’autista, chiamò un facchino per farsi portare le valigie allo scompartimento”. In Dickens tanto l’autista come il facchino sono caratterizzati, e caratterizzati benissimo. Conoscete i bitorzoli del loro volto, le macchie del loro vestito e le cose gentili o villane che si diranno fra loro e diranno al commendator Gattoni, essi faranno parte del mondo dickensiano. Questa regola vale sempre, anche nei romanzi meno riusciti, ed è questo che dà al tutto una così intensa sensazione di formicolante vita.»
Una tale profondità dello sguardo permette di non limitarsi a un semplice “rapporto” sul reale, alla maniera di una cronaca giornalistica ma di accedere a una comprensione dello stesso attraverso artifici di distorsione che solo un grande caricaturista come Dickens poteva tanto naturalmente concepire. Tomasi di Lampedusa, come G. K. Chesterton l’aveva del resto già annunciato nella monumentale biografia che gli dedica, in particolare quando ci fa conoscere un episodio della sua vita raccontato proprio dall’autore di David Copperfield.
«Sulla porta c’era una targa ovale di vetro con le semplici parole COFFEE ROOM scritte sopra, in modo che potessero essere lette dalla strada. La conseguenza era che a me, che stavo dentro il caffè, queste parole apparivano come MOOR EEFFOC e ancora adesso il veder talvolta delle iscrizioni a rovescio mi produce una singolare scossa al sangue.»
Tomasi di Lampedusa, da par suo, insiste sull’azione deformante della realtà, uno specchio in grado d’invertire i codici della realtà attraverso lo humour, e una raffinata arte del ritratto e del paesaggio. È per questo che il figurante, la comparsa, il doppione non giocano affatto un ruolo secondario nelle vicende narrate da Dickens. Basterebbe pensare al centinaio di secondi ruoli, come il fabbro Joe Gargery, cognato di Philip Pirrip, in Grandi speranze, per determinare un repertorio convincente di questo territorio smisurato, ma come non immaginare che dopo tutto gli stessi protagonisti non siano essi stessi semplici figuranti, traghettatori di storie? Altrimenti come accettare l’idea che nel suo ultimo romanzo, incompiuto, Il mistero di Edwin Drood, il personaggio principale viva solo attraverso la propria assenza, la scomparsa. Il che non ci sorprende affatto.
In fondo cosa sarà mai un figurante se non un protagonista in potenza, un’esistenza possibile, un personaggio tutto intero e allo stesso tempo appena abbozzato. Dickens li descrive tuttavia con tale forza che i lettori non potranno esimersi dall’entrare in risonanza con essi, coglierne empaticamente il destino al punto da desiderare di saperne altro, di seguirli oltre lo steccato del tempo e dello spazio in cui l’economia del racconto li ha relegati.
La forza dell’opera dickensiana si esprime attraverso un vero e proprio vortice di passaggi, episodi, divagazioni, personaggi, che grazie al realismo deformante della sua penna generò un tale impatto sui lettori e sulla società politica dell’epoca da costringere il Parlamento inglese a legiferare sul lavoro minorile, proibire i metodi violenti in vigore nel sistema scolastico e ordinare la chiusura della prigione di Marshalsea riservata ai debitori e dove il papà dello scrittore, John, era stato detenuto. Tutte le decisioni furono prese, come dichiarato dagli stessi promulgatori di quelle nuove leggi, dopo aver letto i romanzi di Charles Dickens.
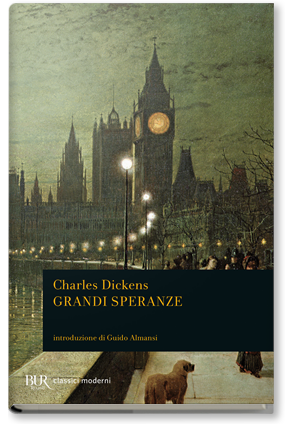
Non dovrebbe allora sorprenderci più di tanto leggere quanto Karl Marx, nel New York Daily Tribune del primo agosto del 1854, scriveva a proposito della «splendida confraternita di romanzieri inglesi le cui pagine eloquenti e icastiche hanno donato al mondo più verità politiche e sociali di quelle pronunciate da professionisti della politica, pubblicisti e moralisti messi insieme, descrivono ogni tratto della borghesia, dai detentori di capitale e beneficiari di rendite che guardano dall’alto ogni altro commercio come volgare, ai negozianti e gli avvocati».
Per capire meglio il grado d’osservazione, insieme periferico e trasversale, dell’autore, vale la pena riprendere la nota che Cesare Pavese, traduttore di David Copperfield, ci ha consegnato in un saggio consacrato a Dickens.
«Un mondo vastissimo ci viene qui evocato: borghesi, marinai, casalinghe, truffatori, semplici ragazze, avvocati, bottegai, fantesche, spostati, in un viluppo di quotidiane avventure che non escludono l’eroismo né la morte, eppure tutti quanti stanno nella reale proporzione di figurine vedute allo stereoscopio.»
Uno stereoscopio, si sa, è un dispositivo oculare a prismi o specchi in grado di dare profondità a immagini bidimensionali. La nostra infanzia si è misurata innumerevoli volte con il desiderio di afferrarne una, di quelle macchinette fotografiche di plastica appese accanto alle cartoline, in quegli innumerevoli chioschetti per turisti in mezzo alle piazze o di fronte alle torri; forse per la semplice voglia di diventare il bersaglio nel mirino che, invece di mostrare quel che c’era effettivamente davanti all’obiettivo, mostrava, scatto dopo scatto, i paesaggi monumentali che la prospettiva rendeva realistici all’inverosimile. Sarà forse un caso che l’apparecchio conosciuto con il nome View-Master portasse talvolta il nome completo Sawyer’s View-Master, come nel Racconto di Natale di Charles Dickens?

Eppure, per cogliere pienamente l’architettura di un’opera allo stesso tempo semplice e complessa potrebbe aiutarci il più singolare e romanzesco dei registi del Novecento, Orson Welles. Per capire quanto fosse grande il suo amore per Dickens basta pensare al fatto che per il programma commissionatogli dalla CBS, Classics for the masses, nel 1938 ne adatterà ben quattro romanzi, A Tale of Two Cities (25 luglio), Oliver Twist (2 ottobre), The Pickwick Papers (20 novembre) e A Christmas Carol (23 dicembre). Però sarà su pellicola che Orson Welles tradurrà quell’amore, e in particolare con Citizen Kane.
Com’è stato fatto notare dai maggiori commentatori dell’opera del regista, tra le grandi novità e sperimentazioni cinematografiche presenti nel film vi è l’uso sistematico del piano-sequenza e del campo lungo. Non che non si conoscesse come tecnica di ripresa, già dagli albori con le esperienze dei frères Lumière, ma fu ostracizzata dagli studios di Hollywood che ritenevano distraesse lo spettatore inutilmente, richiedendo inoltre un lavoro supplementare di tipo scenografico, con relativi costi, in grado di alternare primo piano e fondo della scena.
Welles fu il primo a recuperare la forza espressiva del campo lungo grazie alla genialità del suo direttore della fotografia Gregg Toland. Tale tecnica gli permetteva l’inclusione nella visione di ogni cosa e presenza sullo sfondo, periferica, ottenendo in tal modo un effetto stereoscopico. Rendere visibile, per dirla altrimenti, l’invisibile universo dei personaggi e delle cose come quando ravvisiamo attraverso lo specchio della finestra, il giovane Charles Kane nella neve alle prese con uno slittino mentre in primo piano lo spettatore assiste alla firma da parte della madre dei documenti che sanciranno la separazione dal figlio e l’affido al banchiere Walter Parks Thatcher. Il ribaltamento del piano, che di fatto sposta il protagonista sul fondo lasciando in primo piano un personaggio secondario per quanto essenziale ai fini della storia, descrive bene quanto abbiamo poco prima affermato a proposito della visione dickensiana. Del resto, sembra che Orson Welles l’abbia fatto talmente suo quel modo dickensiano di rappresentare la realtà che perfino il suo Kafka, quello del Processo, sia ancora più dickensiano del Kafka dichiaratamente dickensiano di Amerika.

A riprova di ciò basterebbe ripensare alla scena terribilmente comica dell’incontro di Joseph K con il pittore italiano Titorelli o ancor meglio le scene del tribunale dove Orson Welles riesce a portare sul grande schermo l’ironia dello scrittore praghese – contraddicendo l’adagio di Tomasi di Lampedusa secondo il quale Kafka era come Dickens ma senza humour.
Esiste un altro intimo contatto tra Charles Dickens e Orson Welles ed è la parola Rosebud. Un semplice trattino ne separa le due versioni senza alterarne la comune matrice. Rose Bud è il nome d’uno dei protagonisti dell’ultimo romanzo di Dickens, Il mistero di Edwin Drood. Il romanzo, incompiuto, e pubblicato postumo, considerato come il primo polar della storia della letteratura, ha stregato generazioni e generazioni di lettori dalla sua uscita ai nostri giorni. Rose Bud è una giovane orfanella promessa per testamento a Edwin Drood, anche lui orfano. In una città immaginaria, Cloisterham, il lettore è immerso in una storia dai toni gotici imbattendosi in un numero impressionante di personaggi, inquietanti o intriganti, caratterizzati con la precisione e grazia solite dell’autore di David Copperfield. Il mistero, lo abbiamo ricordato, riguarda la scomparsa del protagonista della storia Edwin Drood; si tratta di un omicidio? Sarà fuggito? Mistero che resterà tale poiché la morte coglierà di sorpresa l’autore il 9 giugno 1870 quando è soltanto a metà dell’opera, sei feuilletons sui dodici previsti.
La parola Rosebud la ritroveremo in Citizen Kane di Orson Welles. Kane è il rappresentante del nuovo potere dei media, Quarto potere sarà il titolo del film nelle sale italiane, e la sua tragedia è raccontata attraverso sei episodi raccontati in flashback, tragedia annunciata fin dal principio con la parola in questione Rosebud, che risuona dalla bocca in primo piano del protagonista. Come la sorte di Edwin Drood, la parola Rosebud è ammantata di mistero malgrado sia associata alla marca di uno slittino, lo stesso che avevamo intravisto tra le gambe del piccolo Charles, e che rappresenterà la fine di un’infanzia felice. Una visione dell’esistenza e del potere che si frantuma come la palla di vetro riempita di finta neve, so Christmas.
Rosebud non significa affatto, a mio avviso, la nostalgia dei tempi che furono (nei due casi un episodio di abbandono e scomparsa, il simbolo di una fine) ma l’incarnazione di quanto di più incompiuto esista per gli uomini, la risoluzione del conflitto sempiterno tra un’istanza individuale e una ragione comunitaria e sociale. Questa ferita corrisponde pienamente e più che mai alla nostra posizione nel mondo attuale, al distacco dagli altri, diventati ormai noi stessi personaggi secondari, figuranti di una storia scritta da nessuno. Il destino degli altri sembra non appartenerci più. In tal senso l’epoca che viviamo è dickensiana, ma senza la risata del romanziere. E quando il nostro sguardo incrocia quello degli ultimi, uomini e donne ai bordi delle strade dovremmo forse tenere a mente le magnifiche parole scritte da Dickens in una cronaca di viaggio:
«Io lo guardai, e guardai le tracce dei bambini nel fango, e pensai alle gocce di pioggia ed alle orme d’una certa creatura estinta secoli fa, che i geologi avevano identificato presso una scogliera; e riflettei: se questo fango potesse pietrificarsi in questo momento, e rimanere qui nascosto per diecimila anni, io mi domando se la stirpe di uomini che saranno allora i nostri successori sulla terra sapranno, da questi o da altri segni, usando per quanto possibile la forza dell’intelletto umano, privi dell’aiuto della tradizione, compiere una deduzione così sbalorditiva quale quella che esistesse una raffinata società che tollerava la pubblica selvatichezza di bambini abbandonati a se stessi per le strade della capitale e che andava orgogliosa del suo potere per mare e per terra, senza che mai facesse uso di questo potere per prenderli e trarli in salvo!» (Da Il viaggiatore senza scopo di Charles Dickens)
Allo stesso modo l’immagine di Aylan Kurdi, il bimbo che una foto avrebbe pietrificato per fissarla per sempre alle bacheche del nostro immaginario, ci fa ben temere che la vergogna ci possa sopravvivere.
Illustrazione copertina di Marta Goldin.
Questo articolo, precedentemente apparso su L’Atelier du roman, è stato tradotto dal francese all’italiano dall’autore stesso.
