«bisogna fare conoscenza, prima di tutto»
Daniele Del Giudice
A me resta da capire chi, se lo scrittore o il personaggio, a un certo punto di Un uomo sottile (Neri Pozza), sia in Canareggio 28, fuori dalla hall di Venezia Santa Lucia, diretto alla Pensione Sardegna, perché la mattina seguente ha appuntamento con Daniele Del Giudice alla Giudecca – dove è stato ricoverato malato di Alzheimer. Ho pensato sotto ci sia Eco – «leggendo romanzi sfuggiamo all’angoscia che ci coglie quando cerchiamo di dire qualcosa di vero sul mondo reale» – anche perché, sin dall’inizio di Un uomo sottile, c’è il sospetto che la soluzione al mio dubbio alimenti la recherche di Del Giudice, la provochi, la indirizzi.

DDG, alias Daniele Del Giudice, come i codici IATA, come l’ha pensato Paolo Vettori in Un uomo sottile, è il simbolo di un’operazione quantistica, il tratto di un’archeologia fisiognomica: «come i nuovi oggetti descritti dalla meccanica quantistica, l’atto stesso di avvicinarsi a DDG lo muta, lo sfarina, lo nasconde». Un’ossessione sintagmatica, di Del Giudice, che soffriva di non poter pronunciare due monemi allo stesso tempo, e, infatti, in Un uomo sottile domina il piano associativo, ciò che sta fuori dal discorso. È evidente che Vettori ha moltiplicato le trame metaletterarie de Lo stadio di Wimbledon (Einaudi), un’irrisolvibile della letteratura italiana; Vettori scrive: «mi piacerebbe lavorare sul fallimento del mio protagonista, un romanziere che insegue le sue tracce. […] Cerca di immedesimarsi in DDG, lo insegue come un cacciatore di fantasmi. È una fissazione che a poco a poco invade anche la sua vita privata, quasi una possessione letteraria».
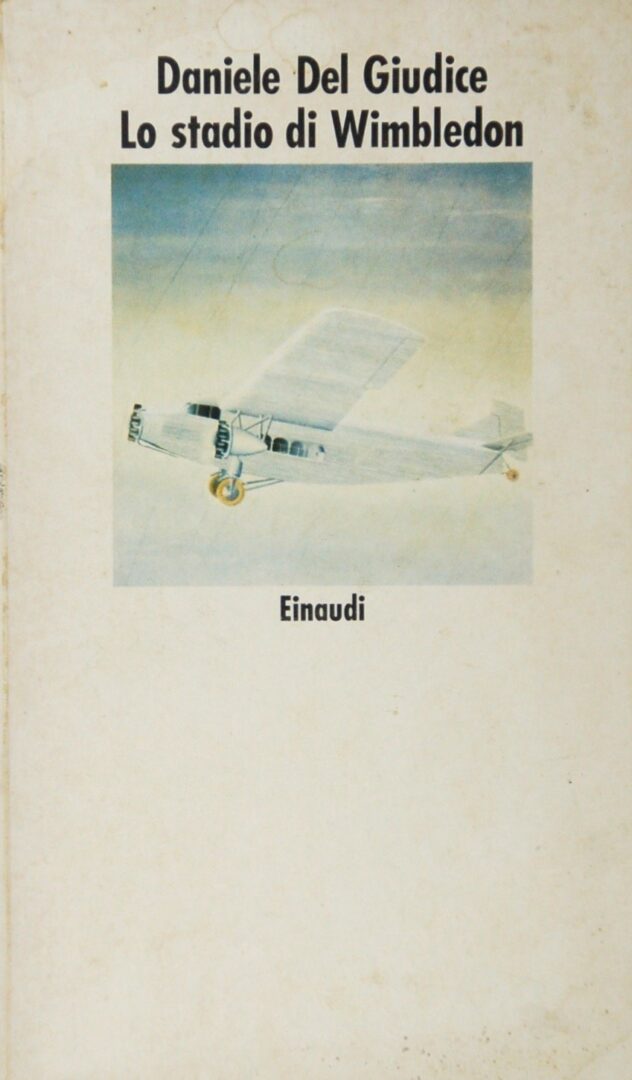
Il criterio di assimilazione di Un uomo sottile è – e sarebbe, credo – il preferito da Del Giudice: l’interazione tra cose, (in fisica) l’entanglement – «il manifestarsi di un oggetto a un altro, nel corso di un’interazione in cui le proprietà degli oggetti diventano attuali» [1] – che, in Vettori, è il propulsore di una lettura intima e rapsodica del rapporto tra Del Giudice e la cosa, lo spazio e la verità.
L’uomo senza proprietà
Ribadisco, DDG è una forma quantistica della «Krisis» della scienza moderna, ossia la desostanzializazzione, un fenomeno, a livello linguistico, iper-wittgensteiniano: qual è la rappresentazione dell’immateriale? Non lo scopro io, è l’idea di Atlante Occidentale (Einaudi), il romanzo di Del Giudice del 1985. Ira Epstein e Pietro Brahe, i due protagonisti, uno scrittore e un fisico, ne parlano al famoso capitolo undici, durante uno spettacolo pirotecnico; Epstein chiede «potrei mai invitarla a visitare dei tempi verbali, dei giunti per incastrare le frasi in modo che si tengano una contro l’altra, come per controspinta? […] Potrei dirle: una storia è fatta di avvenimenti, un avvenimento è fatto di frasi, una frase è fatta di parole, una parola è fatta di lettere? E la lettera è irriducibile?». «No, dietro la lettera c’è energia», luce, direbbe Del Giudice, «light knowledge» [2], il quoziente della deflagrazione deterministica, da cui lo scrittore romano ha fabbricato un linguaggio della scienza intesa come problema epistemologico, cioè «di come cechiamo in tutti i modi di dire ciò che con la scienza e nella scienza non sappiamo dire».
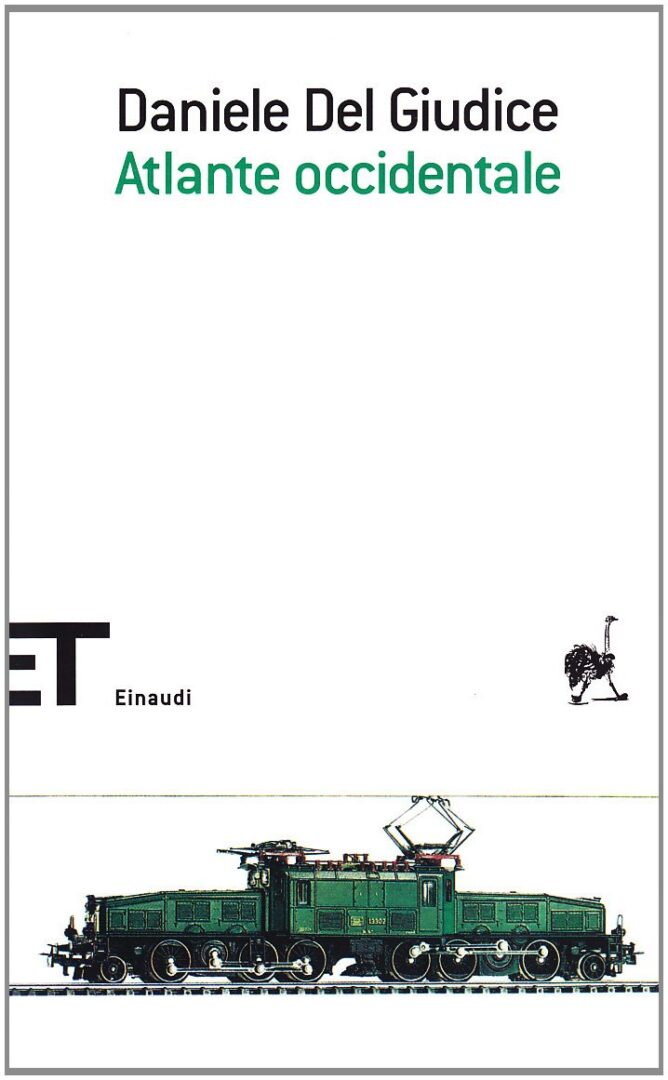
L’io «non è altro che il punto mutevole, risultato di una relazione con tutti gli altri, sul quale di volta in volta mettere il dito» [3], e la sua deterritorializazzione è il risultato dei calcoli probabilistici di Heisenberg, che contagiano persino l’oggetto (moderno), «qualcosa di ambiguo, dotato di un’opacità infausta» [4]. Il ruolo di Ira Epstein è proprio quello di essere lo scrittore che nel Novecento non c’è mai stato, che si occupi di superare la voce descrittiva: «non credo nella descrizione come forma di aderenza del mondo, ma credo nella descrizione come forma narrativa» [5]. Non ho mai creduto Del Giudice avesse interesse verso la parola-riproduzione/imitazione, ma come aggancio, inventio della realtà; ché le parole imitino il mondo è una discussione dell’uovo e della gallina. Il rigore nomenclatorio è una forma strutturalista e ha poco a che vedere con la massima calviniana dell’esattezza. Mi spiego: in Del Giudice c’è Gadda più che Calvino. Gli oggetti, cioè, diventano portavoce di se stessi, perché l’oggetto scientifico è cambiato; l’indeterminazione di Heisenberg è de re, riguarda la cosa stessa, insomma lo sappiamo, è impossibile conoscere (contemporaneamente) tempo e posizione di una particella; la reversibilità tra soggetto e oggetto è irrisolvibile, tanto quanto quella tra chi scrive e chi è protagonista di Un uomo sottile. Vettori duplica Del Giudice, aggrava la scommessa probabilistica di Atlante Occidentale.
L’uomo senza qualità di Robert Musil è l’unico romanzo nella storia della letteratura europea che condivide il tema della «Krisis» con Atlante Occidentale, e – volente o nolente – è l’impostazione di Vettori quando mette al centro di Un uomo sottile DDG, un (altro) uomo «senza proprietà». Ho sentito il prof. Cacciari per primo proporre la traduzione del tedesco Eigenschaften con proprietà e penso che isoli meglio il tema dell’immateriale nel romanzo di Musil; e di più: la proprietà è anche quella umana, del «mondo dei sentimenti», come lo chiama Cacciari in Paradiso e Naufragio (Einaudi), che, a metà del romanzo, Musil si accorge di non aver affrontato. La stessa riflessione che fa Wittgenstein alla fine del Tractatus: cosa ho detto di noi, «animali affettivi» [6]? Un uomo sottile riempie l’intercapedine, restituisce.
Ti con zero
Daniele Del Giudice è stato uno scrittore dello spazio, dell’idea Aristotelica che il vuoto è pieno; ogni luogo racchiude la suggestione di una storia, il potenziale romanzesco [7]. In un’intervista si definisce «scrittore geografo», la disciplina della rappresentazione spaziale, degli atlanti, mappe ecc., cioè di «significanti spaziali» [8]. Se Del Giudice è un autore difficile (?), è perché la diacronica ci è famigliare, a livello narrativo, quotidiano, onirico, e la diatopia (apparentemente) meno – e poi che lo spazio modifichi il tempo è insolito. È ciò che racconta Del Giudice, per esempio, in Mercanti del tempo, racconto del 2005, ambientato a Stavanger, cittadina norvegese, che Vettori esplora su street view; vuole sapere se davvero è una città «alle soglie del nulla», se Del Giudice «vede il tempo nello spazio» [9]. Il viaggio – il volo, il cronotopo dove l’emergenza è prassi – è l’epifenomeno preferito, e non è narrazione d’avventura, non è reportage, documentario, è il significante di una variazione detemporalizzata [10], non lineare, che avvicina tempo e spazio a una dimensione comune, strutturale. Vettori ha a mente i viaggi di Lo stadio di Wimbledon, ripetutiti, da e per Trieste (dov’è anche operata Laura, la moglie di Vettori), che replica nelle eterotopie di Del Giudice, e incontra i suoi personaggi. Del Giudice non è uno scrittore tutto metafora, perché la metafora è uno spazio rimestato, lì l’occhio ha fallito e anche la probabilità che l’ha formata; vedente e veduto si devono definire, con calma, c’è tempo, cioè spazio. Epstein e Brahe sono le traiettorie degli arei, dei loro occhi; la percezione è relativizzata, lo spazio non è subalterno al tempo (forse, col Calvino di Ti con zero, per la prima volta nella letteratura italiana).
Tuttavia, se ho capito bene, Vettori ha a cuore lo spazio in ciò che definisce, delimita, non in ciò che occupa. Un uomo sottile è percorso da forze invisibili, «dentro e fuori, sopra e sotto», la soggettività è irriducibile all’io. Viene in mente Dillon Bay, uno dei racconti di Mania, manifesto anti-antropocentrismo, in realtà un’illusione, forse un paradosso, che Epstein immagina un mondo senza oggetti, e vorrebbe dire senza persone, ma per Del Giudice la persona è il luogo, la forza «che forma e dà forma», nel problema cognitivo della simultaneità [11]. Oppure c’è Come cometa, che, diciamolo, è un racconto erotico, dell’avvicinamento, della crasi, sempre per ribaltare la struttura percettiva, e lo fa lo spazio, che quando è «troppo sentire» è patologia, tradimento; Bianca, la cartomante che Paolo incontra sotto portici di Piazza Castello, quando legge il racconto di Del Giudice si sente ingannata, sostituita, è la poetica della cometografia, una ripetizione, il gesto delle mani e della carte, il gioco dell’esistenza, il possibilismo dell’interazione.
Vettori ha messo insieme lo spazio dei libri e dei dolori, ha disobbedito al Del Giudice di Lo stadio di Wimbledon – «bisogna tenere i libri distinti dai dolori»; come lo fa lo racconta Gianni Montieri in un pezzo bellissimo –, ed ecco Laura, la moglie, malata, lo spazio tempo della nevrosi, della rabbia e dell’ingiustizia, di un ricordo. Sono sicuro Vettori conosca bene la differenza tra il mare triestino e quello veneziano, che da Trieste inizia e a Venezia tange. Laura è un confine, lo è DDG, due Ti con zero, due (ri)scritture di una stessa immagine.
«Lei mi piace»
Il protagonista di Nel museo di Reims (Einaudi) – il racconto più celebrato di Del Giudice – è l’ultimo personaggio a incontrare Vettori: Barnaba, un ex ufficiale della marina, visita Musèe des Beaux-Arts prima di perdere la vista, e incontra Anne, una ragazza misteriosa, che gli fa da guida; a volte mente, cambia le immagini dei quadri, pensando che Barnaba non se ne accorga. Testo e immagine raddoppiano, una lunghissima sinestesia dei temi della malattia (della cecità), della verità. Ma Barnaba a Vettori glielo dice senza giri di parole, «Paolo, tu non hai nessun bisogno della verità. Vuoi solo essere felice».

Ho l’impressione che Laura sia la personificazione del sonno, la barriera percettiva che Del Giudice attiva spesso e che Nel museo di Reims pare dietro l’angolo. La con-fusione tra Laura e DDG è drammatica, lo è il rapporto tra Barnaba e Anne, in generale il sentimento di Un uomo sottile, l’intercapedine di cui dicevo, quando scopri «di essere uguale a un tuo personaggio» e sembra un film di Wim Wenders. Se è una menzogna, è una bugia «del collegamento» – di Anne –, dell’interazione con l’uomo, che struttura la comunicazione stessa, tra Laura e Paolo, vittima del mondo afasico della moglie, come lo è stato Del Giudice (di se stesso) negli anni della malattia.
Insomma, se ho capito bene, si tratta di unire i punti, trovare la geodetica, cioè il tragitto più breve, tra A e B, in Fino al punto di rugiada, la short story più bella di Del Giudice. E Vettori, dopo aver dormito alla Pensione Sardegna, davanti alla porta della stanza di Del Giudice, torna indietro. Perché Il fallimento è il carattere dell’utopia, di Vettori in Un uomo sottile, per Del Giudice della modernità – la menzogna più grande? Forse, dei tempi verbali, che Del Giudice, in tutti i modi, riconduce al presente. L’ennesima ossessione – per una nostalgia del passato? –, perché le persone solo al presente non esistono, e per questo lo stupore, di come «lei mi piace» – sul mare, un altro ancora, a Rimini, Paolo davanti a Laura – corrisponde a qualcosa, qui e ora, tra me e te, «basta lasciarsi attraversare» [12] dal limite della rappresentazione.
[1] Carlo Rovelli, Helgoland, Adelphi.
[2] Cfr. Anna Dolfi, La Light Knowledge di Daniele Del Giudice, in La realtà e i linguaggi.
[3] Daniele Del Giudice, La conoscenza della luce in In questa luce, Einaudi.
[4] Roland Barthes, Il grado zero della scrittura, Einaudi.
[5] Pierpaolo Antonello, La verità degli oggetti: la narrativa di Daniele Del Giudice fra descrizione e testimonianza, in Annali d’Italianistica.
[6] Daniele Del Giudice, Occidente Europa, in In questa luce, Einaudi.
[7] Cfr. Del Giudice, Stevenson. Il tesoro ritrovato, in Corriere della sera, 9 dicembre 1990.
[8] Cfr. Algirdas J. Greimas, Per una semiotica topologica, in Semiotica e scienze sociali.
[9] Camerino M., Daniele Del Giudice: narrazione del luogo, percezione dello spazio, in Strumenti Critici.
[10] Cfr. Cornelia Klettke, Attraverso il segno dell’infinito. Il mondo metaforico di Daniele Del Giudice, Franco Cesati Editore.
[11] Bruno Mellarini, I paesaggi in movimento, in Luce e ombre, leggere Daniele Del Giudice.
[12] Intervista a Daniele Del Giudice, a cura di Camerino M. C., in Verri.
