A quarantanni dalla sua pubblicazione, Morte nella terra promessa dello storico Scott Ellsworth risulta uno dei testi più completi e approfonditi su una pagina tra le più oscure della storia americana: il massacro di Tulsa del 1921, sanguinosa rappresaglia della comunità bianca locale contro i concittadini afroamericani per un mai accertato fatto di cronaca. L’edizione italiana curata da Mimesis (2022) si inserisce in quel filone di scoperta o riscoperta della storia e cultura nera statunitense, fenomeno dell’industria culturale globale che riconosce nel cinema, letteratura e saggistica black un valido strumento di analisi di problematiche e dinamiche inerenti il vivere comune nelle odierne società multietniche. Non che l’esperienza statunitense sia applicabile a ogni contesto estero, ma senz’altro può essere specchio di analoghe questioni nei singoli scenari locali. Una riproduzione in scala maggiore di simili, se non medesimi, fattori che contribuiscono o più facilmente minano un ideale progresso comunitario incentrato sul dialogo e il rispetto delle proprie e altrui diversità. La realtà nera americana diventa così un ideale riferimento a cui guardare e attingere per meglio comprendere la complessità e le difficoltà di un vivere comune possibile pur se ostico, basato sulla consapevolezza di ciò che è stato e sulla volontà di impedire che si ripeta oggi.
Se il tragico episodio è entrato nell’immaginario collettivo tramite canzoni, romanzi, saggi, drammi teatrali, documentari e serie-tv (Watchmen, 2019, parte proprio da quella vicenda), parte del merito va senza dubbio al lavoro di Ellsworth, uno dei primi a riportare alla luce l’evento non come caso a sé bensì inserendolo nel più complesso insieme di forze razziali, sociali, economiche e culturali che «plasmavano Tulsa e l’America nel 1921 e che, in realtà, le modellano ancora oggi». Il massacro nella cittadina dell’Oklahoma diventa allora l’inevitabile conseguenza di un sistema di violenza e repressione che tutelava e tutela una precisa gerarchia etnica su cui il Paese ha costruito la propria identità e patrimonio esperienziale, condiviso e spesso subito in forme più o meno dirette.

Incrociando testimonianze verbali e scritte, articoli di giornali locali e documenti pubblici e privati, l’autore presenta così un mosaico complesso e articolato degli eventi, dando spazio alle diverse voci e versioni, spesso opposte e divergenti, in una narrazione che va oltre le singole letture e interpretazioni in cerca di una verità storica non assoluta ma la più completa e autentica possibile.
Ricostruendo nei primi due capitoli la realtà economica e sociale della città americana negli anni del suo boom (1890-19210), Ellsworth rintraccia nell’espansione demografica dovuta alla corsa alla terra e nei grandi giacimenti petroliferi lì trovati i principali fattori della rapida espansione urbanistica di Tulsa. Nasce così una nuova comunità multietnica, composta da nativi americani, neri e bianchi pur se separati in specifici quartieri secondo le norme segregazioniste in vigore al tempo. Sorprende in particolare la presenza di un numeroso ceto borghese afroamericano affianco a quello proletario di braccianti, domestici e lavoratori semplici. Negli anni di rapido sviluppo, il quartiere nero era diventato una città nella città, con le sue scuole, un ospedale, giornali, tredici chiese, due teatri e una biblioteca, oltre a esercizi commerciali e studi professionali. Uno sviluppo in linea con quello del Paese ma inversamente proporzionale al livello di tolleranza della maggioranza bianca, che l’ha ostacolato e limitato con atti intimidatori e linciaggi. Sono gli anni del cosiddetto “secondo” o “rinato” Ku Klux Klan, i cui 3200 membri tra repubblicani e democratici – alcuni anche investiti di cariche istituzionali – hanno sistematicamente alimentato con tali pratiche la propria ideologia, sostenuta e difesa anche dalla stampa più reazionaria.
Lo spaccato offerto da Ellsworth fa dunque del massacro di Tulsa – due giorni di guerriglia che misero a ferro e fuoco la città, coinvolgendo forze dell’ordine e Guardia Nazionale e provocarono 39 morti accertati e oltre 800 feriti, per lo più afroamericani – il vertice di un sistema che impunemente faceva il gioco dei rivoltosi, ostacolando ogni possibile forma di tutela da parte degli assaliti. E questo anche nella successiva fase di ricostruzione e le relative politiche di sostegno, un sistema ideato per ostacolare la ripresa delle attività gestite da neri ed elaborare un piano di acquisto e conversione dei quartieri devastati al fine di impedire il rilancio economico e sociale della comunità afroamericana. Infine i processi farsa che condannarono un solo nero per supposto possesso di arma da fuoco e nessun bianco per assassinii, incendi e razzie avvenuti in quelle giornate.
Con la sua indagine storica, l’autore decostruisce allora il pensiero diffuso secondo il quale sia stata la volontaria autodifesa armata dei neri di Tulsa a provocare la reazione dei concittadini bianchi, quasi fosse un reato cercare di proteggere ad ogni costo sé stessi e i propri affetti. L’ampia riflessione conclusiva sulle azioni e reazioni relative alla memoria storica, tanto sgradevole da finire per essere riadattata secondo a una sua versione più accettabile, pone così l’accento su una grande problematica ancora attuale negli Stati Uniti, «la raffinata capacità propria di molti americani di attribuire la colpa del razzismo e delle ingiustizie razziali conseguenti ad altri.»
In America, come nel resto dell’occidente multietnico, la capacità di fare lo scaricabarile è una via pratica per «affrontare, o meglio, non affrontare, il proprio passato» e di conseguenza i problemi a esso connessi che si ripresentano ancora oggi in tutta a loro irrisolta complessità. Negare, nascondere o ignorare gli eventi e le responsabilità singolari e collettive è l’espressione di una volontà di rimozione della memoria e della cultura da essa derivata e alimentata. Un fenomeno che la coscienza storica da sempre contrasta ma che la Storia ha dimostrato può ripetersi ciclicamente.
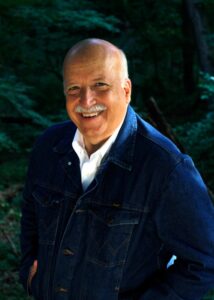
È quanto accade oggi con l’etichettatura “cancel culture” usata da una certa parte del mondo intellettuale statunitense e non solo, scandalizzata dalla recente protesta afroamericana che chiede la rimozione di monumenti dedicati ai generali sudisti protagonisti della Guerra di Secessione. Perché non ci sono stati analoghi interventi contro la rimozione, ad esempio, di statue di sanguinari dittatori europei e non dalla seconda metà del Novecento a oggi o contro le nuove destinazioni d’uso di monumenti o edifici storici? L’indignata ondata di scalpore pare allora manifestare una diffusa incapacità e indisponibilità da parte di una maggioranza a mettere in discussione sé e la propria avvantaggiata posizione sociale: ciò che turba sembra essere che una minoranza avanzi diritti, oltre che rispettare i propri doveri, venendo così a ledere il tacito accordo di superiorità almeno morale che relaziona le due parti. Risulterebbe evidente altrimenti la legittimità di tali richieste – forse tardive? Ma si sa, i processi storici seguono sempre dinamiche temporali diverse da quelle del quotidiano – che investono i prodotti di una cultura sì vicina ma di parte, e non collettiva, costruiti a posteriori a ribadire con fermezza un’ideologia che il tempo e il progresso sociale non possono superare. È il negare questo con atteggiamenti di preoccupato allarme il vero atto di cancellazione, il tentativo di modellare l’opprimente passato collettivo bollando come estremismi le posizioni contrarie. Una «segregazione della memoria» a cui l’esperienza di Tulsa fa da esemplificativo contraltare.
