Tre donne, Quintana, Leona e una misteriosa Ragazza Sfinge incrociano le loro vite nel romanzo di Francesca Marzia Esposito Materiali resistenti (HarperCollins, 2025), tutte e tre sopravvissute a un abbandono. «Tre donne sconosciute, ognuna sulle tracce di un uomo che le infesta la mente […] in balia di un amore scomparso […] che non le cerca, non le desidera […], avvinghiate al passato, alla ricerca furiosa di qualcosa, di qualcuno inesistente».
Sullo sfondo, una città, Milano, imbruttita dai graffiti, invasa dalle pareti bucherellate che recintano i lavori in corso, «con il cielo di gesso che si spegne nella finestra», dove l’aria «è diversamente respirabile» ma i raggi del sole «si spandono dentro il torace slucchettandomi i chakra», concedendo alla protagonista l’illusione di sbloccare la sua energia vitale per trovare finalmente un equilibrio tra corpo, mente e spirito. Verso la fine, Milano è sconvolta da una tempesta, battuta da una pioggia sempre più fitta, «un flusso continuo, percussivo, aritmico (che) pressa sui timpani, pulsa nelle orecchie […] Piovono sassi. Tutte le gocce del cielo sono diventate pietre che si abbattono al suolo. Una tempesta di grandine tartassa i vetri. […] Guardo il castigo di Dio che si sta compiendo e mi prende una paura muta al centro del petto. Non c’è scampo per nessuno, penso. Non c’è difesa, ci stermineranno tutti».
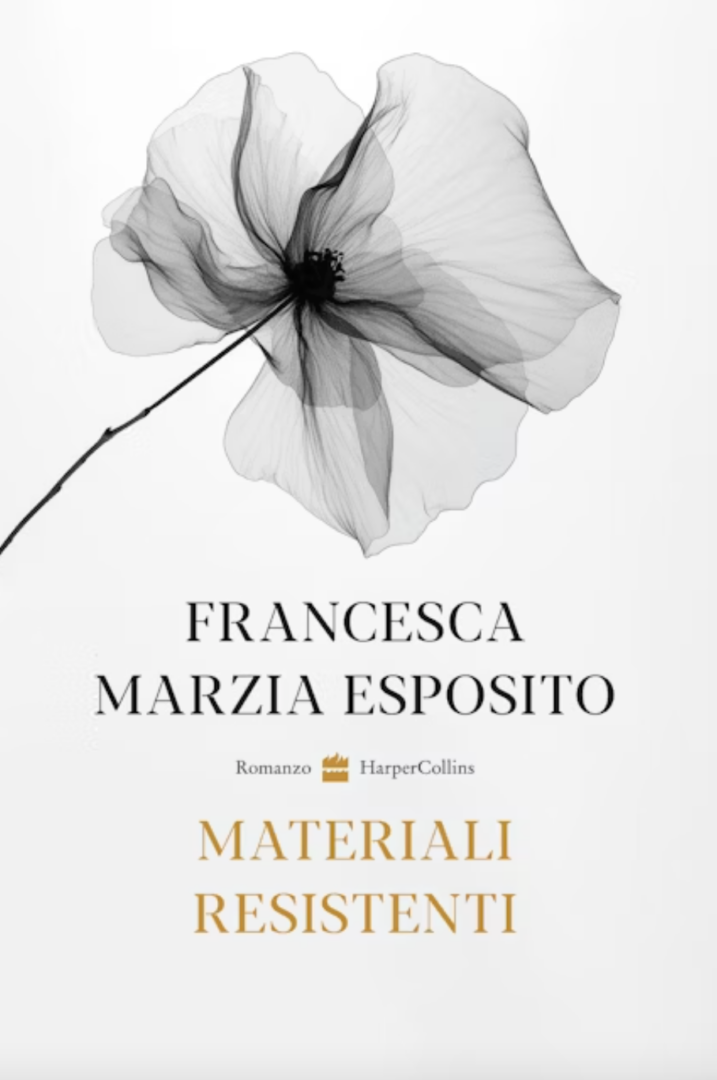
Se un uomo, nel senso di maschio, vuole entrare in questa storia coinvolgente e profondamente femminile, deve trasmigrare in una sorta di altra coscienza, predisporsi all’ascolto della voce narrante, osservando quel che avviene nel racconto senza pregiudizi. Può un uomo, mi sono chiesto alla fine della lettura, evitare di sovrapporre la sua prospettiva, per forza condizionata, a quella della protagonista quando proprio lei sembra incapace di trovare uno spazio di comprensione e di comunicazione con l’universo maschile? L’ex fidanzato Mauro che, apprendiamo, Quintana ha lasciato da tre mesi – perché «non gli piacevo più» e «quando si diventa oggetti asessuati agli occhi dell’altro?» – è tratteggiato in modo volutamente sbiadito ed è un riflesso o un mezzo attraverso il quale la protagonista esplora il proprio malessere. Mauro, «un’entità dardeggiante sospesa in un magma rovente», non è sviluppato come un personaggio autonomo e tridimensionale, è una figura sempre sullo sfondo, “un ologramma”, ed è paradossale perché la protagonista dice – senza però crederlo veramente, o almeno questo è quello che arriva al lettore – che è da lui e dalla fine della relazione con lui che dipende il suo disagio profondo.
Ma anche gli altri personaggi, Leona per esempio, sembrano delineati per rappresentare l’incapacità di una connessione della protagonista con il resto del mondo. Quintana è il vero centro di gravità del romanzo e si prende tutto lo spazio narrativo. La sua voce, i suoi pensieri, le sue turbolenze emotive sono il muro di incomunicabilità autistica in cui è intrappolata. Dopo la fine del rapporto con Mauro e la morte di Agata, una vecchia che le ha lasciato in eredità due case, tra cui quella in cui Quintana è in affitto, è come colta da una masochistica forma di dipendenza dal dolore e, più che superare l’abbandono, sembra desiderare di prolungarlo all’infinito; a volte non vede l’ora di guarire, altre le interessa solo «che la febbre continui a salire», perché considera questo crogiolarsi l’unico modo di chiarire e di comprendere la sua permanenza nel mondo. Va dal terapeuta ma: «Che gli dico, che gli dico, che gli dico. Come se dovessi sostenere un esame all’università»; è sempre in cerca di quiete: «che sollievo tornare nel proprio tugurio e barricarsi dentro. Una tregua dal mondo»; «seduta sul pietismo», «stanca dell’abbastanza, del tutto sommato, del va bene comunque»; perché «da tutto ci si può difendere tranne che dalla tentazione di essere sé stessi».
Francesca Marzia Esposito procede nella narrazione a colpi di machete, perché la quotidianità di Quintana è una giungla dove tutto è difficile, la vita è «prestazionale» e la bellezza «sta lì, mettersi in competizione con sé stessi e battersi in curva», il cibo è schifoso, i tranci di pizza «si ingollano», oppure «si calano nelle fauci spalancate tipo missile in base quattro», lei «scolla mozzarella collosa dal suo disco di pasta», ne fa «una pallina biancastra unta» e se la rigira tra le dita; tutto intorno «è cemento a perdita d’occhio» e a lei pare di essere «l’unica persona sulla faccia della Terra». Se sul pianeta e nella città che Quintana abita – ma senza vederli, così occupata a processare (un verbo usato più volte) il suo tormento interiore – c’è qualcuno, sono gli attivisti Pro-Cement che reclamano «soluzioni efficaci, non pianticelle! Si al cemento! Il cemento è il vero green!». Lei è «un esercito composto da un solo cristiano» nel compito di «annotare come mi sento, che cosa provo» della sua battaglia senza tregua.
C’è nel libro un uso reiterato del corsivo, per l’urgenza di dare pregnanza al pensiero e avvertire il lettore, una sorta di riflessione sul linguaggio: la voce narrante è alla ricerca di una strada per comunicare e sente il bisogno di alcune sottolineature, più adeguate a catturare la complessità del suo vissuto, dove le parole ordinarie sembrano incapaci di contenere quella (corsivo mio) realtà: ciò che è detto ha bisogno di uno scarto per avvicinarsi al vero ma quello che leggiamo, sembra avvertire l’autrice, va preso alla lettera.
Materiali resistenti potrebbe essere catalogato tra gli esempi di narcisismo letterario, una lunga autoanalisi che disturba l’universalità dell’esperienza, confinandola nell’elaborazione di un male oscuro che appartiene alla protagonista ma solo a lei. È un tipo di scrittura che riflette una tradizione consolidata nella letteratura femminile contemporanea, in cui la storia personale, materia prima per l’analisi psicologica, fatica però a collocarsi nel sociale, rimanendo imprigionata nella dimensione intima e rinunciando a farsi discorso politico. Per una lettrice questo esercizio di autocoscienza reiterata è forse un punto di forza, per un lettore maschio è una sfida a confrontarsi con una prospettiva che gli è meno familiare.
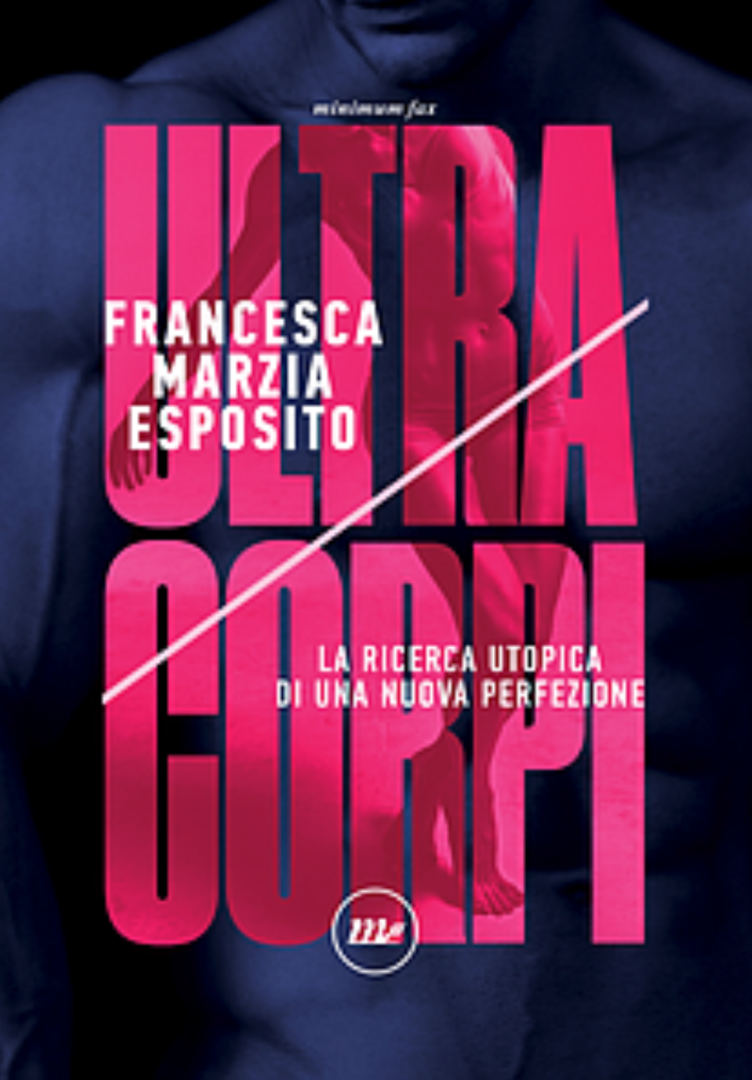
Riprendendo in mano Ultracorpi (Minimum Fax, 2024), il saggio recente di Francesca Marzia Esposito sui corpi estremi (quello anoressico e quello ipernutrito dei culturisti) salta agli occhi la materialità con cui è stato costruito, procedendo per accumulo. Materiali resistenti ha invece un’architettura astratta, se questo aggettivo può contribuire a spiegare una struttura che antepone le sensazioni, gli stati d’animo, le riflessioni all’azione e alla trama, creando una sorta di spazio mentale che avvolge il lettore, piuttosto che un percorso narrativo lineare: essere donna per Quintana è la condanna a essere relegata nella dimensione privata, dalla quale per altro non sembra per nulla intenzionata a uscire, anzi, la reclama, in opposizione al mondo fuori che incombe minaccioso. Se in Ultracorpi Esposito sceglie l’approccio opposto e il corpo materico diventa il centro della riflessione, in un saggio che accumula dettagli, esempi, dati, storie, un affondo nella materia che restituisce la fisicità dell’argomento, Materiali resistenti vive più di atmosfere che di cose che succedono, più di sentimenti che di azioni. Questa doppia anima – da un lato la scrittura aforistica e sospesa, molto assertiva, di Materiali resistenti, dall’altro la concretezza quasi ossessiva di Ultracorpi – riflette due modalità diverse di affrontare il reale: una riluttanza a fissarlo nella narrativa e, invece, un bisogno di affondarci dentro nel saggio.
Francesca Marzia Esposito, una delle voci più interessanti dell’attuale panorama letterario, ha scritto tutti e due i libri ma sembra due persone differenti: l’autrice di Materiali resistenti ci racconta con dovizia di particolari come si sente, quella di Ultracorpi ci dice che cosa sa: da questo un lettore maschio trae insegnamento; in quell’altro prevale la sensazione di sentirsi un intruso.
