Paolino Rasura è cresciuto, ora si chiama Paolo ed è un uomo disilluso. Torna alle origini, alla natìa Santafarra, luogo d’infanzia che ha ormai perduto il proprio incantesimo, con una consapevolezza diversa. Filippu de li Testi, il suo mentore, la sua guida, è morto.
«Gli uomini se ne vanno e la terra rimane» il vecchio detto caro allo scultore assume nelle pagine di Malotempo (minimum fax, 2025) una concretezza effettiva e nostalgica sulla quale si incardina la storia. Il Giardino di Filippu, che custodisce le teste di pietra realizzate dall’artista, sta per essere venduto per lasciare spazio alla nuova superstrada: tutto cambia, la modernità avanza inesorabile sulle rotaie d’acciaio del progresso, senza badare alla malinconia – tutta umana – del tempo che fu.
Dopo Pelleossa (minimum fax, 2023), Veronica Galletta torna a narrarci la storia di una terra, la Sicilia, e delle sue genti attraverso uno sguardo più consapevole, in cui la favola mitica dell’infanzia cede il posto all’amarezza, talvolta venata di sconforto, che caratterizza l’età adulta, perché «crescendo si impara l’insoddisfazione». Paolo non è più Paolino, ma tornando al paese, ritrovando le persone di un tempo, cerca di ricordare il bambino che è stato; anche se ora le teste del giardino di Filippu – personaggio iconico, ispirato al reale scultore siciliano Filippo Bentivegna – non gli parlano più, deve fare uno sforzo d’immaginazione per sentire le loro voci. L’aura mitica del luogo continua a suggestionare, forse perché i luoghi da cui veniamo non ci lasciano con la stessa facilità con cui noi lasciamo loro: il Giardino di Filippu de li Testi rimane uno spazio incantato, anche in assenza del suo creatore, e Paolo adulto fa i conti con i rimorsi, con il vuoto del lutto, sprofonda negli abissi del rimpianto, mentre altri bambini ora corrono e giocano tutt’attorno, vivaci e rumorosi, facendosi beffe del futuro.
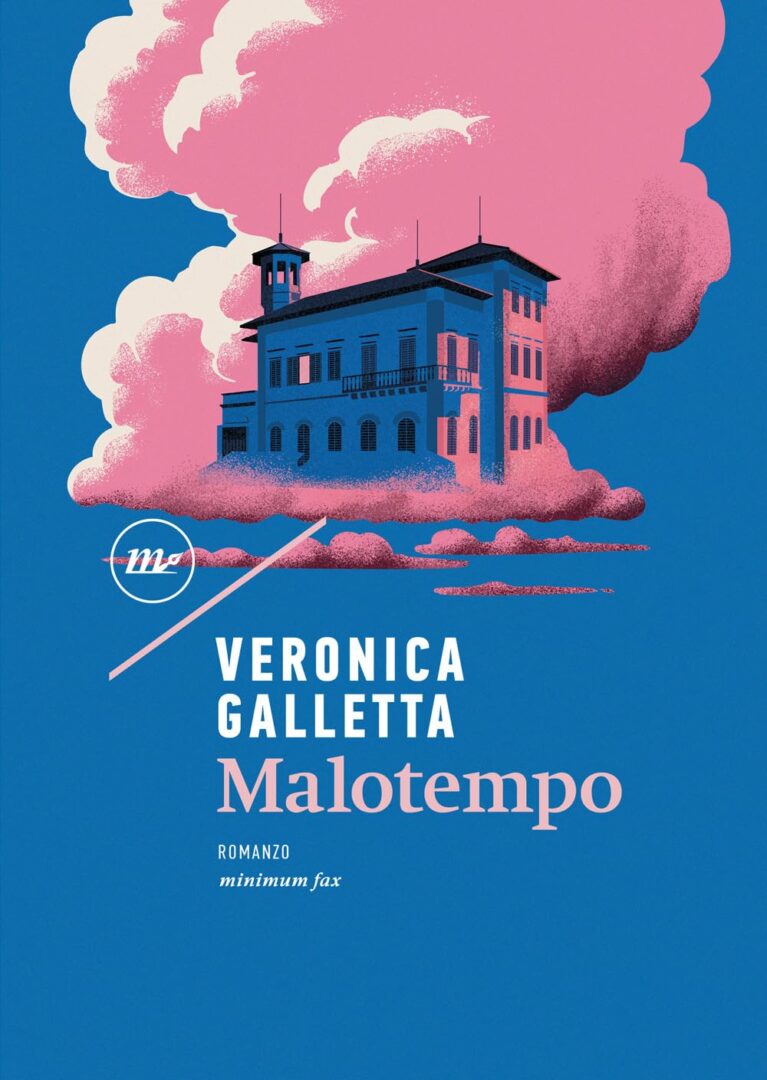
L’avevamo lasciato bambino nelle pagine di Pelleossa, mentre stringeva la mano salda di Filippu e con lui si avviava verso l’orizzonte sulla via del tramonto, andavano insieme incontro alla sera come ne Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini. «Mi piacciono le fiabe, raccontamene altre» dice il bambino al vecchio e in quel desiderio è contenuto l’abbandono tipico dell’infanzia, la gioia di naufragare nella fantasia, senza argini o freni. Non voglio che le cose finiscono, aveva detto Paolino nell’ultima pagina di Pelleossa e, adesso, quella frase appare come un presagio, perché Malotempo inizia proprio con una fine irrevocabile: Filippu è morto e Paolo ritorna per partecipare al suo funerale. Il senso di perdita e disfacimento aleggia incontrastato fin dalla prima pagina; forse è così che diventiamo adulti, perdendo le cose.
Paolo Rasura arriva alla stazione, ha un bagaglio leggero che traduce la ferma volontà di fermarsi appena per pochi giorni. «Domani torno a Palermo» è il ritornello che puntella la storia, scandendone il ritmo dal principio alla fine, come se la vita di Paolo fosse divisa a metà tra due luoghi: Santafarra è il regno dell’innocenza, mentre la città di Palermo rappresenta l’età adulta con il suo carico di guai e responsabilità, l’inevitabile che lo attende al varco. Ha una famiglia adesso, una moglie e due bambini; e un lavoro che non ama. Lo chiamano Pittore, ma non fa altro che dipingere le fondamenta dei carretti siciliani, ha perso la fantasia.
«Devo tornare a Palermo» continua a ripetere Paolo e intanto si trattiene nel limbo, senza partire né tornare davvero, come se avesse un conto in sospeso con sé stesso – o con il destino. A Santafarra la voce-guida di Filippu continua a parlargli attraverso i luoghi, gli oggetti e le lettere d’amore destinate a una certa Meri che vive laggiù in America, al di là del mare. Paolo farnetica di partire alla ricerca della donna-fantasma, di inseguirne l’incanto come un topolino con il pifferaio magico; una speranza, quella di ritrovarla, che sfuma nella follia. «Perché sei voluto venire qua? Per riprendere dei ricordi?» domanda a un certo punto il barbiere, ormai anziano, Michele Lèggio, mentre guardano il mare.
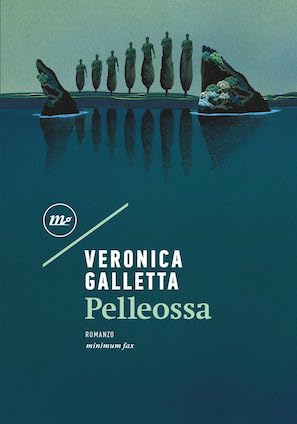
Paolo senza volerlo indugia nel «pensiero magico» che non gli fa accettare la morte e sente di dovere ancora qualcosa al vecchio Filippu – considerato pazzo dalle malelingue, ma che era «solo tanticchia originale» – come se soltanto a lui ora spettasse il compito di tutelarne la memoria, perché appunto «gli uomini se ne vanno, ma la terra rimane». Pelleossa era una storia di nomi, mentre Malotempo è una storia di luoghi e della maniera in cui le persone li abitano. Lo testimonia anche l’accurato apparato paratestuale del romanzo: Pelleossa conteneva in appendice i nomi dei numerosi personaggi, divisi per famiglie di provenienza; mentre Malotempo è corredato da una mappa di Santafarra, che ci mostra la fervida toponomastica immaginaria di questo lembo di terra allungato sul mare «come una lucertola», che in fondo è come ogni paese, anche se ogni paese ci pare essere l’unico.
In Malotempo le case sono umanizzate, hanno dei soprannomi che le identificano, come Il Tabbuto «una casa di linee dritte, nessun recinto intorno» e Sciacquarosa che «sembra l’incubo di un matto», ciascuna abitazione riflette la personalità dei propri inquilini e forse, in qualche maniera, contribuisce pure a plasmarla. Il tema gotico della «casa stregata» è particolarmente rappresentativo dell’originale operazione narrativa compiuta da Veronica Galletta: ogni luogo è sospeso nel proprio incantesimo, finché dura. È indicativa in questo senso la citazione posta in esergo, tratta da L’incubo di Hill House di Shirley Jackson nella traduzione di Monica Pareschi: «Nessun organismo vivente può mantenersi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà» ed ecco che la toponomastica mitica di Santafarra ci parla con il linguaggio segreto dell’immaginazione, che è poi lo stesso custodito nelle «teste parlanti» del Giardino di Filippu, uno dei luoghi fantastici più belli e simbolici creati dalla letteratura italiana contemporanea. In quel giardino solitario è racchiusa l’innocenza dell’infanzia, con il suo Eden paradisiaco di illusioni perdute. Malotempo è una storia di «cieli neonati» e di terre che si fanno teatro della memoria, custodendo intatto il ricordo degli uomini che le hanno abitate.
Il tema del «ritorno», topòs letterario omerico, non a caso apre il libro: Paolo torna a Santafarra compiendo il movimento opposto al viaggio dell’eroe, poiché è partito per realizzare sé stesso e, in cuor suo, sa di aver fallito. Il bambino solitario e prodigioso è diventato un adulto irrisolto e infelice, dopotutto:
«Le persone che stanno scomode, non sono mai felici».
Si avverte un’eco morantiana in queste parole, subito ritorna alla memoria come un’onda la celeberrima citazione:
«Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né contentezza; e mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua, e appena tornati qua, subito hanno voglia di scappar via».
L’isola di Arturo di Elsa Morante diventa paradigma letterario della Santafarra immaginaria di Veronica Galletta: è la terra mitica dell’infanzia, il luogo dove sopravvive intatto il “fanciullino pascoliano” celato in ciascuno di noi. Attraverso la parabola del ritorno, Paolo torna a essere Paolino, N’cantesimo come lo chiamavano, «tutto muta per assomigliare a chi ci ha preceduto, e invece lui è lo stesso bambino incerto di vent’anni prima. Si sente svanire». Paolo Rasura, proprio come Arturo Gerace, vive tra le case dei pescatori e cerca sé stesso in un giardino incantato; solo che Paolino, al contrario dell’eterno fanciullo dal nome di una stella, è cresciuto. Santafarra, come la Procida di Morante, diventa co-protagonista della storia, evolvendosi assieme al suo protagonista: da mondo fatato, la cui sottile irrealtà occultava lo spettro oscuro della guerra, si tramuta in un terreno di speculazioni edilizie dove la corruzione mafiosa regna sovrana, sino a che tutto crolla come un castello di carte. L’incantesimo della giovinezza – rappresentato attraverso la metafora delle teste parlanti – è destinato a sgretolarsi sotto il peso della realtà.
Cosa sarebbe accaduto all’Arturo di Elsa Morante se fosse tornato nella sua isola? Questa storia non ci è mai stata raccontata, poiché la partenza di Arturo da Procida indica l’attraversamento di una soglia necessaria, il confine tra infanzia e maturità. Malotempo di Veronica Galletta ci narra proprio questo passaggio, senza tacere le crepe e i punti di rottura che esso porta con sé: è un libro sulla fine delle illusioni, in cui l’atmosfera fiabesca viene sostituita dalla narrazione implacabile e scandita del tempo che avanza. L’apparato paratestuale ci offre una chiave di lettura preziosa. Ogni capitolo identifica un giorno preciso (e irripetibile) del calendario – dal 27 dicembre 1967 al 16 gennaio 1968, scandendo la permanenza di Paolo a Santafarra, sino alla data simbolo che contrassegna l’Evento. Si intreccia così, in un nodo inestricabile, narrazione fittizia e vita vera.
La Storia fa il suo ingresso prepotente nelle ultime pagine del romanzo, in cui il significato del titolo si rivela appieno, segnando una chiusa che è anche metaforica: Paolo Rasura partirà per Palermo soltanto quando anche l’ultima illusione sarà crollata.
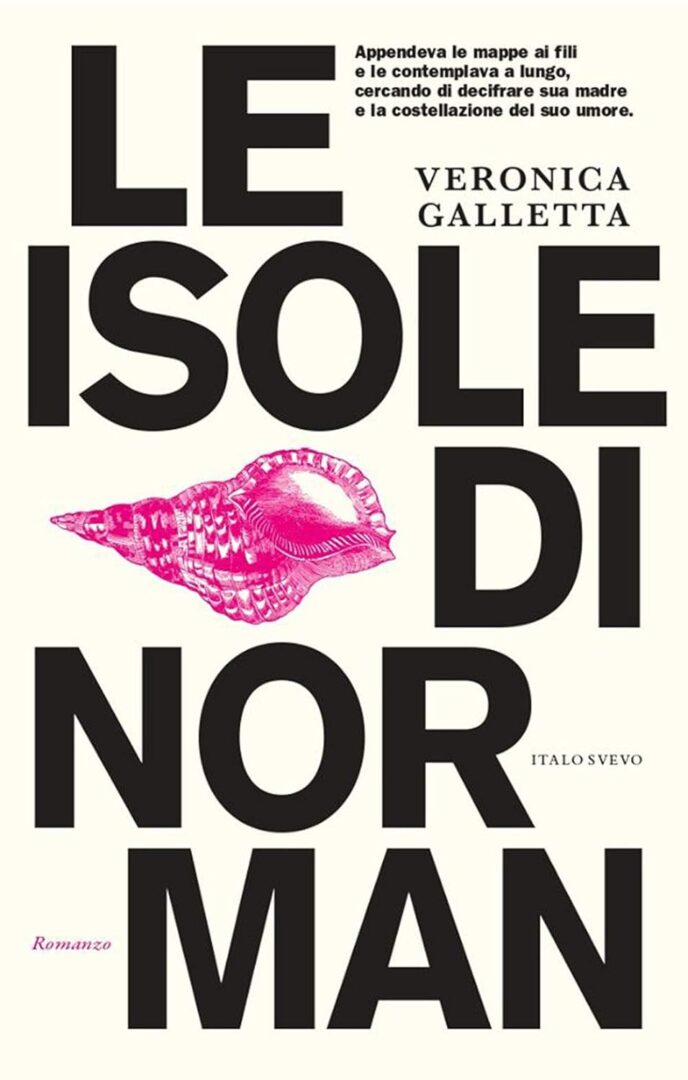
Veronica Galletta prosegue il suo lavoro sperimentale sulla lingua, iniziato con Le isole di Norman (vincitore del Premio Campiello Opera Prima nel 2020), annodandolo a doppio filo alla storia siciliana. Il primo libro dell’autrice si concludeva con l’attentato a Giovanni Falcone, mentre Pelleossa narrava la Sicilia della Seconda guerra mondiale dopo lo sbarco degli alleati: ora l’autrice compie il passo successivo, narrando la corruzione mafiosa degli anni Sessanta e un evento terribile quanto inatteso, che ancora si conta e si racconta sino a trasformarlo in leggenda con la capacità che hanno poi le storie di definire i luoghi e le loro atmosfere. Il linguaggio di Malotempo è cangiante, sapientemente governato, l’uso del dialetto siciliano – rispetto a Pelleossa – appare più controllato, vi si mescolano anche altre lingue, come lo spagnolo parlato da Francisco Gallo, a conferire poliedricità a una narrazione che fuoriesce dalle pagine e si adatta al parlato, con l’aderenza di un racconto orale.
La tradizione novellistica verghiana nutre la prosa nei momenti in cui ancora brilla, in tutto il suo splendore, l’aggettivazione abbondante, la sintassi articolata e lo stile aulico («Nella luce del tramonto è tutta rosa, e sente un moto d’affetto per questa terra, che sua madre e Calogero sono riusciti a non vendere, a tenere unita»); a tutto ciò si aggiunge il ritmo, la musicalità inconfondibile della scrittura di Galletta che permette alla storia di avanzare, con un’impronta quasi favolistica, sino al suo finale.
«Ma no Meri, non t’angustiari. Tutto furrìa, ma iu sugnu un uomo di petra, solido. (…)Trent’anni passaru, Meri mia adorata, ma l’amuri è per sempre, e lascia tutto com’era, come i tuoi occhi brillanti, a ucca odorosa».
L’eredità popolare de Il Cunto de li Cunti di Giambattista Basile era già tangibile in Pelleossa, suddiviso in capitoli dai titoli fiabeschi, ma in questo secondo libro assume una vivace sfumatura lessicale. Leggendo scopriamo il piacere di lasciarci trascinare da un uso più originale della parola: la sonorità del dialetto siciliano a tratti si fonde con l’argentino e lo spagnolo, senza tuttavia tradire il perfetto costrutto formale, dimostrandoci che la lingua è un processo in continuo divenire, una commistione di culture e di popoli, come del resto rivelano le sue origini antiche. La mescolanza sonora ci ricorda (e ravviva) l’influsso della cultura araba sul siciliano corrente.
I personaggi di questo libro si identificano nel loro linguaggio sino a farne una propria estensione: loro sono le parole che dicono, le parole rappresentano anche la loro eredità; ma non solo.
In Malotempo Veronica Galletta riesce a far parlare i luoghi, servendosi di una prospettiva singolare: ci dimostra la maniera in cui i luoghi ci abitano, dando corpo attraverso la scrittura ai movimenti sismici, quasi impercettibili, della terra e dell’anima.
In copertina: Foto di Brett Jordan su Unsplash
