Fuma la franciaccesa fiaccola della comédie de mœurs. A reggere il tizzone, la piromane veterana Yasmina Reza, i cui canovacci ardono di teatro in teatro (spesso, pure sul grande schermo). Risa da sputafuoco, fatte apposta per incenerire una Bella figura?
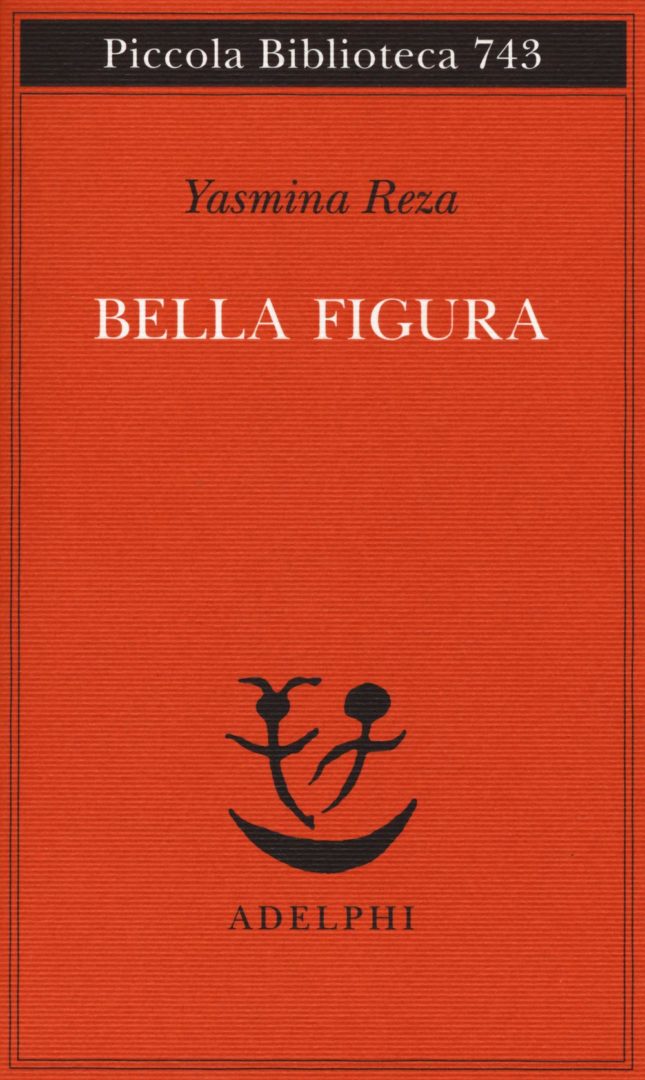
Mais oui, mon Dieu, dice la trama d’Oltralpe – Matthieu Delaporte, Alexandre de la Patellière: questo il terreno, più o meno sublime.
I meccanismi umani d’un ilare scontro tra coppie stavolta sfumano sulle generazioni: Andrea e Boris sono gli amanti, Françoise ed Éric i coniugati, Yvonne la vieille chouette (madre dello stesso Éric). Il cozzo è effettivo – Boris investe senza dolo e senza danno l’anziana signora, nel parcheggio d’un ristorante –, l’incidente è diplomatico – Françoise conosce bene la moglie di Boris. Tutti nello stesso posto al momento giustamente sbagliato, per mangiarsi le unghie, insieme a ricci di mare, al pralinato alle pere.
Acclamata dal 1987 (era Conversations après un enterrement, era il premio Molière), la drammaturga parigina preferisce ambientare i propri interludi – «Quel che conta sono tutti questi contrattempi» – entro setting monofocali. Monolocalmente, così, avvantaggia uno stile esasperato, ristretto sotto forma-pensiero-materia, avvinghiato a vespai compressi che finiscono per contagiare in metafora non solo la storia, anche la carne: «Quattro anni fa, quando mi sono spogliata, tu hai notato che il reggiseno e le mutandine erano strettissimi. Hai notato i segni sulla mia pelle, mi hai detto, perché indossa cose che la lacerano?».
La velenosa datazione al carbon(ch)io di Reza sugli impicci relazionali stima siano immemori nonché immortali. Le crediamo, ci riconosciamo, ci sbrodoliamo su, sogghignando, davanti alla soglia dell’endroit pour manger più inutile di sempre: il cibo non va giù, solo pasticche, sigarette, qualche flûte di «champagnino», a fatica («Lei non beve? Quando si brinda si deve bere»). Il tempo di una «serata sfasata» allunga all’infinito, all’iperbole che vorrebbe persino stravolgere la somaticità – «Ti stai imbruttendo. La tua faccia sta diventando ordinaria».
Ogni personaggio coinquilina il proprio carattere a stento come fosse ospite alieno, ora denudandolo ora celandolo in una «matrioska di sconforti»; matrice comune è l’egotica recherche di «qualcuno che si preoccupi» per quel sé ancora bambino, tanto capriccioso, sommamente nevrotico.

Tra zanzare, melodrammi e stelle cadenti urlano le rane. Lo stallo tragicomico di un imbarazzo perdurante (la compresenza dei cinque attori si rinnova a ogni proclamato addio, prima mentre e dopo lo smascheramento di Boris, fedifrago iellato) somiglia ai batraci nascosti nello scuro di vecchi bossi; ripugna ma ipnotizza, molesta ma scandisce.
Si ride perché altrimenti si piangerebbero, le rovine inferiori che infestano la vita. Si ride perché al sacro triduo Liberté, Égalité, Fraternité s’aggiunge quella légèreté genomica che solo i Franchi sanno; la levità di Reza particolareggia un climax ondulato e ungulato («Andate tutti affanculo!», in bocca al più pacato), un cinismo allegro («Prima di buttarti nella Garonna se ne hai voglia, amore mio, potresti l’ultima sera fare bella figura, come i grandi giocatori d’azzardo»).
L’autrice rende la fenomenologia del cupio dissolvi uno scherzo serio; c’è il pauroso gioco del voler lasciar le cose a frantumare, del vedersi morire, dello specchiarsi deformati. Arriva fino all’orlo del non ritorno, poi la farsa d’emblée indietreggia, si mette in salvo.
Malati di protagonismo qui esistono – «Sì… Sono quella che vuole andarsene e che sempre resta, resta, resta…». Eppure vantano presenze tanto inappetenti quanto ininfluenti, preferenze esauste («Sa che cosa invidio? La ripetizione. Il sempre alla stessa ora») e volontà abbozzate, gestuali («Sa, signora, si possono mimare tante cose… Io mi sorprendo spesso a mimare la pace»).
Soprammobili di poco pregio, gli astanti di Bella figura vedono galleggiare la propria esteriorità, e ne hanno timore.
Photo credit:
Bella Figura, Arno Declair, 2015;
Yasmina Reza, Samuel Kirszenbaum.
