C’è una via, dietro la mia casa, nel quartiere di Monteverde a Roma, intitolata a Ferdinando Palasciano. Vi ho frequentato le lezioni di pianoforte, in una stanzetta al primo piano affacciata proprio sulla targa col nome e cognome di quel medico di cui, prima di leggere il maestoso, folgorante romanzo di Wanda Marasco, non sapevo nulla. Di spalle a questo mondo (Neri Pozza) è, insieme, la storia di una vita e la storia di una scrittura, così fittamente intrecciate tra loro anche a distanza di più d’un secolo. La materia incandescente della narrazione è la vita, appunto, di Palasciano, restituita dall’autrice attraverso momenti cruciali della sua esistenza, scelti con sapiente lavorìo di forbice, e cuciti insieme perché la storia d’Italia e l’avventura dell’uomo – scarti minimi ma fondamentali, o invece notevoli ed epocali – compongano insieme l’arazzo di un tempo inquieto e febbrile.
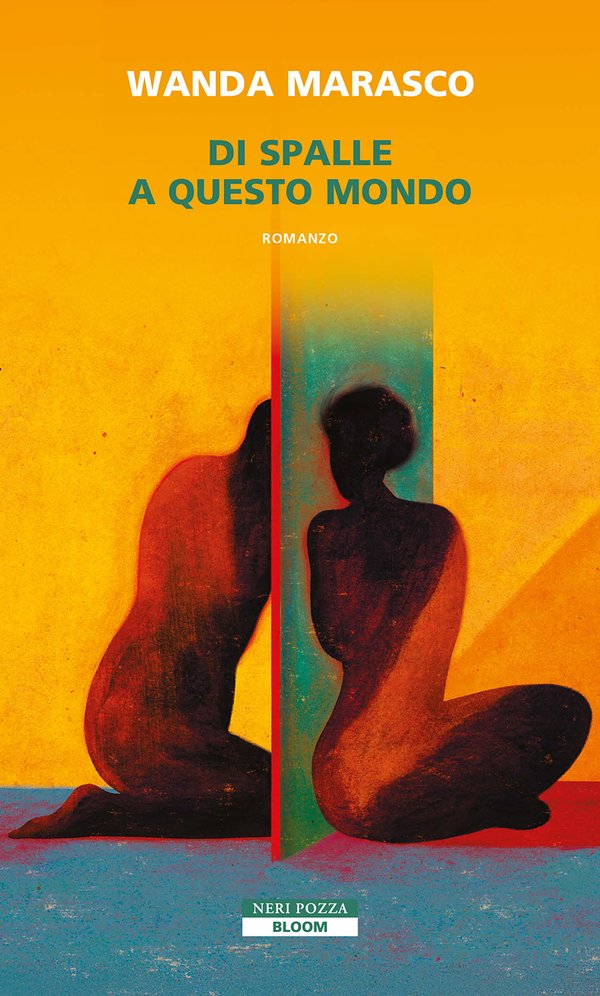
Ragazzino refrattario all’idea della fine, in debito di nome con uno zio muto che abita in un paese catatonico tra mura di giorno accecanti, «che si riempivano di ombre epiche a ogni tramonto: sagome di vecchi intabarrati, giganti curvi, bestie cornute che annusavano la mentuccia cresciuta lungo il perimetro delle case gonfie di silenzio», poi marito pieno d’amore per sua moglie Olga Pavlova Vavilova, che cura con abnegazione da una zoppia destinata a riaffacciarsi nel tempo come ferita quiescente dell’anima. Ferdinando diventa medico per vocazione e passione, ponendo le basi della Convenzione di Ginevra che darà vita alla Croce Rossa. Una passione che brucia così rapidamente da trasformarsi in ossessione, l’ossessione della cura e della salvezza dalla morte, una dedizione da far quasi presagire i segni della follia che lo colpirà nel 1887, lo stesso anno in cui la pazzia tocca anche Vincenzo Gemito, scultore napoletano. Alla figura di Gemito, Wanda Marasco aveva dedicato il romanzo Il genio dell’abbandono (Neri Pozza), e qui torna ad affacciarsi tra le stanze della casa di cura Villa Fleurent, luogo all’avanguardia nel trattamento delle malattie mentali, con ambienti luminosi e attività di svago e di lavoro. Niente a che vedere con le pratiche disumane del manicomio di Aversa. L’infausta data che lega Palasciano e Gemito alla pazzia, riflette l’autrice, sembra quasi voler suggerire, suggestione o ipotesi, il passaggio di una cometa maligna sulla città di Napoli. Quasi che la follia passata da Gemito a Palasciano sia un’arma della memoria per andare alla ricerca dei guasti di un secolo.
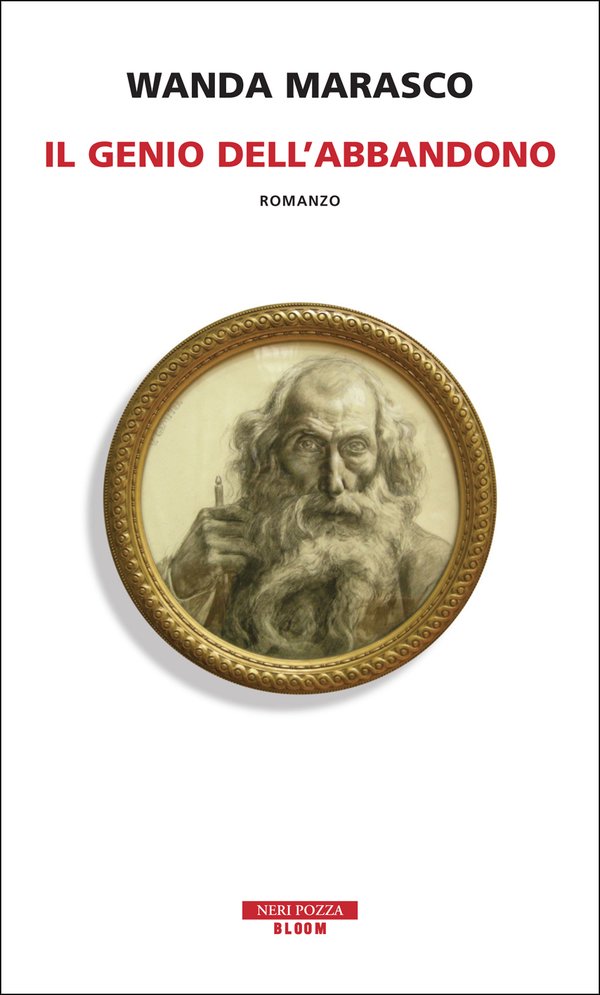
Conducendo i lettori con passo sicuro e ammaliante, Wanda Marasco ci mostra un uomo alle prese con la sua disciplina e in rotta con la politica (prima divenuto deputato, poi dal 1876 senatore del Regno d’Italia). Sì, perché Ferdinando è un medico battagliero, votato a un profondo senso della giustizia, per tenere fede al quale sfida anche i poteri della sua epoca. Eccolo allora a denunciare la prossimità dei reparti di natalità e malattie infettive nella struttura Gesù e Maria; eccolo ancora nel 1848, in guerra, a curare per amore della sua professione tanto i soldati borbonici quanto quelli nemici, un comportamento inammissibile che gli farà sfiorare la condanna a morte per fucilazione. È tra visioni e allucinazioni, tra momenti di lucidità e rimestio di ricordi, vittima di quella «doppiezza della mente cominciata la notte d’Ognissanti del 1887, su via Toledo» che Palasciano, recluso nella casa di cura alla presenza di altre figure indimenticabili – pazienti che gli insegnano linguaggi segreti per comunicare da stanza a stanza, infermieri e medici –, rievoca il mondo che lo abita a partire da sua moglie Olga, rimasta a presidiare la Torre del palazzo al Moiariello.
«Buio e freddo per Olga erano dimensioni psicologiche», scrive l’autrice. Anche quando i fatti precipitosamente portano la donna verso una solitudine che continuerà ad avere per lei il peso delle pietre, anche quando le pietre, si convincerà, converseranno dello scandalo continuando a raccontare, Olga non sfratterà mai le stanze della mente dalla figura del marito, al quale dedica, in pagine di corsivi incandescenti, riflessioni e pensieri:
«Ho pensato a come mettere insieme le parole buone. Del tipo, Ecco, ti ho portato un’altra coperta, le pantofole, l’acqua, il cibo… Quelle frasi minime, da soccorso universale, che andrebbero bene per chiunque (…) Resto con Ferdinando. Ferdinando è il mio fondo. È l’abisso giusto per una come me».
L’altra storia che fa da contrappunto a quella del protagonista e di sua moglie Olga, è quella della scrittura dell’autrice. Da dove viene Wanda Marasco e, verrebbe da chiedersi, ce la meritiamo? Io vorrei credere di sì, ma non ne sono così convinto. Leggere Marasco è un regalo immeritato, troppo più grande d’ogni merito. Nella sua lingua si sente l’eco di grandi scrittrici del Novecento; c’è l’ampio respiro storico di Morante, la visionarietà di Ortese, la capacità trasformativa e metaforizzante della migliore poesia italiana e straniera; c’è persino da sospettare una familiarità con Woolf, per la gestione rivoluzionaria del tempo del racconto, in uno sciabordìo continuo negli anni che segue instancabile il giustapporsi di immagini e fatti. Per questa compresenza di voci, tutte “digerite” e tutte reinventate in uno stile unico, riconoscibilissimo, la penna di Marasco – anche quando s’infarina di dialetto nei discorsi diretti dei suoi personaggi – è una tradizione che si rinnova e, rinnovandosi, non perde un solo centimetro della forza commovente e spiazzante che siamo soliti riconoscere alla vera, grande letteratura.
In copertina: Owen Gent, Your Blissfull Shadow No.4, 2020
