In questa lunga ed estenuante quarantena, come molti altri, ho letto poco e con difficoltà. Le parole mi sembravano sempre troppo fitte: nodi di significati irraggiungibili. Mi mancava l’aria e la letteratura per la prima volta non mi dava ossigeno ma una sensazione di lontananza. Solo i romanzi giapponesi, miracolosamente, favorivano la mia concentrazione. Mi sono chiesta perché. Cosa, della scrittura giapponese, si sintonizzava così bene al mio (nostro) isolamento.
La risposta è storica, antropologica: l’isolamento è il marchio della letteratura giapponese, la sua molla, la sua vena pulsante. In che senso? Innanzitutto, il romanzo giapponese nasce proprio da una chiusura (nonché quello mondiale, in quanto prima non esisteva nel mondo la forma romanzesca compiuta, indagatrice della psiche): Murasaki Shikibu, una dama dell’anno mille che viveva chiusa tra le quattro mura della sua sfarzosissima corte, a un certo punto decise di scrivere. Ma non si trattò solo di una chiusura fisica: era anche una chiusura politica, perché tagliava i ponti con il dominio maschile, in quanto la letteratura era prerogativa degli uomini, ed era anche una chiusura linguistica, perché abbandonava la lingua cinese con cui finora era stata composta la letteratura (ecco perché la lingua giapponese venne da allora definita onnade, “mano femminile”). E cosa nasce da questo intrico di chiusure, cesure, isolamenti? Un romanzo di uno spessore psicologico (e di pagine, in effetti) straordinario: La storia di Genji. Ma nessun libro nasce da un semplice esercizio introspettivo: i romanzi non sono gastroscopie, passano dall’io solo per approdare ad analisi più ampie del reale. Infatti Murasaki era una donna colta, che conosceva benissimo la letteratura giapponese e anche quella cinese. La stesura della storia di Genji nasce dunque da un isolamento che è stato preceduto da ricerche sull’esistente.
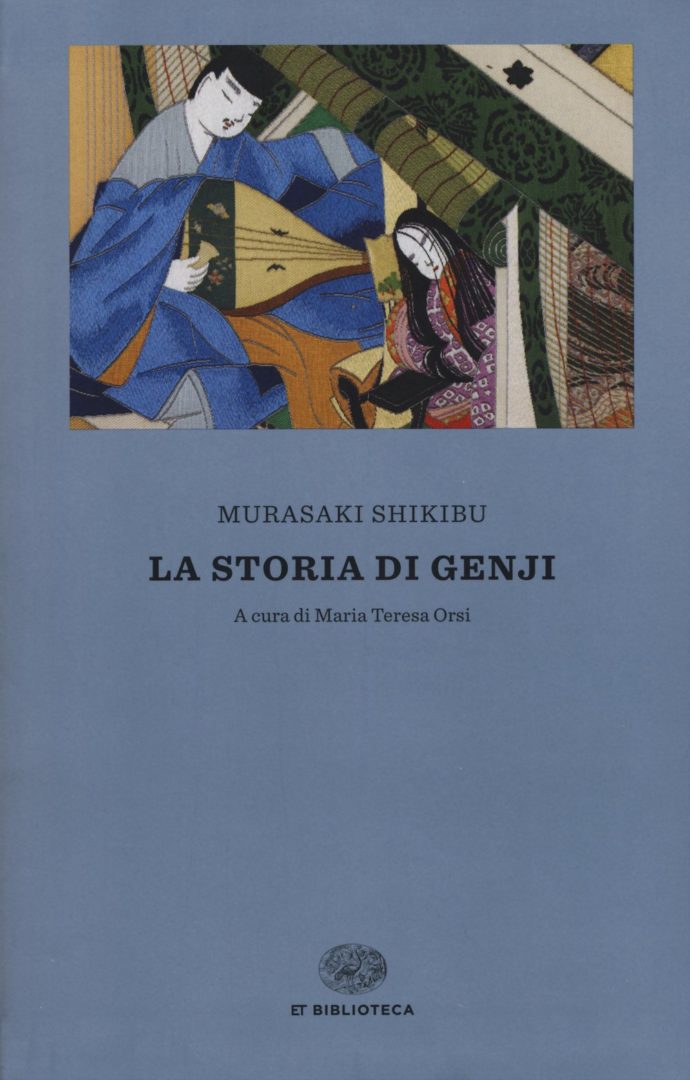
Questo particolare esercizio in due quarti che segna la nascita del romanzo, ovvero la chiusura verso l’esterno preceduta da uno studio meticoloso, è caratteristico dell’intera storia nipponica, non solo letteraria: la cultura giapponese è fondata su un costante esercizio di analisi del mondo e di successiva ridefinizione di sé. Sporgendosi dai bordi dell’arcipelago, il Sol Levante attingeva materiale culturale da fuori (dalla Cina: religioni, arti, la stessa scrittura; dall’occidente moderno, la tecnologia) e poi lo elaborava e rimestava nel suo immaginario, creando prodotti affascinanti e complessi il cui aspetto universale nasceva proprio dall’autenticità di questa sintesi.
Al contrario della Cina, infatti, che ha fondato la sua idea di nazione su una centralità escludente, che immaginava mostri al di fuori dei suoi confini (infatti Cina in cinese si dice “Zhongguo”, terra di mezzo), il Giappone ha sempre definito se stesso nell’impatto con l’esterno, in uno sguardo bipolare che esordisce con un’osservazione attenta e poi si chiude in se stesso per creare meraviglie. (Giappone si dice poeticamente “Nihon”, le radici del sole. Non c’è un centro geografico, dunque, nell’immaginario patriottico: è più un centro religioso, poetico, che non esclude altri astri né ha una gerarchia troppo marcata).
Studiare in modo quasi entomologico l’alterità culturale, per poi innestarla in pazienza e solitudine nel tessuto culturale autoctono, è il segreto dei capolavori letterari e cinematografici che tanto amiamo. Joyce Carol Oates, nei suoi saggi sull’esperienza visionaria in letteratura, ha scritto che la vera tragedia letteraria è culturale, non è mai personale: solo l’io dilatato dalla sua ombra collettiva ha il potere di portare l’arte alla storia. E infatti non esiste capolavoro che non sia nato dopo un’osservazione umile dell’arte precedente.
Ecco perché, guardando Sogni di Kurosawa o leggendo Il padiglione d’oro di Mishima, siamo catturati da un’esperienza di estraneità in cui però sentiamo l’eco di noi stessi. Il genio di Mishima Yukio nasce proprio dalla sintesi di elementi tematici nipponici (tra tutti la contemplazione della bellezza, che nella cultura giapponese occupa il posto che in occidente occupa l’abnegazione religiosa) con la ricerca formale e psicologica del novecento occidentale. Kawabata Yasunari, autore premio Nobel dei bellissimi Bellezza e tristezza e Il paese delle nevi, è passato per lo sperimentalismo ombelicale europeo per approdare a una forma squisitamente giapponese di letteratura.
Ma come sono riusciti gli scrittori contemporanei a portare avanti questa attitudine?
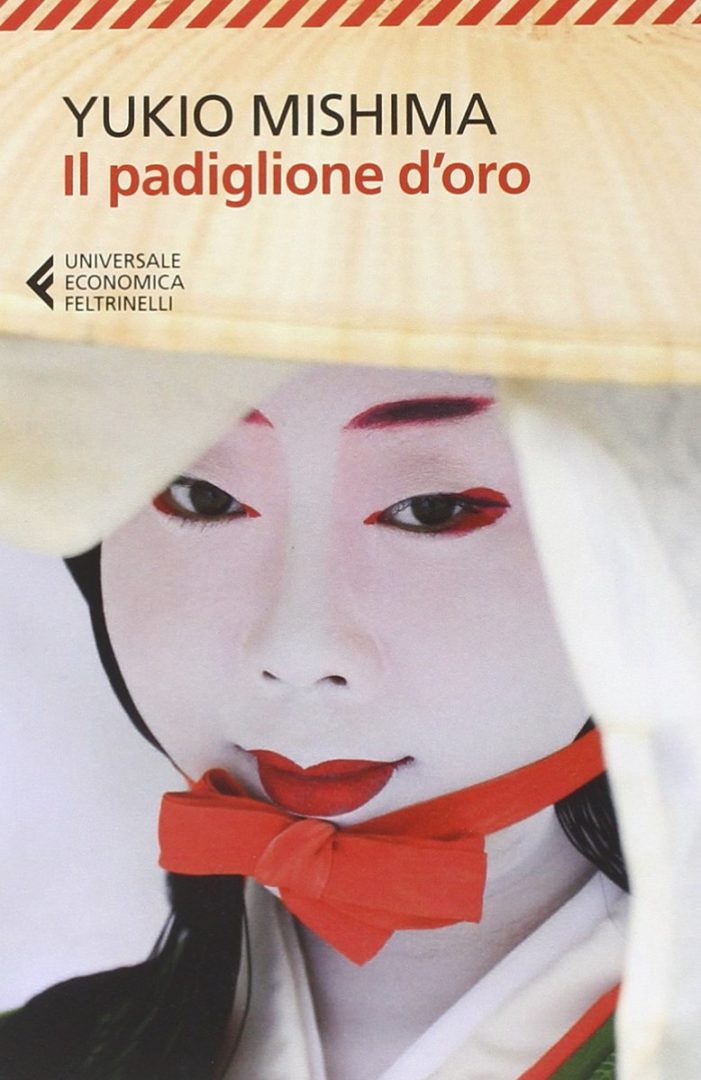
Murakami Haruki ha uno stile molto occidentale in cui fanno incursione reminiscenze nipponiche, come in Norwegian Wood, dove il rock e il nichilismo sono attraversati dal tema rarefatto e volutamente non indagato del suicidio: lo yugen, ideale estetico autoctono che sta alla base del teatro Nō, teorizza una bellezza mai dispiegata, solo suggerita. Così, il passato risulta polveroso e magico perché isolato dall’analisi del presente.
Murakami Ryū, appena tornato in libreria con il suo esordio Blu quasi trasparente, ha mutuato il peculiare gelo carnale e carnoso di certi romanzi occidentali sul mondo della droga, portando il lerciume fisico di quell’universo a un livello quasi metafisico: i dialoghi sono privi di slancio e fantasia e solo la materia, l’azione annichilente sul mondo e su se stessi, sembra avere importanza. Raggiunto qualche settimana fa via e-mail per un’intervista per Tuttolibri, Ryū mi dice tra le altre cose che ormai si sente lontano dal suo primo romanzo, scritto poco più che adolescente, e che alla sua età vuole ormai parlare solo di se stesso: io penso che, lungi dall’essere una caratteristica della tarda età adulta, il parlare di se stessi è proprio una prerogativa dell’adolescenza, quando le menti hanno uno slancio diaristico sul mondo e ogni sensazione viene preservata sacralmente come le spoglie di un animale raro sotto formalina. E penso che questo, lo sguardo post-adolescenziale, è proprio uno dei modi in cui si declina oggi l’attitudine all’isolamento giapponese.

Un altro modo è quello di Tawada Yoko: sconosciuta in Italia, in Il bagno, fiaba alla Angela Carter, racconta delle trasformazioni di un corpo a causa di un’identità troppo fluida. «L’Europa l’hanno inventata i giapponesi», dice provocatoriamente l’autrice nella prefazione al breve romanzo, e infatti ciò che restituisce quel corpo pieno di squame è la confusione di ingozzarsi di stimoli culturali esterni e poi doverli, con cura speciale e nevrotico perfezionismo, introiettare.
L’ultima forma di isolamento romanzesco nipponico che vi racconto è l’attenzione feticista al dettaglio: leggete la bravissima Ogawa Yoko. Nel suo libro L’anulare (o, nel titolo originale, L’esemplare di anulare), l’isolamento all’interno di una struttura fisica – un museo che preserva i ricordi – diventa isolamento emotivo in una relazione claustrofobica con il direttore del museo, e tutto, ogni oggetto del reale come della mente, è raccontato nella sua assoluta solitudine: quella di essere oggetto di uno sguardo assoluto, predatorio eppure, per la sua fissità, protettivo.
E non perdete il suo ultimo libro, L’isola dei senza memoria: perché è nell’elisione, nella cancellazione della nostra memoria su di noi che possiamo creare spazio per apprendere, creare, scoprire cose nuove sul mondo e, solo dopo, sulla nostra mente.
Illustrazione di copertina: Elisa Rizzitiello
