Il suicidio è un virus letale che contagia prematuramente le sue vittime. Chi alza la mano contro se stesso percorre un cammino che da subito è famigliare: lo sa, lo coltiva, lo vezzeggia, lo prepara. Ci prova, a volte. Ma con tattica dilatoria, deve trovare l’innesco, il momento fatidico e indifferibile, una data segnata sul calendario o un impegno predestinato, da svolgere con cura maniacale dei dettagli.
Lo sapeva Sylvia Plath, dopo diversi tentativi non riusciti, quando decise di mettere la testa nel forno. Lo stesso metodo che scelse un’amica mia nel fiore degli anni, con l’aggiunta di un particolare macabro: la madre l’aveva incoraggiata a mettere su casa da sola e lei l’aveva arredata, impiegando un tempo infinito. Quando tutto fu pronto, mancava un solo elemento, un forno di colore rosso, identico a quello di Sylvia Plath. Coincidenza o caso?
Virginia Woolf entrò senza indugi nelle acque del fiume Ouse, riempiendosi le tasche di pietre, e camminando impavida, lo sguardo dritto davanti a sé. Aveva deciso e andò sino in fondo, non solo metaforicamente.
Lo sapevano bene gli scrittori Stig Dagerman (1923-1954) e Guido Morselli (1912-1973), le cui esistenze – in angoli diversi del mondo – si sovrapposero per un trentennio circa, ovvero la durata della vita di Dagerman, sino a quando Stig recise lui stesso anzitempo il filo delle Parche: Morselli doppiò i suoi anni, e ne ricalcò l’esempio fatale all’età di 61. Strane e singolari alcune coincidenze fra loro, specie nelle opere che più li riflettono, pressoché autobiografiche: la premonizione di Dagerman contenuta in quel meraviglioso libro testamentario che è Il nostro bisogno di consolazione (1952) fa il pari con il morselliano Dissipatio H.G. (scritto nel 1972, uscito postumo nel 1977), l’ultima scommessa narrativa, prima del suicidio.

I due avevano perduto la madre presto: Dagerman abbandonato a pochi mesi dalla nascita, cresciuto da nonni per fortuna intellettualmente dotati. Ma il nonno fu ucciso da un balordo, e la nonna non gli sopravvisse a lungo. Rimasto solo, tornò a vivere dal padre, totalmente inadeguato alla sua indole sensibilissima. Morselli aveva perduto la madre (e poco dopo la sorella maggiore che gli faceva da madre) più tardi rispetto a Dagerman: all’età di dodici anni, anni decisivi per il formarsi di una coscienza delle cose e della vita, sulla quale la figura paterna avrebbe avuto, più che influenza, almeno tolleranza, anzi, rispetto. Questa assenza condivisa della figura materna fece di loro dei bambini trascurati, lasciati soli a costruire il proprio mondo interiore, e non mancò di influire sui loro tormentati amori adulti. Dagerman, che passò un’infanzia sofferta, ne risentì profondamente: sviluppò infatti un’attenzione spasmodica nei confronti dei bambini, vittime innocenti di infelicità e di violenza, protagonisti di alcuni dei suoi libri più struggenti: «Profondi sono i solchi nei gradini del dolore, e pieni di sabbia e sale» (Bambino bruciato, da cui è tratta la frase; Perché i bambini devono ubbidire?; Uccidere un bambino).
Non stupisce se entrambi, lo svedese e l’italiano, furono precocemente attratti dalla scrittura: ventenni, si fecero le ossa scrivendo articoli giornalistici, mandando corrispondenze e reportage dalla Germania. Osservando e raccontando il mondo postbellico, Stig Dagerman abbracciò una posizione politica fortemente antinazista, sul piano sociale aderì a movimenti anarco-sindacalisti. Guido Morselli, agnostico con dubbi assillanti, vagamente anarcoide lui stesso, intellettuale isolazionista, vestì i panni di un conservatorismo borghese, liberale alla maniera anglosassone, con una spiccata attenzione umana per le persone umili.
Morire è un’arte, asserì la Plath: forse sì, c’è qualcosa di personale e peculiare, quasi uno stile eloquente, una cifra riconoscibile, nella pignoleria con la quale a volte si sceglie il metodo e si mette in pratica l’atto, si compie il gesto finale, quasi mai un impulso improvviso e irrazionale, bensì un itinerario preparatorio della mente, della psiche, uno scontro progressivo, prolungato, tra lucidità e follia, testa e cuore.
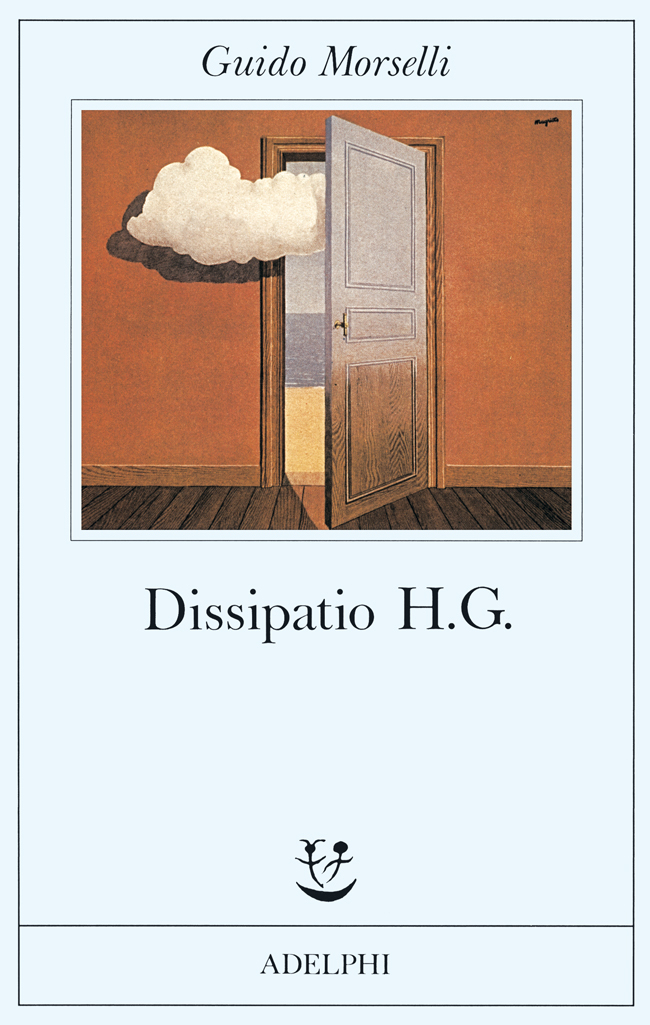
«L’unica cosa che m’importa è quella che non ottengo mai: l’assicurazione che le mie parole hanno toccato il cuore del mondo», scrive Stig Dagerman nel 1952. Due anni dopo, appena trentunenne, si chiuse in macchina a respirare i gas di scarico. Precedenti tentativi, forse incerti, inefficaci, erano andati a vuoto. Quando decise di sparire, era un giovane talentuoso, all’apice di un successo forse detestato, con una eccellente produzione poetica, letteraria, teatrale, cinematografica, ma evidentemente insoddisfatto o divorato dal dubbio di non riuscire a mantenersi all’altezza delle aspettative. Diverso il caso di Morselli che la gloria non arrivò a toccarla: capace di valutare la qualità delle proprie opere, che continuò a proporre agli editori con reiterata ostinazione, quasi masochistica, commovente, mutando ogni volta registro alle proprie storie, versatile e poliedrico quanto Dagerman, non gli fu mai concessa l’esaltante sensazione di fare colpo sul lettore. Un destino avverso oppure la sfortuna di non essere compreso perché troppo originale, lo beffarono, consacrandolo interamente post mortem.
Si dice che la natura possa talvolta costituire una consolazione alle delusioni, e i due scrittori, inquieti, refrattari agli umani, addirittura fobantropi (Morselli), ci provarono, seguendo l’esempio di Thoreau che almeno «aveva la foresta di Walden», come riconobbe Dagerman: «Posso camminare sulla spiaggia e all’improvviso sentire la spaventosa sfida dell’eternità alla mia esistenza nell’incessante movimento del mare e nell’inarrestabile fuga del vento. Cos’è allora il tempo se non una consolazione perché niente di umano può essere perenne?» (Il nostro bisogno di consolazione, corsivo nostro).
Anche Morselli, che amava il gioco di parentesizzare l’esistenza dei propri simili figurandosi come l’unico pensante in una realtà deserta, sognava una natura pulsante con sé e per sé solo: «Mi alzavo di tra l’erba e abbracciavo i larici, cosa che mi capitava di fare anche da ragazzo e allo stesso fine preciso: di lasciarmi penetrare dalla loro forza vitale». Nella folle sfida al tempo, all’eternità, raccontata in Dissipatio H.G., un’ipotesi surreale trasforma il suicidio nella scomparsa del genere umano: «La notte favolosa fra il primo e il 2 giugno. Quella notte, ero deciso, mi sarei ammazzato. Perché. Per il prevalere del negativo sul positivo». Non è forse il suicidio un sottrarsi al mondo, o farlo vuoto di esseri umani, condannandosi a una perenne solitudine? O al contrario, non è dei morti, dell’ombra degli scomparsi, l’aggirarsi inquieto fra gli umani senza più poter avere con questi ultimi alcun contatto reale? Guido Morselli si sparò un colpo di rivoltella, la famosa «ragazza dall’occhio nero», a fine estate, proprio quando ricevette copie di Dissipatio, il suo ultimo lavoro compiuto, restituite al mittente. Dopo Il nostro bisogno di consolazione, Dagerman scrisse poco altro.
Il prevalere del negativo sul positivo, l’impossibilità di toccare il cuore degli uomini con la Parola: per Guido Morselli come per Stig Dagerman non esisteva consolazione possibile. «I cuori ardenti – scrisse Dagerman – A chi interessano più i cuori, ormai? E i poeti?» (La politica dell’impossibile, 1943). La loro morte tragica e inutile, come quella subita, non cercata, di Albert Camus/Sisifo, caro a entrambi per la tensione indomita di rivolta contro l’esistenza, ha reso eterna la loro Scrittura, sogno antico d’immortalità. Se è stata in entrambi i casi la parola a tradirli, la Parola che non ha toccato il cuore del mondo, è inevitabile pensare quale consolazione sia per noi – adesso – leggere e rileggere le opere di questi due giganti del Novecento, antidoto alla mediocrità odierna. È con tali classici che val la pena nutrire le nostre anime.
Copertina – Andreea Popa tramite Unsplash
