«È per Rilke che il nostro tempo verrà perdonato». L’esistenza del poeta come contrappeso al male di un secolo. I versi sublimi che ci hanno emendato dalle guerre stupide. Marina Cvetaeva lo scrive, lo dice e lo urla nel suo modo, attraverso lettere che sono mistica. La poetessa, che si è innamorata di chiunque, ha chiesto solo a lui il miracolo. Quello di essere capita. E Rainer Maria Rilke ha risposto dandole un posto tra «le sue parole di cielo».
«Noi soli
come aria che si rinnova trascorriamo su tutte le cose.»
(La seconda elegia, Rainer Maria Rilke)
Per cominciare, Marina, una poetessa russa poverissima, esule perché sempre estranea, dai versi magnifici. Non si può che condannarla quando si legge la sua biografia travagliata e si scopre come ha fatto morire Irina, la figlia di tre anni, in un orfanotrofio. La piccola sbatteva la testa per terra pur di essere guardata da una madre sempre altrove. Eppure di che amore sembra capace Marina Cvetaeva quando scrive a Rainer Maria Rilke. Di che clamore, di che grandezza. Lei, regina di una solitudine scelta, passa le giornate a eseguire i sentimenti, come racconta Serena Vitale nella prefazione a Il paese dell’Anima, Lettere 1909-1925 (Adelphi). La sua vita suona teatrale quando invece è più un progetto di adesione volontaria al dolore. Lo ammette a più riprese, paragonandosi agli amici, alla famiglia. «In Alja (la figlia primogenita, ndr) non riconosco più nulla di me, ma so una cosa: sarà felice. Io questo (per me) non l’ho mai voluto». Ed è in una delle infinite lettere all’amante del momento che la Cvetaeva conferma la sua, quasi compiaciuta in quanto distintiva, diagnosi, «perché io non sono fatta per la vita. In me tutto è incendio». Marina si sperpera in incontri, brucia (l’unico verbo profondamento adatto a lei) di passione in passione. Eppure, «per tutti questi anni, sempre qualcuno accanto, ma un tale deserto». La donna, che adora «i vestiti nuovi, soprattutto quelli tristi», sa essere feroce come solo una persona scorticata può essere. Ed è cattiva con chi non vive alla sua impossibile altezza.
«Vi stringo la mano e attendo da voi prodigi» scrive a un amico. Nella lettera seguente allo stesso amico annuncia di non volerlo più, «mi avete ritenuto più semplice di quanto io sia». Non trova pace neanche nella libertà dei suoi «spaziosi versi». Per Marina Cvetaeva scrivere è obbedire, è arrendersi «al compito sonoro già assegnatomi». E quindi per forza si concede a Rilke con uno slancio disperato, chiede a lui di compierla, finalmente, come poetessa. Il luogo dell’incontro per i due non può che essere un epistolario, vicinanza e distanza insieme, lo spazio breve dove si può allestire un sentimento anche se «non ci sono mani». Ed è grazie a questa corrispondenza a tratti mistica, del tutto lirica, che il solitario austriaco potrà essere poeta per l’ultima volta, prima di morire. Il loro epistolario viene pubblicato da SE (Marina Cvetaeva – Rainer Maria Rilke, Lettere). Le date delle loro missive recano sempre lo stesso anno: 1926. Sono pochi mesi, intensi, forse, in qualche forma gioiosi. Poi il poeta muore tra la febbre e i dolori, lei continua a vivere zoppicando per quella perdita che non si esaurisce. Non si sono mai incontrati. Per entrambi l’amore può esistere solo come racconto di una lontananza. Per prima, e questo dà la misura tragica del suo continuo domandare, ha cominciato Marina. L’ha ammirato per anni. Nella mansarda mentre la poetessa russa bruciava mobili per scaldarsi, mentre zittiva la stupida Irina, leggeva «Reineke» – come, nella storpiatura musicale dei bambini, la figlia Alja chiamava il poeta.

Un giorno di maggio, dopo aver parlato di lei con Boris Pasternak, Rilke le scrive quasi con misurata gentilezza un biglietto e le invia due libri con un’indicazione d’uso: «sono per Lei, sono di Sua proprietà». La Cvetaeva risponde, esasperando ogni ardore «lei è un fenomeno naturale che non può essere mio e che non si ama, ma a cui si fa fronte». Riempie questa prima missiva del suo amore solitario e fino a quel momento mai corrisposto, perché maturato leggendo, notte dopo notte, i versi rilkiani. Maldestramente si scusa con il grande poeta e passa al “tu”, «non devi sentirTi obbligato a rispondermi, so che cosa significa il tempo e so che cosa è una poesia. So pure che cosa è una lettera. Ecco».
Nonostante la reverenza di lei e lo stupore di lui, combaciano. «Poetessa senti come mi hai sopraffatto […] scrivo come Tu scrivi e come Te scendo un paio di gradini dalla frase verso il mezzanino delle parentesi, dove i soffitti sono bassi e ancor profuma di rose un tempo fiorite». Marina gli risponde come in sogno, dedica pagine a commentare i suoi versi (I Sonetti a Orfeo, ndr). «O Rainer, Tu mi scrivi nell’orecchio, e con l’orecchio io Ti leggo».
Più che platonico è un amore orfico, che nasce nella perdita, nel cantarsi reciprocamente finiti e dispersi. Marina chiede a Rainer una fotografia, indaga sul suo stato coniugale, gli fa forse troppe domande. E poi si schermisce: «qualcosa in Te deve ancora abituarsi a me». Rilke, che coglie subito le assonanze con se stesso, non sembra faticare a comprendere questa sacerdotessa votata al tragico, sempre a spogliarsi per meglio potersi prestare, essere strumento e permettere alla «cosa» di realizzarsi. Anche lui si sente vincolato alle richieste dell’arte. La solitudine è il prezzo, la sottomissione necessaria allo scopo. «Abito sempre da solo, solo come sempre ho vissuto, e anche di più: in una dilatazione spesso inquietante di ciò che si chiama solitudine, in un isolamento portato all’estremo e ultimo limite». Si danno notizie dalla loro condizione di appartati, l’uno che ha rinunciato alla famiglia, l’altra con figli e amanti. Entrambi aderiscono alla vocazione della poesia, in modi complementari.
C’è il bisogno di Rainer, (l’uomo «che odia il pressapoco»), di non essere distratto, di non farsi distrarre mentre per Marina è imperativa la necessità di scrivere sull’orlo di un incontro continuo. Lui mette i paletti e sottointende un allontanamento, anche se del tutto potenziale: «[…] nel caso io d’un tratto dovessi farTi mancare mie notizie, ciò non Ti dovrebbe comunque impedire di scrivermi». Lei, che segretamente si offende, tace e già canta il suo tormento. «Il mio amore per Te si è sminuzzato in giorni e lettere, in ore e righe». Rilke risponde dedicandole una poesia scritta tra le colline dei vigneti («Gli amanti, Marina, non dovrebbero, non devono sapere così tanto del declino»). E lei a quel punto divampa: «Io Ti amo, non so dirlo diversamente». Lo bacia, lo abbraccia alla fine di tutte le lettere. Rilke ha uno slancio più pacato, sa che il suo tempo è contato e sente la gravità della fine. Lei chiede di essere la sola nel suo cuore, unica cittadina ammessa nella «Rainerlandia». Lui si dice contrario a ogni esclusione («che cresce dalla radice dell’amore e diventa legno»), ma le scrive la dichiarazione più bella, quella che la Cvetaeva ha cercato ovunque, stringendosi a tutti, «quale forza possiedi, Poetessa, nel raggiungere, […] il Tuo intento di essere precisa a te stessa». E finalmente lì, in quel momento e per la prima volta, si scopre compresa, non solo ammirata.
«Per tutta la vita, Rainer, io mi sono data nei versi, a tutti. Ma ho sempre dato troppo, il tono della mia voce ha sempre superato ogni possibile risposta». Non si sono mai visti, non sono mai stati. Eppure si dicono «io Ti riconosco». Leggere il loro dialogo è capire che esiste davvero «il centro del sempre». Ovvero lo spazio dove noi, che ci siamo trovati, non ci possiamo perdere, anche nel nostro morire.
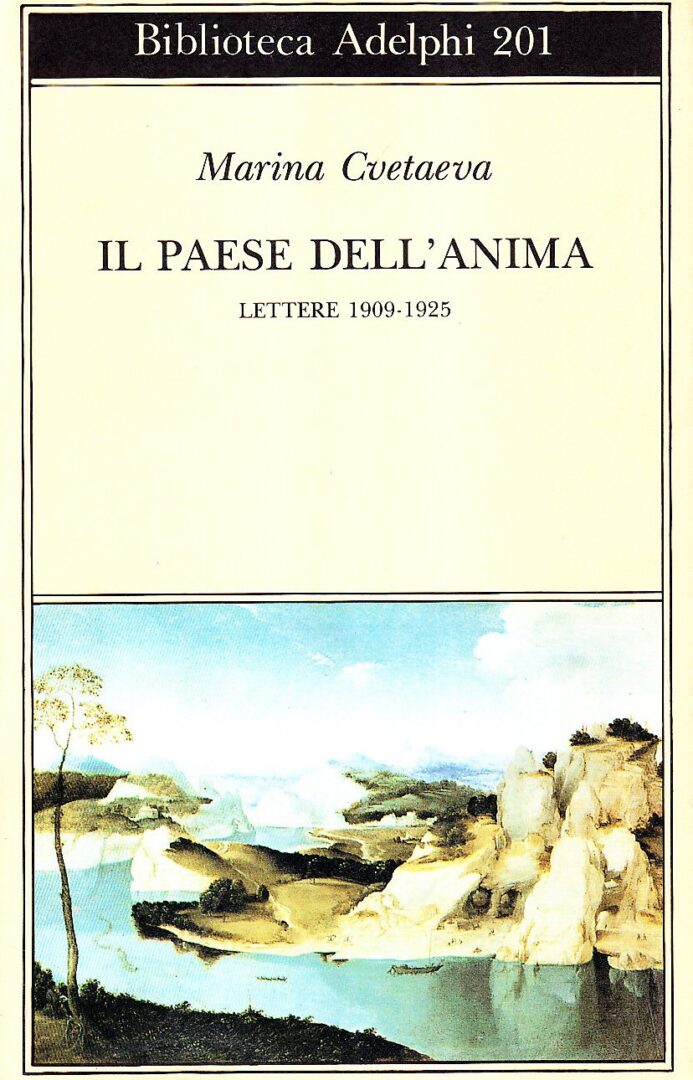
A novembre Marina non sa che le condizioni di salute del suo amatissimo sono ormai irrimediabili, gli invia una cartolina per rendergli noto il suo nuovo indirizzo: «Caro Rainer! Io vivo qui. Mi ami ancora?». Rilke muore il 29 dicembre e lei si consumerà nel ricordarlo. Come un Orfeo che canta la nostalgia di Euridice, mette su carta lettere che sono requiem di mancanza e compone l’epitaffio più dolce nella sua enormità.«Rilke non è nato né su ordinazione né per ambizione del nostro tempo, ma per essere il suo contrappeso. Le guerre, i macelli, la carne lacerata dalle discordie e Rilke. È per Rilke che il nostro tempo verrà perdonato al mondo».
Il 1941 è l’anno del suicidio di Marina Cvetaeva. Si uccide in agosto, lei che per il poeta austriaco era «un’estate di parole». Si è sentita malridotta, mutilata dalle miserie quotidiane (indigente al punto da non trovare neanche un tavolino dove appoggiarsi per scrivere) e dai dolori che sono stati sempre il suo modo di concepire il mondo.
Si è chiesta cosa fare per non entrare nella schiera delle donne rinunciatarie, ordinarie, inutili. Si è guardata allo specchio e, implacabile, si è chiesta: “Sarei io, questa?”. Ha scritto, prima di suicidarsi, rassegnata, «chiedo di essere assunta come lavapiatti nella mensa di Litfond di prossima apertura». Credeva di aver perso la scrittura, il verso di cui lei era umile, estatica mano. E non c’era neanche più l’amore come prova che era esistita, con la figlia e il marito dispersi (condannata al confino la prima e alla fucilazione il secondo, ndr), Pasternak e il suo Rilke andati per sempre.
Fin da bambina Marina Cvetaeva si era scelta un sogno, quello di essere esatta nella descrizione della sua anima. Nel morire voleva «sbocciare in rosa, farmi verso». Non desiderava essere amata, ma essere compresa, diventare condivisibile. Ha scoperto prestissimo che nessuno ci coglie per la persona segreta che siamo. Eppure, qualche volta, sopra le nostre rovine, possono arrivare, per poco e per miracolo, gli altri. Con le loro voci che ci corrispondono non tanto per aderenza, quanto per vastità.
Illustrazione copertina a cura di Francesca Paola Turco (@frappati)
