Un racconto, tra quelli bellissimi della raccolta sciasciana Il mare colore del vino (Einaudi, 1973, adesso nel catalogo Adelphi), descrive in modo quasi filologico il paesaggio della Sicilia. Piane silenziose e crinali spogli vanno da sud a nord, rincorrendosi verso le montagne. Si tratta di L’esame, un racconto di emigrazione, di sofferta rinuncia, di orgoglio e vergogna insieme. La scrittura che racconta la storia dei luoghi ha un ruolo, tra le tante cose, di testimonianza dei paesaggi che cambiano. In Sicilia, ciò è ancor più importante, se è vero che gli ambienti, i climi e i relativi paesaggi sono tantissimi e variegati (la terra cambia da palmo a palmo, mi raccontavano i contadini che incontravo nelle terre).
L’ambiente sciasciano è quello dei narratori, anche minori, della Sicilia interna. È stato ripubblicato nel 2020 il romanzo Malagigi di Nino Savarese (Il Palindromo), dopo la riproposta, nel 2017, di I fatti di Petra dello stesso Savarese, ispiratore non a caso della prima raccolta di Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra. I luoghi e il mondo di Savarese, e poi di Sciascia sono quelli della Sicilia sottratta in quanto ignota, per lo più, ma soprattutto plasmata dai suoi remoti abitanti per sottrazione, appunto. Le abitazioni scavate nella roccia, seppur arricchite con successive sopraelevazioni, nascondono la storia e la vita delle famiglie: in quegli ambienti ctoni dove, insieme, si immagazzinano le derrate e si venerano gli dei protettori, nascono e si spengono le lotte per l’emancipazione dei corpi e delle menti, l’inevitabile resa di fronte alla vita o alla morte (non fa poi molta differenza). È la Sicilia delle rocche, inospitale e dura in inverno, nebbiosa più che le pianure dell’Italia settentrionale.

Siamo nei contrafforti dell’antico Val Dèmone e di Castrogiovanni, terra appenninica, ma dove è sempre più evidente il cambiamento del clima, comune al cambiamento nell’intero pianeta. Fu nella metà degli anni Ottanta del secolo scorso quando ci accorgemmo all’improvviso che non c’era più il clima della nostra infanzia: le nevi prima abbondanti si facevano attendere e, pur se arrivavano, dopo pochi giorni andavano incontro a veloce fusione; i mandorli fiorivano in collina già a fine gennaio e i biancospini perdevano le foglie ad agosto sotto i colpi di estati lunghissime e siccitose. Fortunatamente le faggete in montagna sono sopravvissute a questo sconquasso, grazie anche allo stratagemma delle precipitazioni occulte, umidità catturata dalle chiome degli stessi alberi che la concentrano causando delle piogge iper-localizzate, quasi autogenerate, anche nel pieno della torrida estate.
C’è una stagione sulla quale, però, il cambiamento climatico sta incidendo più profondamente. L’autunno, sempre più caldo e siccitoso, sino a novembre è ormai una estenuata tarda estate, ma, proprio per questo, più struggente. Uso questi termini non a caso, poiché li riprendo da Ercole Patti, un autore che ha raccontato questa stagione con grazia irripetibile (Ercole Patti, Tutte le opere, La nave di Teseo, 2019). Il suo autunno etneo è fatto di ciclamini selvatici, di castagne, di vendemmie soprattutto. C’è in Patti un’evidente complicità con i suoi personaggi inani, dediti allo sperpero di sé stessi, tra il rombo di un’Alfa Romeo 33 Stradale e le cicorie in umido le sere di ricercata solitudine. La campagna autunnale è come una seconda voce, non solo uno scenario: il sole crepuscolare che illumina i muretti a secco e fa intravedere sprazzi di eternità, potrebbe essere un antidoto di purezza, eppure diventa presto complice della dissipazione, sedandone la tragedia.
Molto diversa è naturalmente la Sicilia dell’altopiano gessoso-solfifero, tra il Val di Mazara e il Val di Noto, teatro delle più rilevanti voci della letteratura siciliana ‘classica’. È la Sicilia gialla di ogni stereotipo, ma è anche il paesaggio di Sciascia, di cui parlavamo, che eredita da Pirandello: luoghi che dovrebbero essere di mare e sono invece di terra, coperti di quella polvere bianca che avvolge le pellicole di Pietro Germi. Chi percorresse oggi questi luoghi, però, troverebbe un paesaggio in parte nuovo: vigne che si rincorrono perfino dolcemente, grazie ai portainnesti cosiddetti americani capaci, cosa prima impossibile, di far prosperare la vite in terreni calcarei e sassosi. Certo, il paesaggio è anche attraversato da incongrui viadotti in cemento, scheletri di impianti estrattivi, reperti che ci rimandano ai cantieri mafiosi per cui fu ucciso Colasberna in Il giorno della civetta, ma è pur sempre un paesaggio diverso, che smentisce l’aura, e più spesso l’alibi, di immutabilità dell’isola.
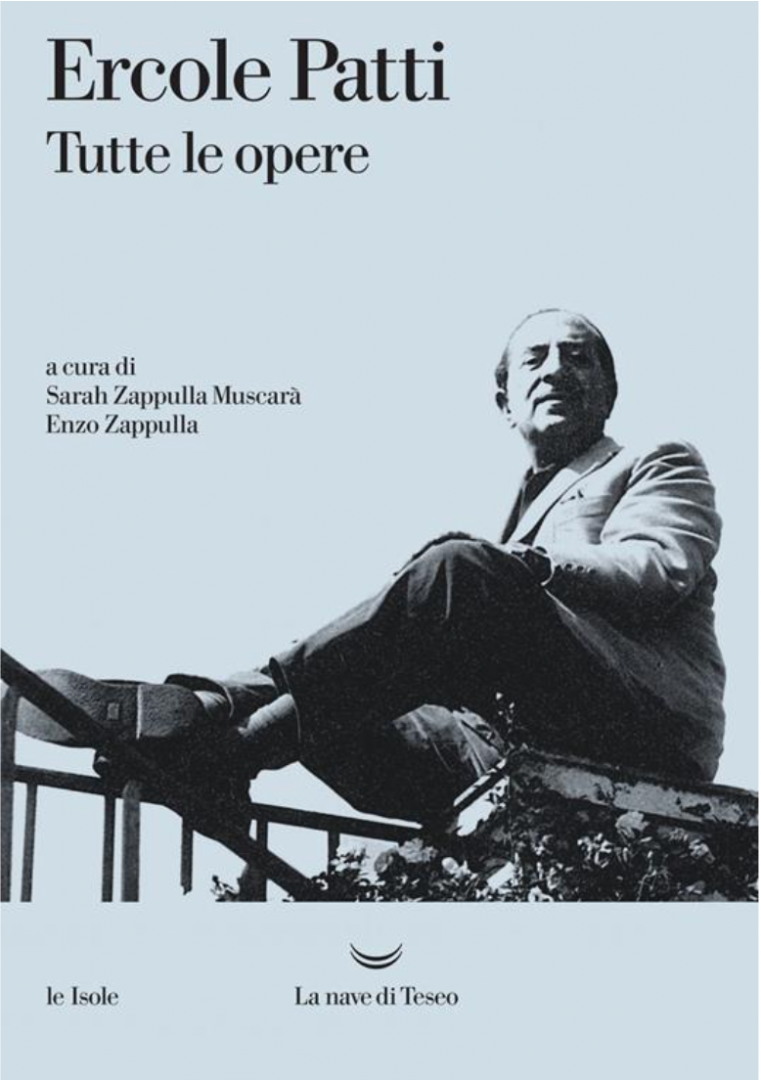
La scrittura di Sciascia ha avuto il merito di svelare le trame, solo dopo averne scoperto nodi indicibili, che rendono inutile lo stesso disvelamento. Sembrava possibile, grazie a questo scavo, che la letteratura siciliana potesse continuare la ricerca di un orizzonte sperimentale, ma oggi non sembra così e il rischio, soprattutto nelle scelte editoriali, di una Sicilia neo rusticana, è terribilmente alto.
Ci sono voci però che ancora rispondono all’eco e all’ethos di tale ricerca. Penso alle poesie di Nino De Vita, amato molto da Consolo che ne aveva colto subito la straordinaria ricerca linguistica, opposta alla facile narrativa da esportazione. In Il bianco della luna (Le Lettere, 2020) ci sono le tante spire della sua produzione, dal 1984 in poi, i suoi luoghi e soprattutto i suoi suoni, arrotati, cavallereschi, inesorabili. De Vita ha la forza di descrivere ambienti, di mare e di terre, rendendoli ancora vivi per come sono: perché, se possono apparire troppo spesso archetipici e senza tempo, sono invece reali e attuali. È un altro imprescindibile tributo alla conoscenza dei tanti orizzonti siciliani che abbiamo il dovere (direbbe Vittorini) di testimoniare e anche, purtroppo o per fortuna, di cambiare.
Vittorini, quindi, approdo e origine di ogni discorso sulla Sicilia contemporanea. Il viaggio omerico racchiuso nel suo capolavoro incompiuto Le città del mondo è la narrazione più pura del panorama siciliano, tramite lo sguardo dei due pastori nomadi protagonisti dell’opera, alla ricerca di un mondo nuovo eppure ancora mitico, di un mito rivoluzionario. Le città “belle”, Scicli, Nicosia, Enna ma anche quelle “brutte”, secondo il linguaggio vergine del giovane pastore Rosario, brillano come le lucciole a illuminare un mondo dove il richiamo dell’oscurità è spesso invincibile. L’ambiente siciliano, per quanto difficile e avverso, è vittima della povertà dei feudi, della dissipazione. I crinali sono spogli perché l’uomo li ha spogliati al fine di ottenere ora legna ora nuova terra per una cerealicoltura di rapina, e oggi il rischio della desertificazione è figlio soprattutto di pratiche agricole che hanno eroso la fertilità del suolo esponendolo, senza più difesa, alle variazioni, grandi ma anche piccole, dei fattori del clima.
Eppure gli ecosistemi tendono all’omeostasi, a un equilibrio dinamico, e la vita ha ancora il compito che viene descritto nelle prime pagine di ogni libro di fisiologia: opporsi all’entropia. La narrazione della Sicilia ha questo debito verso un ambiente così compromesso: opporsi al degrado, descriverne i cambiamenti così come le sconfitte, i tradimenti, costruire uno spazio dove far ascoltare le vite e le voci che gli altopiani senza fine tendono a disperdere per sempre, le stesse voci che risuonano nelle notti oniriche descritte da Vittorini. Altrimenti resterà solo un vano svolazzo barocco.
