Torna in libreria, a 60 anni dall’uscita della prima traduzione italiana (di Giulio de Angelis con la consulenza di Glauco Cambon, Carlo Izzo e Giorgio Melchiori per la Mondadori), “Ulisse” di James Joyce, edito da La nave di Teseo. Una nuova versione, tradotta da Mario Biondi, che fa riferimento all’edizione inglese degli Oxford World Classics del 1922. Nel giorno del Bloomsday, pubblichiamo la prefazione di questa nuova edizione, dal titolo “PROLEGOMENI. Alla famosa giornata di peripezie dell’onorevole signor Henry Flower Flor de la Flora Virag Boom Visciidbloom Elia Leopold Bloom, gentiluomo, resa in lingua italiana“.
***
Singolarmente pasticciata, martoriata la vicenda editoriale dell’Ulysses nel travaglio delle sue prime edizioni e ristampe. Tanto per cominciare a causa del disinvolto modo in cui il suo autore progettava il testo, come si può desumere da una lettera del 22 novembre 1917 all’amico Sykes a Zurigo: “Prendo appunti su pezzi sparsi di carta che poi dimentico nei luoghi più improbabili, in libri, sotto soprammobili, nelle mie stesse tasche, e sul retro di volantini pubblicitari.” E una volta ritrovati i pezzetti di carta, via a comunicare correzioni ai temporanei affidatari dei suoi manoscritti e appunti a mano. Così, arrivati finalmente al primo testo a stampa, le errata corrige si sono susseguite a raffica, da parte dello stesso Joyce, di suoi amici e collaboratori – precipitosamente informati del ritrovamento di questo o quel pezzetto di carta qua o là –, di successivi commentatori.
E le prime correzioni effettuate sui piombi dello stampatore francese Darantière – tipografo non di lingua madre inglese, autore-creatore malato di sperimentalismo onomaturgico, autore-correttore con formidabili problemi di vista e calligrafia illeggibile eccetera – hanno provocato a loro volta epici pasticci. Lettere o parole o interi blocchetti di testo che cascavano fuori ed erano infilati di nuovo dentro alla bell’e meglio. Tipo la vicenda narrata da I.B. Singer nel magnifico racconto La riga mancante: un’intera riga scomparsa da un feuilleton su un giornale yiddish di Varsavia e ricomparsa come per miracolo o magia in un pezzo di cronaca nera su un altro giornale, stampato “a una dozzina di vie di distanza”… Cose che succedevano agli eroici tempi dei piombi, ma sta di fatto che è difficile trovare due edizioni del primissimo Ulysses precisamente uguali. Scrive d’altra parte Joyce: «Un uomo di genio non commette errori. I suoi errori sono intenzionali e sono i portali della scoperta.» Segnaliamoli, quindi, questi presunti errori, e cerchiamo anche attraverso essi di procedere ad almeno qualcuna delle infinite – e sempre nuove, e capaci di rinnovare lo stupore a ogni lettura – scoperte che questo tempestoso testo consente.
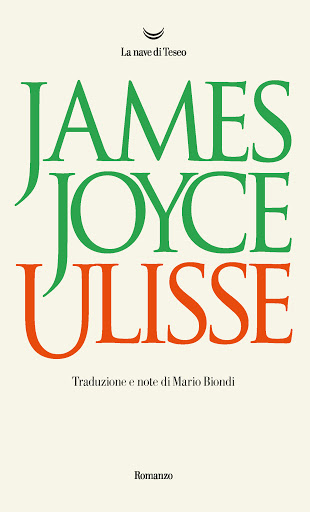
Per la mia traduzione mi sono dunque basato sull’edizione cartacea “1922” pubblicata, commentata, corretta e annotata negli Oxford World Classics. Poi, al fine di facilitare le indispensabili e infinite ricerche incrociate, ho usato il testo elettronico di pubblico dominio realizzato dal Project Gutenberg, aggiornato al 30 ottobre 2018, che si basa sulle prime edizioni del libro (1922-1923), quindi comprende già le prime correzioni. I due testi ovviamente non coincidono, e quando ho riscontrato notevole divergenza ho cercato di segnalarlo al meglio racchiudendo tra parentesi graffe {…} la frase o singola parola interessata e poi mettendo una spiegazione in nota. In qualche caso di forte dubbio, infine, ho consultato l’edizione Odyssey degli anni Trenta, che è largamente ritenuta la più attendibile tra quelle realizzate con Joyce ancora in vita (Alma Classics 3a ed. 2017).
Per i dialoghi Joyce esecrava le virgolette “tonde”, o “alte”, tipiche della tipografia inglese, era arrivato addirittura a chiamarle perverted commas, “virgole pervertite”, giocando su inverted commas, una delle loro definizioni, e pensava che meno se ne usava meglio era. Quindi per contrassegnare i suoi dialoghi (scrivendoli a mano) si serviva della lineetta lunga “—”, all’uso, secondo lui, dei “continentali”. Non risulta però che abbia mai detto o scritto niente a proposito delle guillemet o duck-foot (zampa di papera), le francesi e italiane, quindi continentali, «sergenti». E io, continentale, nei circa cento libri che ho portato dallo stato di manoscritto a quello di libro pubblicato, tra testi miei e traduzioni, ho sempre usato le «sergenti», a meno che l’editore non ne fosse impedito a causa dei macchinari tipografici con cui stampava.
Una passione insopprimibile, simile al primo amore, divampata quando nell’estate 1975 mi sono trovato davanti agli occhi le bozze del mio primo romanzo. Una frase, in particolare, a metà di pagina 10, che è poi la seconda: Domandava sempre «sono spettinato?»… Chiamalo evento traumatico, chiamalo come vuoi, ma per me quella modifica di segni, la trasformazione delle tristi “virgolette diritte” del mio dattiloscritto in quelle sontuose «sergenti», rinchiudeva in sé la quintessenza stessa del fatto che il mio fascio di fogli disseminati di segni era diventato, con segni diversi, un libro! Dal bozzolo era uscita la farfalla. E James-Stephen, capace di pensare: “I segni caratteristici di tutte le cose io sono qui per leggere…”, elaborando l’Aristotele di Sensazione e sensibile attraverso il Jakob Böhme di Signatura rerum, sono sicuro che non potrebbe non capire i miei motivi.

Certo, a lui non importava niente che i dialoghi complessi potessero risultare oscuri per il lettore, anzi: più oscurità c’era, più – secondo lui – si introducevano possibili “portali di scoperta”. E come tali arrivava persino ad accogliere in qualche caso gli errori dei tipografi, senza correggerli e ridendone beato; in altri casi, però, poteva essere maniacale nelle sue correzioni. Comunque sia: una cosa è l’oscurità dell’autore, voluta o imposta dalla furia creativa (e come tale subita? Chissà…), una del tutto diversa è quella del traduttore, che potrebbe ingenerare il dubbio: ha voluto rispettare l’oscurità dell’autore o non ha capito bene? Meglio, secondo me, cercare di evitarla.
Quindi vengo a patti con l’ombra di James-Stephen e uso le «sergenti». Ma, ripeto, potessi discuterne con lui sono sicuro che accetterebbe questa mia scelta: come traduttore ho il dovere di offrire un testo chiaro, dimostrando di averlo capito al meglio possibile, e le «sergenti» nei punti complicati lo rendono terso, oltre a consentire in subordine le “tonde” e poi, volendo, a cascata, anche le ‘semplici’, e possono servire per citare espressioni “pensate” o “scritte”.
Joyce non ha originariamente indicato alcuna suddivisione per il suo testo al di là delle tre Parti principali, anche se in seguito ha comunicato schemi di lettura ad amici come Carlo Linati e Valéry Larbaud. Io seguo quindi la suddivisione in Parti ed Episodi che ne è derivata (come nel testo del Project Gutenberg, mentre quello degli Oxford Classics numera soltanto le tre parti). La comprensione del romanzo diventa in tal modo (o almeno mi sembra) molto più agevole, essendo esso semplicemente pullulante di ripetizioni, citazioni e rimandi, che diventano così più facili da rintracciare e confrontare.

Mi è parso invece poco utile tenere conto dei titoli suggeriti da Joyce per parti ed episodi onde connetterli con la vicenda originale dell’Odissea. Chiedo perdono, ma li trovo piuttosto artificiosi. L’Odissea l’ho letta tutta a dodici-tredici anni in italiano, in seconda media, nella traduzione di Ettore Romagnoli. Ci aveva appassionato come un western di quei tempi: avevamo il compagno soprannominato Tersite (era pieno di tic) e il gigantone Agamennone. Il Peloponneso sporgeva con prepotenza ma non era precisamente una penisola… Poi di nuovo ne ho letto qualche canto in greco al liceo. È un’altra cosa, a ciascuno il suo.
D’altra parte Joyce aveva una straordinaria conoscenza del latino (medievale, ecclesiastico), martellatagli in testa dai suoi maestri gesuiti tra una bacchettata e l’altra sulle mani, ma il greco non lo conosceva altrettanto bene. «Bisogna che andiamo ad Atene. […] Ah, Dedalus, i greci! Devo insegnarti. Bisogna leggerli in originale,» dice all’inizio all’imbronciato Stephen-James il debordante Mulligan-Gogarty. E poi, parlando di lui all’Episodio 10 con l’inglese Haines, appassionato di folclore irlandese: «Non coglierà mai la nota attica.» Ed è lo stesso Joyce, in una lettera del giugno 1923 a Harriet Weaver a scrivere: “Io il greco non lo so nemmeno, sebbene mi si consideri un erudito…”
All’Episodio 16, intitolato “Eumeo” negli schemi, si capisce che l’Ulisse dell’Odissea non è Bloom ma Murphy, misterioso marinaio di nome incerto e barba rossiccia che ha navigato dappertutto, ha una moglie che lo aspetta su un’isola e un figlio partito per mare. Due Ulisse in un libro solo? Troppi. Dunque Bloom non sarebbe Ulisse? Sì, è l’Ulisse del suo tempo e luogo, nel senso che arranca per una ventina di ore (a cavallo di due giorni, si badi bene, non di uno solo, dal mattino del 16 all’alba del 17 giugno 1904) nel coloratissimo ma limitato universo del romanzo (Dublino) senza mai metterne fuori il naso, all’unico fine di tornare a casa dalla moglie nonostante tutta la sua presunta sfilza di proci. Bloom discende da “ebrei erranti”, certo, ma non ha mai viaggiato sul serio in vita sua: già l’idea di andare a trovare la figlia a Mullingar (un’ottantina di chilometri) lo fa sudare freddo, il suo grandioso sogno è arrivare fino a Londra da Dublino seguendo l’itinerario lungo per mare che aggira il sud dell’Inghilterra. Non ha un figlio maschio, con suo struggente rammarico. Ha effettivamente una moglie che lo aspetta a casa, ma a poche centinaia di metri di distanza, e non precisamente impegnatissima a difendere il talamo nuziale dalla famosa sfilza di corteggiatori.

Allora chi è davvero Bloom? «Bloom. Di Bloom. A Bloom. Bloom,» dicono le inquisitive guardie della città notturna. Un’entità declinabile e adattabile al momento. Leggiamo ancora Mulligan-Gogarty che parla di Stephen con Haines all’Episodio 1: «Quello lì [Stephen Dedalus, James Joyce, preciso io] dimostra per mezzo dell’algebra che il nipote di Amleto è il nonno di Shakespeare, e che lui stesso è il fantasma del proprio padre.» E anche la riflessione di Stephen-James, poco dopo: “il sottile eresiarca africano, Sabellio, secondo cui il Padre era Lui Stesso il proprio Figlio.” E poi caso mai rileggiamo anche le sue elucubrazioni su Shakespeare, famiglia, opere e loro rapporti all’Episodio 9. Per esempio: «Quando […] shakespeare [o chiunque fosse] ha scritto l’Amleto non era solamente il padre del proprio figlio ma, non essendo più un figlio, era e si sentiva il padre di tutta la sua stirpe, il padre del suo stesso nonno, il padre del suo nascituro nipote.»
Lo scrittore crea i propri personaggi (compresi i propri figli e padri: principe Amleto e re Amleto) come doppi di se stesso e come doppi dei personaggi stessi. Bloom è un teosofico doppio eterico di James Joyce, un alter ego adulto del giovanissimo Stephen. Le sue torbide fantasie erotiche sono quelle che l’autore è renitente a divulgare di se stesso. Leggiamo l’acuto commento scritto dal fratello Stanislaus ai primi avatar dell’autobiografico Stephen (Stephen Hero e Ritratto dell’artista da giovane): “Si pensa che Jim sia molto franco su se stesso, ma il suo stile è tale che si potrebbe sostenere si stia confessando in lingua straniera: confessione assai più facile che in lingua volgare.” E in ogni caso il lettore avvertito sa che dal famoso monologo della signora Bloom che chiude il libro (comprese ortografia, punteggiatura, grammatica e sintassi) trasuda un concentrato dell’erotismo che infarciva le audacissime lettere dei due assatanati giovani sposi quando si trovavano separati. Sposi? Quali? Ma James Joyce e sua moglie Nora Barnacle, naturalmente. E non è Stephen costruito a specchio di James? Quindi il Bloom sposato con Molly altri non è se non un doppio del James-Stephen sposato con Nora.
Infatti fra Stephen e Bloom non si stabilisce affatto un rapporto figlio-padre, per quanto il promotore pubblicitario Bloom si arrabatti, promuova, pubblicizzi e mercanteggi. Anzi, il primo finisce con l’essere discretamente infastidito dall’altro, dal doppio che ha creato lui stesso, come del resto il suo creatore alter ego è infastidito da una grandissima parte del mondo che ha conosciuto (non proprio tantissima). Gli canticchia addirittura un’offensiva filastrocca antiebraica: al fondo non si fida di lui. E non appena può lo pianta in asso, uscendo con lui dall’oscurità della casa alla penombra esterna “oscuri in doppio”. A quanto pare se n’era saturato se non infastidito lo stesso Joyce, se è vero che in una lettera del maggio 1921 a Claud Sykes scriveva di essere alle prese con l’Episodio 17, “Itaca”: “una sublimazione matematico-astronomico-psico-meccanico-geometrico-chimica di Bloom e Stephen (il diavolo se li prenda entrambi).” Stephen vagava alla ricerca di un padre, credeva di esserselo creato, ma non è stato così. Comunque, quando incontra il vero padre di Telemaco, nel Rifugio del Vetturino eletto a capanna di Eumeo, non se ne accorge nemmeno: non gli interessa. È troppo preso nella ricerca del vero se stesso per accorgersi di padri o altro.

Per concludere, ritengo narcisisticamente opportuno spiegare perché tanto tempo fa ho deciso di provare a tradurre l’Ulysses, interrompendo poi il lavoro per molti anni. Nel 1960, durante il noioso e malinconico servizio militare a Padova, non avendo niente di meglio da fare, il pomeriggio mi chiudevo nella “biblioteca” della caserma (sedie e tavoli, nemmeno un libro) a “studiare”. In effetti preparavo i miei esami di economia alla lontana Bocconi, ma soprattutto scrivevo, su fogli protocollo, con una penna Koh-i-noor a inchiostro di china. Perché scorresse alla perfezione e non frenasse il flusso della mia creazione ne pulivo meticolosamente il pennino con un brandello di carta abrasiva: avevo ventun anni. Ne venne un romanzino che secondo me si intitolava Il merdone: l’ineluttabile, confusa, persino dolorosa condizione del passaggio di un maschio dall’adolescenza all’età adulta. Rimase lì com’era (e dovrebbe essere ancora lì), un fascio di fogli sbiaditi. Andò persino perso, alla Casa della Cultura di Milano, dov’era stato lasciato dalla musicologa e compositrice elettronica Teresa Rossi Rampazzi, che avevo conosciuto a Padova e me lo aveva chiesto in lettura, senza evidentemente trarne molta soddisfazione. «Oh, be’, scrivine un altro,» mi disse, quando l’informai della scomparsa. Era una bella sagoma anche lei. Ricomparve miracolosamente qualche tempo dopo tra gli scartafacci di un uomo di teatro milanese che alla Casa della Cultura aveva fatto uno spettacolo. Si chiamava Rossi anche lui – per questo, essendo contrassegnato “Rossi” (ma si trattava di Teresa), il mio manoscritto era finito tra le sue carte –, però purtroppo non ricordo il nome e non ne ho mai avuto altre notizie. Fu bravissimo e gentilissimo, mi rintracciò attraverso la Casa della Cultura e andai a casa sua a recuperare il manoscritto.
Nel frattempo (18 ottobre 1961: è scritto a matita e firmato sul libro) avevo comperato e divorato il Ritratto dell’artista da cucciolo di uno dei miei idoli poetici: Dylan Thomas. “Cucciolo” io lo avrei tradotto “giovane cane”, anzi tutto perché secondo me rende molto meglio l’idea del grande abbaiare che Thomas fa in quei racconti, ma sopra tutto perché il titolo inglese di quel libro è Portrait of the Artist as a Young Dog e discende direttamente dal Portrait of the Artist as a Young Man di Joyce, che avevo già letto in originale. Eccolo lì il titolo del mio romanzino per fogli protocollo e penna Koh-i-noor: Il (ritratto dell’artista da) lupo bambino. A poco più di vent’anni si ha diritto a essere presuntuosi? In seguito si può semplicemente peggiorare. Sia come sia, con quel titolo il mio primo romanzino è finalmente uscito nel 1975 (Marsilio Editori, molto compianto e carissimo amico Cesare De Michelis). E con esso, come ho scritto sopra, è nato il mio insopprimibile primo amore per le «virgolette sergenti»…
Il mio progetto di tradurre l’Ulysses, avventurosamente e presuntuosamente avviato agli inizi degli anni settanta, mentre mi annoiavo non più a Padova ma a Firenze (colpa mia), si era però dovuto arenare al primo centinaio di pagine o giù di lì. Anzi tutto, per campare dovevo tradurre quello che mi commissionavano gli editori, ma sopra tutto l’Ulysses era troppo difficile. Dopo aver ripreso più volte in mano il progetto negli anni ottanta e novanta, nel duemila avanzato – essendomi lasciato 71 traduzioni e con esse “un grande avvenire dietro le spalle” – ho creduto di potermi finalmente sentire adeguato al compito, quindi eccolo qui. È un testo di grandissimo fascino, in larga misura anche proprio per le sue oscurità volute o indotte, i suoi giochi di parole, le sue onomaturgie. È del tutto possibile che qualche errore mi sia scappato. Prego il lettore di perdonarmi e di ricordarsi che, gli “errori sono […] i portali della scoperta”… O magari, semplicemente, interpretazioni personali dell’autore-traduttore.
