«[…] senza parole, non c’è niente. Le parole sono la sensazione stessa che nasce, che si mette in moto.»
(Les Fruits d’Or, Nathalie Sarraute)
Nathalie Sarraute nasce il 18 luglio 1900 a Ivanovo, in Russia, punto di partenza di una serie di peregrinazioni a seguito dei genitori tra Francia, Svizzera, Inghilterra e Germania, attraverso le quali percorrerà tutto il ventesimo secolo. Forse è proprio nella matrice multilinguistica che bisogna rintracciare la sua fascinazione per il linguaggio, nella duplice dimensione di significante e significato.
Autrice di romanzi, pièce teatrali e saggi sulla scrittura e sul Nouveau Roman, o “anti-romanzo”, Sarraute consacra la sua vita di scrittrice alla ricerca del linguaggio più adatto a esprimere tutta la complessità della realtà, senza volerla meramente copiare o imitare su carta, processo che necessariamente risulterebbe nella riproduzione di una “realtà di superficie”, ma cogliendone l’essenza e trasmettendo la sua personale esperienza, all’interno di un dialogo dove il lettore non è più destinatario passivo, ma soggetto attivo che esperisce il romanzo in modo del tutto unico e autentico, in uno scambio fluido che si plasma continuamente.
Per fare questo, Sarraute opera una dissoluzione degli elementi romanzeschi tradizionali dove lettore e personaggi giacevano fino ad allora in spazi separati e ben definiti: questi ultimi, come affermato da Bénard in L’Annuaire théâtral: revue québécoise d’études théâtrales, diventano materia anonima «essendo privati […] di tutta l’apparenza, di ogni scorciatoia, forzando lo spirito a mantenersi sempre sull’attenti».
I personaggi sarrautiani, infatti, spesso non hanno un nome proprio, ma vengono designati rispettivamente alla prima o alla terza persona singolari nei romanzi e con semplici lettere e/o numeri (come U1/U2 per uomo e D1/D2/D3 per donna); non vengono mai descritti fisicamente, ma vengono colti nel loro relazionarsi con gli altri, nei dialoghi, perdendo la loro cristallizzazione e muovendosi in confini fluidi e mai definitivi, costituendo così un semplice vettore per descrivere al lettore «quelle sensazioni così intense, ma brevi» che «si nascondono dietro le conversazioni più banali e i gesti più semplici» in «un tempo che non è più quello della vita reale, ma un presente smisuratamente dilatato» (L’Ère de Soupçon).
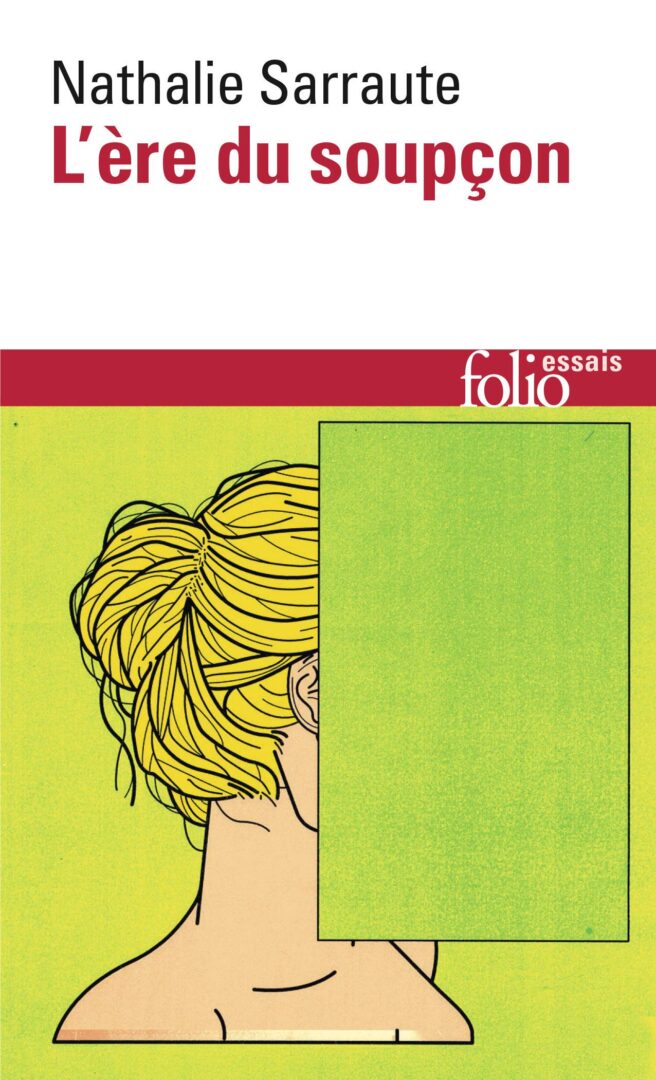
Sarraute spiegherà questa evoluzione del romanzo confrontandolo con un processo analogo avvenuto nell’arte a partire dagli impressionisti che consiste nello «strappare l’oggetto dall’universo dello spettatore e deformarlo per farne scaturire l’elemento pittorico», come delineerà nella serie di articoli, raccolti sotto il titolo Età del sospetto (Nonostante edizioni), ovvero l’età in cui il lettore non crede più ciecamente al narratore e viceversa, considerati il manifesto del Nouveau Roman e pubblicati tra gli anni tra il 1947 e il 1956 su diverse riviste letterarie francesi, tra cui quella di Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, Temps modernes.
Proprio Sartre riconoscerà l’unicità di Sarraute e scriverà la prefazione al suo secondo romanzo, Portrait d’un Inconnu (1948), dove in poche righe ne descrive perfettamente le intenzioni:
I libri di Nathalie Sarraute sono pieni di questi momenti di panico: si parla, qualcosa sembra scoppiare, illuminare improvvisamente il lugubre fondo di un’anima e ognuno sente le sabbie mobili della sua. E poi non accade: la minaccia viene rimossa, il pericolo viene evitato, si ricomincia a scambiare nuovamente luoghi comuni come nulla fosse. Questi però talvolta crollano e appare la spaventosa nudità protoplasmatica: “Sembra loro che i loro contorni si dipanino, si allunghino in tutte le direzioni, le corazze, le armature si crepano su tutti i lati, sono nudi, senza protezione, scivolano intrecciati gli uni agli altri, scendono come in fondo a un pozzo… qui, dove stanno scendendo come in un paesaggio sottomarino, tutte le cose hanno la capacità di vacillare, oscillano, irreali e precise come oggetti in un incubo, si gonfiano, assumono strane proporzioni… una grande massa molle che preme su di essa, la schiaccia… cerca goffamente di uscire un po’, sente la sua stessa voce, una voce strana, troppo neutra…”. E non succede niente: non succede mai niente.
La trama, così come i personaggi, si dissolve poiché la scrittrice è interessata soltanto al significato profondo, alla «sotto-conversazione», a quei «fremiti quasi impercettibili» che chiama «tropismi», che danno il titolo al suo primo romanzo e che sono quei «movimenti indefinibili, che scivolano molto rapidamente ai limiti della nostra coscienza; sono all’origine dei nostri gesti, delle nostre parole, dei sentimenti che manifestiamo, che crediamo di sperimentare e che è possibile definire. Mi sembravano e mi sembrano ancora la fonte segreta della nostra esistenza».
E per lo stesso motivo, materiale di prim’ordine per le sue opere è costituito dal «nostro piccolo stock» di «luoghi comuni», che non creano confusione poiché sono solo superficie, non ricoprono nulla e «di cui ci serviamo in caso di bisogno», come afferma uno dei personaggi della pièce Isma.

Così in L’usage de la parole (L’uso della parola, SE) analizza espressioni comunemente usate, i lieux communs, e, rompendone la corazza, le sbriciola e le ispeziona come un chirurgo per estrarne il senso profondo e nascosto. E si diverte nel farlo sprigionando un’ironia a tratti sardonica attraverso conversazioni folli e alienanti. Come quella unilaterale fra due conoscenti, che continuano a incontrarsi a intervalli regolari – nonostante uno dei due parli senza sosta e l’altro non dica mai niente – per l’apparente inspiegabile bisogno impellente dell’uno di accomiatarsi dall’altro con la frase «a presto» per poi fissare immediatamente l’incontro successivo. La spiegazione di questa necessità sta nel fatto che «ci si trova davanti a quel monumento che porta inscritto sul frontone… si dica pure in “lettere d’oro” per sottolineare il suo carattere eminentemente rispettabile, imponente… Amicizia. […] un’istituzione da cui non si può uscire senza un lascia passare rilasciato solamente per delle solide ragioni…». E si ricorre all’espediente di tali espressioni convenzionali proprio per questa impossibilità, inconscia e quindi inespressa o inesprimibile, di uscire da queste «istituzioni».
Sarraute intraprende dunque la missione di «esprimere l’inesprimibile», maneggiando il linguaggio «per disfare le costruzioni ingannevoli o semplicemente illusorie della lingua del mondo» per esprimere la materia psicologica provando a inoltrarsi nei meandri della psiche.

E se nel romanzo questi tentativi risultano più complicati, a causa della natura del mezzo, il teatro costituisce per Sarraute una détente.
In Pour un oui ou pour un non, la sesta pièce di Sarraute, due amici si ritrovano dopo qualche tempo e uno dei due chiede all’altro per quale motivo si sia allontanato. Ne scaturisce uno scambio di battute tanto ammaliante quanto straniante, che sfiora il reame dell’assurdo. La lingua non è semplice mezzo di comunicazione, ma un’arma potente che uno dei due uomini inizialmente «non osa» utilizzare, sebbene siano «solo delle parole».
La spiegazione dell’allontanamento, che si forma faticosamente pezzo dopo pezzo attraverso il dialogo dei due, sta in una semplice frase: «C’est bien ça», pronunciata dall’amico in risposta al racconto dell’altro di un suo successo. Ma non solamente sulla frase in sé, bensì sul tono e sul ritmo che accompagnano la sua enunciazione: «C’est bien…ça».
Una risposta apparentemente banale, ma che attraverso il modo in cui viene pronunciata diventa insulto, disprezzo, condiscendenza e una serie infinita di altre venature e sfumature, di cui quando dialoghiamo possiamo percepire talvolta gli effetti senza mai eseguire l’analisi lucida e spietata che ne fa genialmente Sarraute attraverso i suoi dialoghi.
[1] Arnaud Rykner a Pour un oui ou pour un non, Nathalie Sarraute, Gallimard (1999), p. 7.
Traduzione dei testi a cura di Alessandra Corsi
