Perturbamento (Adelphi, 1981) è un romanzo (o antiromanzo, se si volesse tener fede ai precetti più formalistici della critica sul genere in questione) paradigmatico dell’intera parabola letteraria di Thomas Bernhard, perché contiene e sussume gran parte degli stilemi, delle caratterizzazioni e delle figure tipiche dello scrittore austriaco. Entro il perimetro d’una scenografia montagnosa e arida (locus amoenus rovesciato), spaccato avvilente di un Austria rurale e all’abbandono, in cui la degradazione della natura sembra riflettere appieno la degradazione dell’umano, la scrittura di Bernhard scava in profondità, come in apnea, sostenendo una traiettoria narrativa che si nutre della propria verticalità, non solo temporale ma ontologica, per mezzo di un linguaggio scarnificato, ridotto allo scheletro e dunque potente, semanticamente pregno, abile a scandagliare ossessivamente gli anfratti più cupi dell’affresco esistenziale che viene via via svelato.
Del resto, che Bernhard sia un autore naturalmente predisposto al rovescio ombroso delle cose, alla dimensione ostativa insita nelle situazioni-limite, emerge con chiarezza anche dalla sua intervista rilasciata a Peter Hamm sul finire del ’76, oggi pubblicata in Italia per la prima volta dalla casa editrice pesarese Portatori d’acqua col titolo Una conversazione notturna. La conversazione tra i due avrebbe dovuto aprire a mo’ di introduzione un volume di saggi che la Suhrkamp aveva in programma di dedicare all’opera dello scrittore austriaco; tuttavia, dopo averne letto la trascrizione, Bernhard vietò categoricamente a Hamm di utilizzarla, forse perché si rese conto che, durante quel dialogo notturno ad alta gradazione alcolica, troppo della sua infanzia era stato sviscerato, troppi di quei demoni che avrebbero poi abitato alacremente le pagine dei suoi romanzi di matrice autobiografica – come ad esempio La cantina, Il respiro, Il freddo, Un bambino – erano stati messi sul piatto, abozzatti con eccessiva nonchalance.
Dalla lettura del prezioso pamhplet (curato da Mauro Maraschi e Micaela Latini, tradotto da Elsbeth Gut Bozzetti) traspare la figura di un uomo, prima che di un intellettuale, sempre posizionato “contro”, sin dagli anni raminghi di formazione: contro l’ottusità predominante, contro l’ordine, contro i compromessi, contro le false adulazioni, contro la famiglia e le sue restrizioni, contro i conformismi e gli obblighi imposti dall’esterno. Gli anni inquieti e solitari dell’adolescenza, caratterizzati dalla fascinazione altalenante per il nonno scrittore, da una salute precaria e dalla smania pressante d’essere sempre altrove, sono votati – racconta sagacemente Bernhard – oltre che alla conoscenza e alla pratica musicale – eredità fondamentale per la formazione e la messa a punto delle strategie compositive con cui strutturerà le future prove narrative –, a un vitalismo antinomico e irrisolto, che traslerà poi al fondo dei suoi testi. Nello stesso periodo va sviluppando una curiosità irriducibile, che lo stesso Bernhard definisce «primitiva, animale», nei confronti delle forme del reale, dalle sue declinazioni latenti a quelle più manifeste. Nonostante la consapevolezza che in fondo tutta l’esistenza dell’uomo si riveli essere nient’altro che una lenta e insofferente ripetizione di fenomeni pressoché identici, lo scrittore austriaco nutre un inestinguibile interesse per le infinite possibilità disvelate dall’applicazione di uno sguardo ogni volta differenziato, di una prospettiva ogni volta scostante, in grado di attuare un processo di dislocazione estemporanea delle costellazioni immobili del presente, nonché uno straniamento improvviso del panorama percettivo e cognitivo.

Non sorprende allora che Perturbamento, uno dei suoi più fulgidi capolavori, sia percorso da una tensione sopita, sonnambolica, capace di innescare scosse telluriche quasi insondabili che producono smottamenti lievi e però profondi, destinati ad esacerbare il trauma celato e incombente, sempre pronto a emergere e ad affiorare in superficie. Il narrato di Bernhard si ciba, qui come in molti altri suoi romanzi, di una violenza sottaciuta, che da un momento all’altro pare debba scardinare definitivamente la razionalità della dialettica e della struttura che la ingloba. Calato dentro lo spazio di una geografia negativa, contenente solo vestigia e rimasugli dell’antica e fiorente cultura e socialità, va in scena un climax ascendente che, passando attraverso vari gradi intermedi, personaggi mediocri e brutali – Bloch, la signora Ebenhöh, i vecchi Fochler – arriva sino all’apice, alla solitudine dorata del principe di Saurau, il cui vaniloquio torrenziale capovolge totalmente il quadro romanzesco sin lì costruito, sconquassandone, con le sue riflessioni acuminate e i suoi improperi inconsolabili, la tessitura, le dinamiche interne e la stessa legittimità.
Ciò che Bernhard intende problematizzare, seguendo un doppio livello di significazione che termina appunto nel suo culmine aporetico e non sintetizzabile, è il rapporto padre-figlio, la cui specificità contingente si presta da subito a una valutazione interpretativa universale, che mette in questione il problema insolvibile dell’ascendenza e dell’origine. Ecco allora che Perturbamento si configura come un lungo e angosciante commiato dal tempo presente, anacronistico e tossico prolungamento di un passato ingombrante e ormai irripetibile, la cui stretta tardiva e recalcitrante sembra però spegnere in partenza ogni tentativo (che sia davvero tale e non solo fumosamente proclamato) di rinnovamento e rivoluzione. Sotto il giogo di un retaggio atavico e ancestrale, i padri, miseri ed impotenti, ereditano una colpa primordiale e insormontabile, un’onta dalla fisionomia indefinibile che grava sui gesti, sulle sensazioni, sugli affetti, indebolendone la portata e il valore, deputata poi ad affliggere anche i figli, rei di prolungare la sofferenza, anch’essi vittime inconsapevoli di una maledizione secolare.
Orfani di senso, di un centro saldo a cui tornare, i padri e i figli, lontani o vicini, odiati o amati, si affidano ad un linguaggio spezzato, tendente al balbettio e costretto alla marginalità, a un’affermazione antitetica e ostracizzante di se stesso. Incapace di affermare, forse perché tutto è stato già detto e ripetuto, l’io narrante (il figlio del medico) si sostanzia in quanto testimone, attento e neutrale, nell’eterna giostra di citazioni e parodie, costituendo un resoconto obiettivo che manifesta tuttavia un’ansia di comunicazione, seppure secondaria e traslata, depositatasi lì dove l’irruzione primogenita e violenta si è placata e raffreddata, come se fosse necessario mediare, filtrare, far resistenza all’assalto verbale e mentale delle riflessioni, delle azioni e dei propositi. Soltanto la distanza permette di intravedere, di cogliere attraverso rapidi ed estemporanei attimi di consapevolezza superiore il vulnus magmatico ed eteroclito dell’esperienza, delle cause e delle conseguenze.
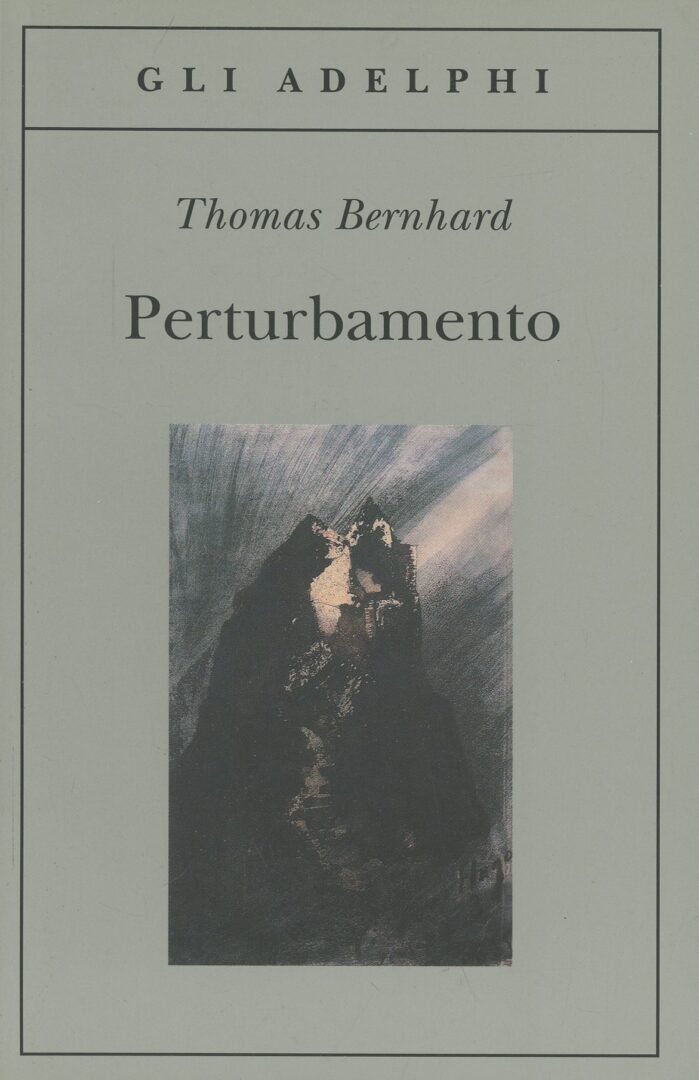
La prosa concitata ma precisa di Bernhard, puntuale nel restituire i lineamenti labili di chi ha superato uno stato certo d’umanità per addentrarsi in territori oscuri e ignoti, si fa carico di dar voce (forse per l’ultima volta) a uno sparuto gruppo di persone alla deriva, smarrite, che paiono rimanere sulla terra unicamente per onorare una sorta di meccanica coazione a ripetere, fantasmi vuoti, sorretti malamente da una retorica nostalgica e incline all’esplosione folle e incontenibile. Circondati da un paesaggio tetro e agonizzante, correlativo oggettivo della precaria condizione esistenziale di chi continua, trascinandosi per inerzia, ad abitarvi, i personaggi di Perturbamento vorrebbero rinnegare con ferocia e spregio lo splendore ingannatore del tempo che fu, con tutta la sua eredità divenuta inconoscibile e irrintracciabile – l’estro, l’intelligenza, l’immaginazione –, ma non ci riescono, rimanendo invischiati nella stessa melma da cui tentano di liberarsi. Le loro malattie, reali e simboliche, divengono metafora dell’isolamento, dell’incomunicabilità, dell’estinzione non più rimandabile di un’intera mitologia (borghese e non) di riti, relazioni e abitudini. Le costruzioni tradizionali, solite e abusate, di ordine e costume cedono sotto il peso dell’insignificanza dei giorni, su cui incombe il nulla dell’avvenire, presagio d’una escatologia entropica, destinata a implodere.
Dalla piatta procrastinazione di un reale sempre identico a se stesso emerge la figura apicale del principe Sarau, che lo stesso Bernhard definisce nell’intervista rilasciata ad Hamm «principe folle […] non-innocuo e non-idiota». Davanti al soliloquio di rara potenza prosodica e concettuale del principe, tentativo estremo di nominare filosoficamente le vicende e di significare gli avvenimenti e i loro affetti, il protagonista e il padre si acclimatano, assumendo un atteggiamento di passività interessata e quasi estatica, come di fronte allo spettacolo di una marea che cresce vorticosamente sino a invadere la battigia e la spiaggia e poi le strade e i cortili, forse perché vi scorgono ancora la possibilità di un acuto originale, l’espressione apocalittica e però genuina del proprio impazzimento.
Chiuso nel suo castello, rintanato nel suo cervello, tramortito da una tensione cerebrale costante e priva di ogni appiglio concreto, sociale e morale, il principe sacrifica la sua salute, oramai inutile, sull’altare di un’astrazione estenuante, malsana e sadica. Parlando a se stesso (il medico e il figlio sono spettatori per lui marginali, così come ogni altro eventuale interlocutore) il principe accetta e interiorizza il dolore del proprio fallimento, nomina la propria paralisi, raccontandosi una storia che intende prolungare stancamente il silenzio finale dell’addio e dell’abbandono definitivo. Invece, al netto del farfugliamento disperato e accecante del principe, è solo nello spazio della complicità muta che si stabilisce tra il medico ed il figlio, che si gioca la sopravvivenza dell’ultimo possibile spiraglio di condivisione, amore e conoscenza. Mettendo alla berlina la vacuità di verità antiquate, non più combacianti alla realtà cupa e desolante dei giorni futuri, la scrittura di Bernhard, così come quella di Beckett, tratteggia con nettezza e concisione l’assurdo, prendendosi una rivincita sull’insensatezza del mondo.
