Giorni frenetici come Milano, desolati come Bangui, illusori come Parigi, imprudenti come New York, sfaccettati come Buenos Aires. Spazio e tempo: elementi che si contengono l’uno nell’altro, mettendo in relazione lo scorrere dell’esistenza con le linee dell’urbanistica, la lontananza geografica con la contemporaneità emotiva.
Il romanzo Le città e i giorni di Filippo D’Angelo, uscito per Nottetempo, si serve di queste connessioni per raccontarci una disconnessione già avvenuta, una biforcazione narrativa il cui punto d’origine sta così indietro da non avere più importanza. Maurizio ed Emanuele sono due fratelli che non hanno più contatti da tempo. Le loro strade si dipanano in città spaventosamente distanti e in giorni dal ritmo totalmente diverso. Vite divenute parallele che in qualche modo si guardano, non senza una punta di rancore, senza più incontrarsi. Quasi a voler calcare la mano su questa lontananza, D’Angelo realizza un romanzo doppio, con due archi narrativi raccontati a capitoli intermittenti, come in un film a montaggio alternato.
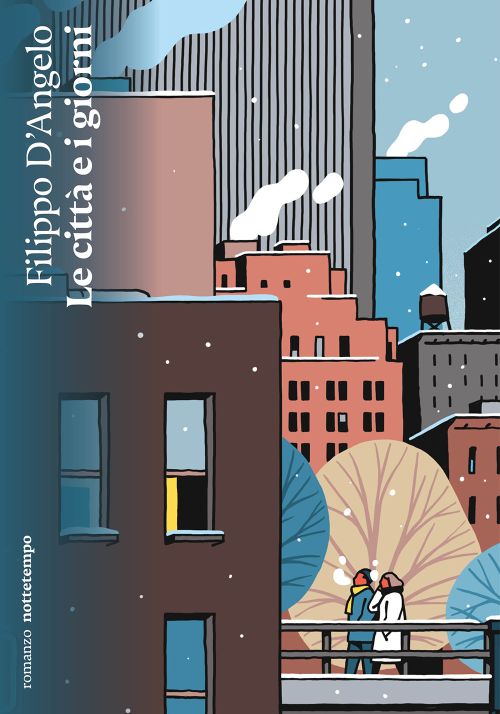
I capitoli dispari sono dedicati a Maurizio, di professione architetto, rampollo di terza generazione di una blasonata famiglia di architetti milanesi. Vive a Parigi, a distanza di sicurezza da suo padre, con una moglie e una figlia piccola. L’instabilità silenziosa del suo equilibrio familiare inizia seriamente a scricchiolare quando il padre lo richiama a Milano per proporgli di partecipare alla costruzione di un grattacielo in collaborazione con un’archistar d’oltremanica. Maurizio torna allora nella sua città d’origine, dove è costretto ad affrontare le insoddisfazioni di sua moglie, l’autorità ingombrante di suo padre e gli eccessi di Ariel, il figlio dell’archistar, personaggio tragico e falstaffiano, riflesso deformato delle sue stesse problematiche esistenziali.
I capitoli pari ci portano invece nella Repubblica Centrafricana, luogo scelto da Emanuele per la sua personale fuga dalla schiacciante tradizione familiare. Nel prestare servizio presso organizzazioni umanitarie, si ritrova a indagare su un caso di abusi sessuali commessi da due soldati francesi ai danni dei bambini di alcuni villaggi. Per farlo deve addentrarsi nell’essenza più profonda di un popolo che, ai suoi occhi di “bianco”, sembra aver assorbito la subordinazione e l’invasione rendendole parte della propria identità e dunque della propria cultura. Lo stesso Emanuele, pur nelle sue velleità altruistiche, è parte integrante di questa dinamica, dal momento che ha sulla coscienza un suo personale peccato di “dominazione” con cui dovrà fare i conti.
Due storie che, dicevamo, non si toccano mai – per farlo bisognerà riavvolgere il nastro, cambiare carattere di scrittura in un capitolo non numerato – ma che rappresentano comunque due facce, neanche tanto opposte, della stessa fuga. Una fuga che in entrambi i casi appare la conseguenza naturale per chi è cresciuto in un ambiente familiare tutt’altro che rassicurante. Più che dai genitori in sé, i protagonisti sembrano proprio incapaci di convivere con il concetto stesso di famiglia. Tra le pagine di D’Angelo, chiunque sia padre, madre, moglie o marito si porta addosso colpe di cui è più o meno consapevole, atteggiamenti tossici che incidono in qualche modo sui figli, i quali a loro volta si preparano a essere madri e padri altrettanto discutibili. La famiglia è allora il luogo da cui si fugge. Maurizio fugge da suo padre e rende infelice sua moglie, si allontana da lei, la tradisce ripetutamente. Emanuele scappa in Africa per poi darsi di nuovo alla fuga di fronte alle responsabilità di un’annunciata paternità.
Ma dove conducono tutte queste fughe? Ci riportano immancabilmente all’inizio, alle città e ai giorni, si fugge nello spazio e nel tempo, ci si allontana in quanto infelici per riscoprirsi a perpetuare quell’infelicità altrove. Emanuele e Maurizio si portano dietro un cordone ombelicale d’insoddisfazione, con cui contaminano tutto e tutti, infettando chi gli sta intorno e ponendo il proprio dolore come falsa e insufficiente giustificazione. Un veleno che raggiunge persino il lettore, che se in un primo momento tende a empatizzare coi protagonisti, man mano che inizia a conoscerli davvero, entrando sempre di più nelle loro contraddizioni, finisce per prenderne le distanze.
Tale destabilizzazione si riflette anche nello stile di D’Angelo: la sua prosa si mantiene alta, a tratti anche molto ricercata, ma talvolta si abbandona d’improvviso al turpiloquo, parolacce che ci colgono di sorpresa come un rapace in picchiata e restituiscono la giusta crudezza ad atti e atteggiamenti squallidi.
Le città e i giorni è insomma un libro tutt’altro che accogliente, racconta la fuga ma ne rifiuta la fin troppo diffusa visione romanticizzata, non la vede come un’opportunità ma come un eterno rinnovarsi del dolore, un ramificarsi che non sembra avere fine. Scappare è un pessimo modo di percorrere spazio e tempo, di abitare le città e vivere i giorni. Voltare le spalle ai nostri fantasmi, rifiutare di affrontarli, ci trasforma a nostra volta, e inesorabilmente, nei traumi di qualcun altro.
E allora forse anche il nostro dissociarci di lettori, quella distanza emotiva dai personaggi nasconde un rovescio della medaglia: non ci allontaniamo da Maurizio ed Emanuele perché rispetto a loro ci sentiamo “giusti”, lo facciamo perché in qualche misura, ci somigliano. Perché di fronte alla sofferenza, alla prevaricazione, al disagio familiare ed esistenziale siamo tutti tentati di fuggire per poi, una volta ricostruito un nucleo di affetti, restituire agli altri quello che è stato fatto a noi. Le città e i giorni invece ci sbatte in faccia ciò che facciamo di tutto per dimenticare, ossia che le nostre ferite non ci danno alcun diritto.
