«Sì, – rispose Abbott – se fosse una bambina simpatica e graziosa si potrebbe anche provare compassione per la sua disgrazia; ma è davvero impossibile preoccuparsi per un rospo del genere.»
«Certo non è granché, – convenne Bessie – comunque una bellezza come miss Georgiana, nella stessa situazione, sarebbe molto più commovente!»
(Jane Eyre, Charlotte Brontë).
Prima che salvare il mondo, dunque, la bellezza – secondo la Brontë – aiuterebbe anzitutto a salvare (cioè a farsi amare e rispettare) chi la possiede.
Scrive qualcosa di simile, non molti anni prima della Brontë, anche Leopardi:
«Lo sventurato non bello, e maggiormente se vecchio, potrà esser compatito, ma difficilmente pianto. Cosí nelle tragedie, ne’ poemi, ne’ romanzi ec. come nella vita.» (Zibaldone, 6 marzo 1821)
E, tornando più distesamente sul tema pochi mesi dopo, Leopardi spiega come mai in letteratura (e, aggiungerei attualizzando, in ogni genere di fiction popolare) gli eroi protagonisti sono sempre “giovani e belli”:
«Che cosa è la bellezza? lo stesso in fondo, che la nobiltà e la ricchezza: dono del caso? È egli punto meno pregevole un uomo sensibile e grande, perchè non è bello? Quale inferiorità di vero merito si trova nel più brutto degli uomini verso il più bello? Eppure non solamente lo scrittore o il poeta si deve guardare dal fingerlo brutto, ma deve anche guardarsi da entrare in comparazioni sulla sua bellezza. Ogni effetto svanirebbe se parlando o di se stesso (come fa il Petrarca) o del suo eroe, l’autore dicesse ch’egli era sfortunato nel tale amore perché le sue forme, o anche il suo tratto e maniere esteriori (cosa al tutto corporea) non piacevano all’amata, o perch’egli era men bello di un suo rivale ec. ec. Che cosa è dunque il mondo fuorché NATURA? Ho detto che l’intelletto umano è materiale in tutte le sue operazioni e concezioni. La teoria stessa dell’intelletto si deve applicare al cuore e alla fantasia. La virtù, il sentimento, i più grandi pregi morali, le qualità dell’uomo le più pure, le più sublimi, infinite, le più immensamente lontane in apparenza dalla materia, non si amano, non fanno effetto veruno se non come materia, e in quanto materiali. Divideteli dalla bellezza, o dalle maniere esteriori, non si sente più nulla in essi. Il cuore può bene immaginarsi di amare lo spirito, o di sentir qualche cosa d’immateriale: ma assolutamente s’inganna. Così accade in certo modo riguardo allo stile e alle parole, che sono, come ben dice Pindemonte, non la veste, ma il corpo de’ pensieri. E quanto prevalga l’effetto dello stile a quello de’ pensieri, (benché spessissimo il lettore non se ne accorga, né sappia distinguere le cose dalle parole, ed attribuisca a’soli pensieri l’effetto che prova, nel che in gran parte consiste l’arte dello stile) interrogatene la storia d’ogni letteratura».
(Zib., 13 settembre 1821; grassetto dell’autore)
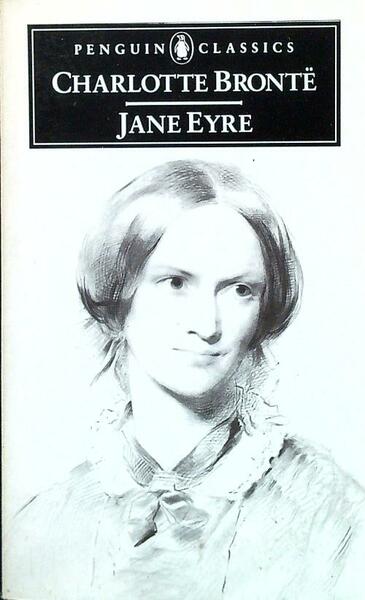
La bellezza di cui parlano Brontë e Leopardi è (per quanto considerata nei suoi effetti sentimentali e morali su chi la percepisce) la mera bellezza fisica, esteriore. Nient’altro. Quella che più che mai oggi spopola nei media. Niente a che vedere dunque con il bello come metafora del bene morale né tantomeno come armonia cosmica o metafisica, cioè con quella bellezza salvifica, per intenderci, cui pare riferirsi la celebre (ma un po’ enigmatica) frase attribuita da Dostoevskij ne L’idiota al principe Miškin. Dunque Brontë e Leopardi muovono da un ambito prettamente naturalistico. Parlano entrambi (poco cristianamente, direi, ma molto modernamente) della determinante influenza del corpo nei giudizi e nei rapporti umani.
In Leopardi il ragionamento, molto più ampio che nella Brontë, prende con tutta (per quanto implicita) evidenza le mosse da un tasto dolente della sfortunata condizione esistenziale del poeta. E tuttavia esso spicca subito il volo verso una rigorosa e tagliente argomentazione filosofica di portata generale. Sono deduzioni che dissacrano e sbugiardano l’ipocrisia di cui si nutre ogni edificante discorso sul primato della “bellezza interiore”. Testimoniano infatti del contrario, secondo Leopardi, sia l’esperienza comune sia soprattutto la sterminata produzione letteraria (oggi, ripeto, ci aggiungeremmo quella cinematografica e televisiva) dove quel primato appare piuttosto riconosciuto da tutti (autori e lettori) alla bellezza esteriore. Quello che in Brontë rimarrà giocoforza una incisiva ma rapida considerazione en passant di un personaggio dentro un contesto narrativo, Leopardi lo esplicita, dunque, e lo approfondisce alla perfezione nel suo pensiero zibaldoniano: il primato effettuale della bellezza esteriore è (piaccia o no) un dato naturale, invincibile e incontrovertibile. Non siamo capaci di riconoscere né di apprezzare spontaneamente alcun bene astratto ove esso non si incarni nella bellezza sensibile di un corpo o di una immagine.
Richiamandosi ad una intuizione del Pindemonte la chiusa del discorso leopardiano sconfina per altro (e per analogia) su di un terreno retorico-linguistico: bellezza esteriore sta a quella interiore come la forma di un testo sta ai suoi contenuti. Parole e stile, cioè, sono il “corpo” delle idee o dei pensieri contenuti in un discorso. È dunque la forma “corporea”, percettibile e attraente di esso a consentirci di essere toccati dal pensiero: non è il contenuto intellegibile in sé a produrre effetto su di noi, ma il suo proporsi ed estrinsecarsi in una forma sensibile.

Conclusioni del genere (ispirate con ogni evidenza al sensismo materialistico settecentesco) contengono, a guardar bene,implicazioni davvero poco rassicuranti. Il sìnolo bellezza interiore/bellezza esteriore non è infatti (o non sempre è) una realtà oggettiva. Può trattarsi molto spesso di una proiezione soggettiva (chiamiamola pure con Leopardi “illusione” o “inganno”…) di chi subisce gli effetti della bellezza esteriore, della persona o della parola. E allora può anche succedere che la bellezza esteriore suggerisca a chi la osserva una bellezza interiore che non esiste: questa possibile dissociazione Leopardi la intuisce già (e la esprime, direi, con drastica amarezza) in un pensiero antecedente al nostro: «Tutto quello che la bellezza promette, e par che dimostri, virtù, candore di costumi, sensibilità, grandezza d’animo, è tutto falso. E così la bellezza è una tacita menzogna» (Zib. 8 Novembre 1820). Ma la focalizzerà a dovere solo una dozzina di anni più tardi (sulla scia della cocente delusione d’amore per Fanny) in Aspasia:
«Raggio divino al mio pensiero apparve,
Donna, la tua beltà. Simile effetto
Fan la bellezza e i musicali accordi,
Ch’alto mistero d’ignorati Elisi
Paion sovente rivelar. Vagheggia
Il piagato mortal quindi la figlia
Della sua mente, l’amorosa idea,
Che gran parte d’Olimpo in se racchiude,
Tutta al volto ai costumi alla favella,
Pari alla donna che il rapito amante
Vagheggiare ed amar confuso estima.
Or questa egli non già, ma quella, ancora
Nei corporali amplessi, inchina ed ama.
Alfin l’errore e gli scambiati oggetti
Conoscendo, s’adira; e spesso incolpa
La donna a torto. A quella eccelsa imago
Sorge di rado il femminile ingegno;
E ciò che inspira ai generosi amanti
La sua stessa beltà, donna non pensa,
Nè comprender potria. Non cape in quelle
Anguste fronti ugual concetto. E male
Al vivo sfolgorar di quegli sguardi
Spera l’uomo ingannato, e mal richiede
Sensi profondi, sconosciuti, e molto
Più che virili, in chi dell’uomo, al tutto
Da natura è minor.»
(Aspasia, vv. 33- 58)
Qui l’effetto perverso e frustrante dell’inganno estetico lo si avverte in tutta la sua dolorosa ampiezza e profondità psicologica: l’avvenenza sensuale della donna produce nell’innamorato l’illusione che quella angelica bellezza esteriore corrisponda a una altrettanto angelica bellezza interiore. Si tratta invece solo di un’ “amorosa idea”, cioè di una immagine, “eccelsa” ma fallace, che l’innamorato si costruisce arbitrariamente dell’amata: in quel simulacro mentale (tutto soggettivo e fantastico), ma solo in quello, bellezza esteriore e interiore coincidono. Nella realtà (conclude Leopardi con accenti di spiccata, sprezzante misoginia) la donna non è all’altezza – come persona – dei pensieri sublimi che la sua bellezza esteriore ispira nell’uomo. Frustrante e tragica agnizione di un divario altrettanto tragico e (ben al di là dell’eros) tipicamente leopardiano: quello tra illusione e realtà. E riconoscimento implicito e definitivo del fatto – aggiungerei – che la bellezza esteriore significa quella interiore solo o soprattutto nella finzione: cioè nell’immaginazione dell’innamorato ovvero nella fiction letteraria (dell’epos, del teatro e del romanzo allora e, oggigiorno,anche del cinema o della tv).
Leopardi arriva pertanto a demistificare fino in fondo,come puro desiderio o illusione, la corrispondenza/equivalenza di bello esteriore ed interiore.
Non trova seguito invece nel Leopardi più maturo l’altro ramo che si era generato, biforcandosi a sua volta, dal tronco del ragionamento principale: il problema del rapporto tra forma e contenuto, significante e significato, corpo e anima del discorso. Se nel tempo Leopardi avesse sviluppato, in direzione altrettanto negativa e coerente con l’altra, anche la riflessione sul legame tra parola e pensiero, allora sarebbe arrivato a toccare facilmente, prima o poi,e a sviscerare a suo modo il tema (tanto caro ai suoi cari Greci antichi) della fallacia della parola. Cioè della retorica che seduce e che inganna, nascondendo o manipolando la verità, anziché rivelarla. In realtà Leopardi non si inoltra nel sentiero tracciato da questa sua intuizione giovanile. Non approfondisce mai il tema dell’inganno “estetico” della parola (pur riconoscendo allo stile una potenza di influsso molto superiore al pensiero). E ciò non accade,forse, per la sua indole radicalmente antiretorica: per lui parola diventa sempre più nel corso degli anni (anche quando rievoca o sprigiona il fascino delle illusioni) ricerca e rivelazione del vero, dolorosa ma coraggiosa demistificazione, ma iastuto o allettante sviamento, né tantomeno ipocrita veste consolatoria.
Leopardi, come si sa, non ha mai scritto romanzi o narrativa popolare. Si è limitato ad abbozzarne qualche progetto. I motivi per cui questi disegni letterari non si sono mai realizzati possono essere molti e non facili da individuare. Ma non escluderei che tra questi ci sia stata anche (o soprattutto?) la sua profonda, crescente estraneità a generi che egli sentiva troppo condizionati, per l’appunto, da stereotipi retorici – affabulatori o edificanti o consolatori che fossero. Il suo scarso interesse per Manzoni e i suoi giudizi piuttosto sommari e tiepidi sui Promessi sposi, per altro, sembrerebbero confermarlo.
Copertina:
Illustrazione di Sonia De Nardo
