In Io e Mr. Wilder, l’ultimo romanzo di Jonathan Coe, l’Io (narrante) a cui il titolo fa riferimento è quello di Calista, una ragazza greca che nel 1976, in viaggio per gli Stati Uniti, per fortuite circostanze è invitata a una cena con Billy Wilder; l’anno successivo, quando a quell’incontro quasi non pensa più, da studentessa di musica ad Atene si ritrova ingaggiata come traduttrice sul set greco di quello che sarà il penultimo lungometraggio del regista. Il film è Fedora (1978), opera crepuscolare che faceva calare il sipario su un’epoca con poetico/patetico ritardo: in esso Wilder riprendeva il William Holden di Viale del tramonto solo per ritrarlo sconfitto dagli anni, nella parte di Barry “Dutch” Detweiler, produttore cinematografico oramai alla frutta. Il progetto su cui Detweiller scommette tutto è un nuovo adattamento di Anna Karenina che può andare in porto solo se accettato da Fedora, una star del passato, segregata nel suo buen retiro in un’isola dell’Egeo. La diva, depositaria di un mistero (ovvio come la sua soluzione), si propone allo spettatore come evidente concentrato simbolico: di un divismo estinto, del glamour che va evaporando, di un cinema sorpassato che si tenta di tenere in vita con un artificio (il finale, con mesta ovvietà, ci dice che l’eterna giovinezza non esiste). Film che, esponendola, pratica la stessa idea di cinema declinante, Fedora è (capolavoro) orgogliosamente anacronistico, reazione in pellicola alla New Hollywood (e ai suoi registi «barbuti») che aveva ridotto in polvere la classicità.
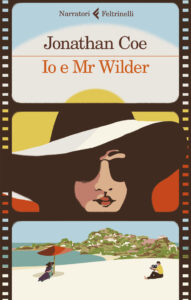
Dunque Jonathan Coe sceglie di raccontare Wilder in un momento critico della sua carriera: se nel 1950, con Sunset Boulevard, il cineasta aveva girato il ritratto al vetriolo di Hollywood e fatto interpretare il personaggio della diva decaduta Norma Desmond a una vera attrice al tramonto (Gloria Swanson, star del muto), nel 1978 egli stesso è diventato come Norma Desmond, un grande artista nel quale il Sistema non crede più. E che è dunque costretto a recarsi in Europa per girare un nuovo film su Hollywood che stavolta gli studios non vogliono produrre, ritenendolo (a ragione, diranno i fatti) non redditizio (« A Hollywood non si legge Cahiers du Cinéma prima di iniziare a lavorare. Si legge l’andamento del mercato»).
Fedora è, dunque, un autoritratto. Decadente e serissimo: tanto che proprio l’assenza di ironia è alla radice di un tacito dissidio tra il regista e lo sceneggiatore Iz Diamond, apparente comprimario nel teatro semiveristico allestito da Coe, ma determinante coscienza interna dello stesso.
Del gioco di specchi di Fedora il romanzo non fa che aumentare i riflessi: così racconta una storia fittizia, quella di Calista, all’interno della circostanza storica del tournage del flop firmato da Wilder. Insomma, se Fedora, trattando realisticamente dell’ambiente hollywoodiano, inseriva, nel suo tessuto narrativo di finzione, personaggi interpretati da attori che ricoprivano il ruolo di se stessi (da Michael York, di cui la diva si innamora sul set, a Henry Fonda, presidente dell’Academy che consegna a Fedora l’Oscar alla carriera), allo stesso modo Coe, facendo eco al film di cui narra la lavorazione, parte da uno scenario veridico, popolato di persone realmente esistite, per dipanarvi all’interno il suo racconto inventato. E per dare sostanza ineccepibile al personaggio-storico-Wilder, gli mette in bocca discorsi che provengono da fonti documentate (l’elenco è contenuto nelle note finali).
Com’è sua consuetudine, però, lo scrittore dispiega la materia su più piani temporali: così, quella della lavorazione del film è una rievocazione che viene esposta dalla voce narrante della protagonista ormai ultracinquantenne. E giunta a un passaggio delicato della sua vita. Un altro rispecchiamento: Calista è infatti in crisi perché nessuno sa più cosa farsene di quelle che sono le sue principali doti, comporre musica per film ed essere una buona madre. Come Billy Wilder al termine della sua carriera, la donna ha ancora progetti da portare avanti a cui nessuno sembra credere. Di più, sembra cadere anch’ella nei pericoli della nostalgia, nel rifiuto della realtà, nella diffidenza del presente, nell’indifferenza nei confronti dello spirito mutante dei tempi. In quella stessa trappola malinconica che portò Wilder a concepire Fedora: così la rievocazione dell’esperienza sul set del film diventa, per la protagonista, un traslato bagno di realtà, un modo di riprendere in mano la propria vita, superando le pastoie del passato e di ciò che significa. Di guardare avanti.
Coe ottiene il caleidoscopico rincorrersi di riverberi e la sofisticata teoria di echi tra realtà storica e letteraria attraverso quella variazione di piani narrativi, modi espressivi e linguaggi a cui la sua opera ci ha abituati. Così la novella racconta Wilder anche come rifugiato di origine austriaca in fuga dal nazismo, presentandone i ricordi nella forma dello script di un film, diviso in scene con contestuali didascalie e dialoghi. In questo frammento risiede anche il momento più intenso del libro: il dialogo tra il cineasta ed Emeric Pressburger in cui il primo confessa di guardare i filmati dei campi di concentramento non solo per l’incarico ricevuto dall’esercito americano, ma anche per ritrovare la madre dispersa. Un flashback doloroso che, da un lato, traccia per il lettore un ritratto introspettivo di Wilder, dall’altro, inaspettatamente, lo conduce al confronto proficuo che il regista ingaggia col presente, alla sua riconciliazione col cinema per come si è evoluto (c’entra Schindler’s List, non aggiungo altro).

Il romanzo, dunque, al di là dell’argomento, dialoga incessantemente col cinema anche come suggestione: così Calista tende a collegare quello che narra alle immagini dei film che ha imparato a conoscere, facendo rimare la realtà romanzesca con il mondo della Settima Arte.
Nota a margine. A ben guardare, in questo personaggio, inizialmente ingenuo e a digiuno di cinema, che, senza averli mai visti, dei film, però può sciorinare a memoria i giudizi della Halliwell’s Film Guide, c’è qualcosa di malignamente ironico: l’insistenza con la quale Calista recita quelle minirecensioni non è forse la presa in giro di certa cinefilia che considera quei volumi non come raccolta di letture, prospettive, sguardi possibili, ma come testi sacri, di cui fidarsi al buio?
