Inverness è la destinazione mancata, che si fa emblema del sentimento non corrisposto. Una sperduta cittadina della Scozia dà il titolo alla perturbante raccolta di racconti firmata da Monica Pareschi, nota traduttrice di grandi nomi della letteratura inglese – da Emily Brontë a Doris Lessing, da Thomas Hardy a James Ballard, per dirne alcuni. A dieci anni esatti dall’esordio nella narrativa con È di vetro quest’aria (Italic Pequod, 2014), in queste pagine Pareschi appare nella veste, forse ai più ancora inedita, di scrittrice.
La lingua è affilata, precisa, capace di scarnificare una sensazione sino all’osso: capiamo subito che il confine è sottile, quanto a padronanza linguistica la Pareschi scrittrice non è per nulla inferiore alla Pareschi traduttrice. Nelle pagine di Inverness (Poliodoro Editore, collana «Interzona», 2024) troviamo perfezione formale, ricercatezza lessicale, un’adesione estrema – quasi feroce – al significato: nessun aggettivo è lasciato al caso, ogni termine evoca un’impressione puntuale, innescando spesso una reazione di inquietudine, oppressione o persino disgusto, nel lettore.
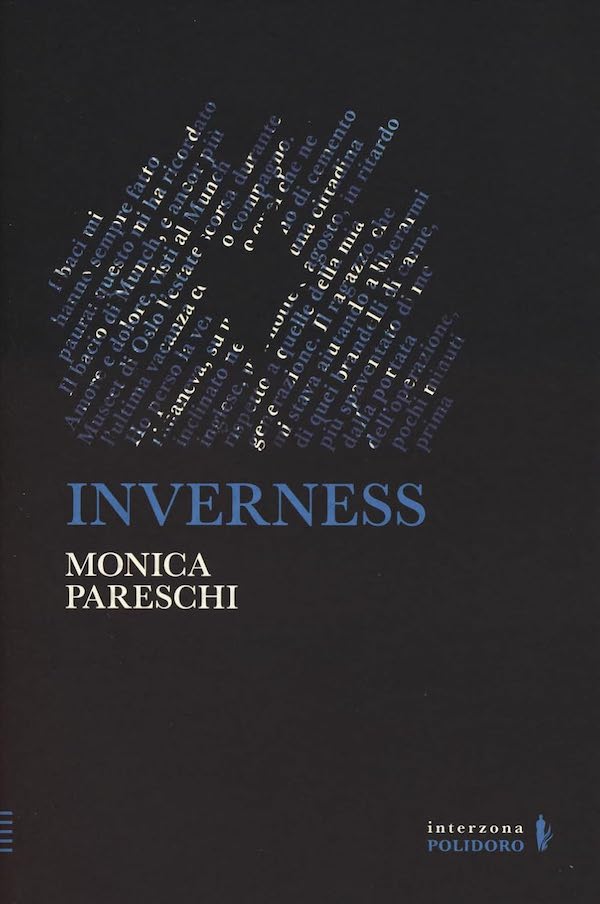
Gli otto racconti che compongono la raccolta si leggono in una tensione irresistibile: uno tira l’altro, possono creare dipendenza. Benché molto diversi tra loro, per temi e personaggi, sono accomunati dalla medesima atmosfera “elettrica” e da alcune caratteristiche in grado di evocare un turbamento sottile, strisciante, che talvolta esplode detonando in vero e proprio orrore, ma il più delle volte non lo fa, rimane latente e oscuro, appena sotto la superficie delle cose, lasciandoci intendere che il “non detto” conta molto di quanto viene messo nero su bianco. Le lacune, le omissioni, sono il vero segreto di questa scrittura che, anche a lettura conclusa, continua a scavare e a insinuarsi nella mente del lettore come una domanda irrisolta.
L’incapacità di vivere (o di comunicare) accomuna tutte le protagoniste femminili di queste storie, ciascuna cristallizzata in un istante segreto del presente – o del passato. Il vero filo conduttore dei racconti di Inverness è una forma di sofferenza prodotta dal contatto con l’altro: ogni relazione è una forma di contaminazione, non se ne esce mai indenni. L’amore è declinato nelle sue sembianze più infernali o scabrose, dall’abuso alla molestia alla cieca volontà di possesso, dall’amore adultero sino al disamore: in Fiori viene messa in scena una parabola del disinnamoramento, una donna osserva l’uomo che ama e viene assalita da una «tristezza senza rimedio». Certe sensazioni insidiose e pungenti sono difficili da raccontare: al principio di un amore, allo sbocciare di un amore, sono stati dedicati fiumi di pagine, tenzoni, romanzi, poesie, ma come raccontare invece il modo in cui le cose finiscono? La rottura – che non si vede, ma c’è, è sottile come un filo strappato – è il vero punto focale di queste storie, l’autrice riesce a far sentire a chi legge quello strappo silenzioso, il momento in cui le cose smettono di congiungersi, di corrispondersi.
«C’è che questi fiori non mi chiedono niente, pensò come gridando. C’è che il loro amore è muto, puro, perfetto, e il mio per loro lo stesso».
Inverness, lo scopriamo soltanto alla fine in quanto dà il titolo all’ultimo racconto, è un luogo: una città scozzese, conosciuta come capitale delle Highlands, la località più a nord del Regno Unito. La meta designata dalla protagonista della storia.
«Andremo fino a Inverness, dico. P. mi guarda con aria interrogativa. E perché? Mi piace il nome, rispondo. Quello che non dico è che è un nome pieno di sole e di luce ghiacciata, azzurra. Un nome che contiene l’inverno».
Il titolo in lingua inglese è probabilmente una sfida sottintesa dell’autrice che, da traduttrice esperta, ben conosce il potenziale evocativo delle parole cosiddette «intraducibili»: Inverness infatti è la chiave di lettura dell’intera raccolta, la «parola assoluta» che comprende – e contiene – tutte le altre. Potrebbe essere tradotta in italiano come “Invernitudine”, un termine desueto.
Non è semplicemente un luogo, come ci suggerisce anche il suono sibilante e lo strascico finale che perdura come un brivido gelato sulla lingua nel pronunciarla: Inverness è uno stato d’animo.
«Io sono niente» dirà a un certo punto la protagonista del suddetto racconto alla sua psicanalista. In quel «essere niente» troviamo la perfetta declinazione di «Inverness» – il suffisso –ness in lingua inglese viene utilizzato per trarre sostantivi astratti dagli aggettivi e indicare così uno stato, una qualità, una condizione. «Essere niente», ecco la corrispondenza: il nulla, sostanza astratta per eccellenza, diventa una condizione esistenziale. Nella cornice del racconto di Pareschi infatti Inverness rappresenta la meta mai raggiunta, ma anche il desiderio infranto della protagonista. Tradurre comporta l’atto di interpretare, talvolta anche di riscrivere: chi traduce è abituato a maneggiare i significati reconditi delle parole, per questo nel titolo si gioca anche con l’ambivalenza interpretativa dell’italiano che coglie in «Inverness» un derivato di «Inverno», conducendo la mente del lettore ad associare immediatamente il termine alla stagione del freddo.
Il racconto inizia facendo l’eco al celebre romanzo breve di Cesare Pavese, La bella estate (1949): «A quei tempi era sempre inverno» scrive Pareschi con un chiaro rimando letterario che ribalta in chiave oppositiva il noto incipit pavesiano: «A quei tempi era sempre festa». In questo caso la giovinezza della protagonista raggiunge l’apice quando incontra P., la nuova compagna di classe dagli irresistibili occhi azzurri. Da quel momento tutto cambia e, nonostante la narrazione segua le vicende per un lungo arco narrativo che include vari intermezzi estivi, si ha la sensazione – anche grazie al magistrale gioco linguistico – che sia l’Inverno, con la sua luce lattea che annacqua gli occhi e confonde i contorni, a dominare. È come se Inverness fosse in realtà il riflesso della condizione esistenziale della protagonista: incapace di sbloccarsi, chiusa in sé stessa come in una lastra di ghiaccio, tende all’annullamento di sé perché lacerata nel profondo da un’attrazione velenosa. L’inverno narrato da Monica Pareschi è una condizione dell’anima: proprio per questo motivo la maggior parte dei racconti di Inverness presenta un’ambientazione estiva.
Plana dall’alto come un sole che scioglie ogni cosa, un’estate feroce, spietata, che paralizza e invade. È l’estate che segna la fine dell’innocenza, proprio come nel racconto pavesiano: la vicenda di Ginia e della sua «bella estate» fu descritta a suo tempo da Cesare Pavese come «la storia di una verginità che si difende». Anche nel libro di Pavese l’estate del titolo era metaforica, di fatto sfumata nei contorni di una Torino grigia e crepuscolare; in questo caso avviene l’operazione inversa, ovvero all’inverno richiamato simbolicamente nel titolo si oppone il bagliore di un’estate agghiacciante. Tutte le scene madri di Inverness avvengono d’estate: è il tempo della rivelazione, in cui qualcosa inevitabilmente si spezza e così restano nelle mani del lettore i cocci frantumati di quello schianto dell’anima. Le protagoniste di questi racconti sono spesso giovani donne o bambine, ma l’infanzia non è mai innocente come scopriamo subito in Primo amore, il racconto che ci dà l’esatta misura dell’elemento perturbante insito in queste storie. L’animale simbolo della paura, il coniglio, appare in questa storia come un presagio del male: la bambina protagonista osserva conigli malati o violenti, mamma coniglia che mangia i suoi piccoli, chiusi dietro le barre di ferro delle gabbie. La sua infanzia è insidiata da questa visione, così come lo è dalla vita domestica, tranquilla solamente in superficie, in realtà piena di baratri, di trappole sentimentali.
«In campagna si nasce, si marcisce e si crepa, così ha detto una volta sua madre».
È innegabile l’influenza di Shirley Jackson, celebre autrice tradotta da Monica Pareschi per Adelphi, definita la «regina del perturbante» o addirittura «la Strega». C’è ben poco di orrorifico nella narrativa di Jackson, l’elemento inquietante o pauroso delle sue storie deriva non dal soprannaturale ma dal quotidiano, dal conflitto tra i suoi personaggi e il mondo. La scrittura di Shirley Jackson riesce a spingersi dove le ombre si allargano e tutto ciò che è all’apparenza normale rivela infine il suo rovescio. Così questi racconti di Monica Pareschi che ci rivelano l’altro lato, nascosto, dietro la normalità più banale, apparentemente immune dalle lusinghe del male. Perché non esiste nulla di più abissale e impenetrabile della mente di un essere umano. Lo dimostra bene il racconto I gabbiani che parte da un episodio all’apparenza banale (una donna è infastidita da un pennuto che invade il balcone di casa), per poi analizzare un trauma annidato nell’inconscio, un episodio di molestie in apparenza di poco conto che, in realtà, lascia una ferita profonda – e duratura – nella psiche. Solo nel finale, con un brusco colpo di scena, ci rendiamo conto della vera identità dell’uccello.

La narrazione di Inverness è intessuta del gioco dei contrari e delle opposizioni, sin dall’incipit: I baci di Munch, anziché il celeberrimo Urlo, ma il bacio diventa l’urlo. Chi ricorda il bacio di Munch? È un dipinto olio su tela del 1897, conservato presso il Munchmuseet di Oslo. Oscuro, tetro, malinconico, sui toni del blu, ci mostra due amanti nell’ombra accanto a una finestra chiusa. I due si baciano e appaiono talmente avvinghiati da rendere impossibile distinguere dove cominci uno e inizi l’altro. La protagonista del racconto di Pareschi ha sviluppato una fobia per i baci, che interpreta come un atto di cannibalismo: «I baci mi hanno sempre fatto paura». In un giorno d’estate si trova di fronte al dipinto e cerca di analizzare l’origine della sua nevrosi. I due amanti di Munch sembrano perdersi l’uno nell’altro sino a smarrire le reciproche identità: sono come congelati nel loro bacio. Il quadro fa parte del ciclo di dipinti di Edvard Munch dal titolo The Frieze of Life (1902-1916), in cui il pittore cerca di raffigurare le varie fasi della vita e delle relazioni nel tentativo di mostrare «la battaglia che si chiama amore». Ne Il bacio con la finestra i corpi non hanno contorni, sembrano annullarsi nell’abbraccio, eppure la visione nell’insieme ci ispira un forte senso di solitudine: gli amanti ci appaiono nudi, indifesi, rivelati nelle fragilità distinte delle loro anime. Questa rappresentazione non è poi molto diversa dall’immagine feroce – che davvero richiama un atto di cannibalismo – del quadro Amore e dolore (1892) in cui vediamo una donna dai lunghi capelli rossi che bacia un uomo sul collo: il dipinto fu poi rinominato Vampire dallo scrittore Stanisław Przybyszewski, amico di Munch. Un abbraccio amoroso si trasfigura in una scena raccapricciante che rimanda a una tortura: l’uomo appare succube, piegato, sottomesso. Proprio la sensazione ultima (e raggelante) che comunicano questi racconti di Monica Pareschi, i quali appaiono in stretta relazione con la pittura di Edvard Munch, con le sue pennellate drammatiche, vibranti, cariche di tensione emotiva, tese a svelare l’anima dei soggetti rappresentati.
La forza feroce dell’amore è forse tutto quanto Inverness tende a indagare mostrandoci le lacerazioni invisibili lasciate dal contatto tra i corpi, l’attrito scaturito dal rapporto con l’altro, il «non detto» che si dilata sino a divenire baratro. L’amore è colto nella sua impossibilità, nella sua irrealizzazione, anche nella sua ferocia, come un campo di battaglia che rivela infine ciascuno a sé stesso, nudo e sfuggente nella sua solitudine.
Foto di Aaron Burden su Unsplash
