In un saggio del 1968, dal titolo Rivolta e rassegnazione, Jean Améry sottolinea quanto lo sguardo degli altri influisca negativamente sul soggetto che invecchia, trasformandolo in un “individuo senza potenzialità”: di fronte al processo di “nientificazione” messo in atto dalla nostra società, colui che invecchia viene percepito come corpo ingombrante e indesiderato, da tenere lontano dagli occhi e dunque dal cuore. Invecchiare, in fondo, è non essere più guardati.
Per fortuna la letteratura offre uno spazio privilegiato di riflessione e di resistenza, come dimostra il recente panorama editoriale dove il tema dell’accudimento e della perdita dei propri cari è ricorrente. Tra le pubblicazioni del 2024 meritano particolare attenzione il saggio-memoir di Didier Eribon, vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo (L’orma, traduzione di Annalisa Romani), i romanzi La casa delle orfane bianche di Fiammetta Palpati (Laurana) e L’abbandono di Valentina Durante (La nave di Teseo), libri in cui la vecchiaia, la malattia e in alcuni casi la morte dei genitori è raccontata dal punto di vista dei figli, e dove la contingenza della vecchiaia induce uno scambio di ruoli, e di sguardi, che rovescia la condizione di figlio: non più soggetto accudito bensì colui che accudisce. In che modo la vecchiaia e la malattia dei nostri genitori ci costringe a rivedere il nostro statuto di figli? Con la morte dei propri genitori si smette di essere figli? O al contrario non si finisce mai di esserlo? E ancora, quanto possiamo sperare di lasciarcela alle spalle la vita di nostra madre? Si è chiesta Sheila Heti in Maternità (Sellerio, traduzione di Martina Testa). E quella di nostro padre?
Paradossalmente l’accudimento dei nostri genitori, pur costringendoci a un cambio di statuto, sembrerebbe condannarci a essere eternamente figli perché il ritorno nella casa dell’infanzia, reale o simbolico che sia, la prossimità con il corpo dei padri e delle madri presentificano legami, interrogativi, traumi.
Se non si può impedire al proprio padre di morire, e forse nemmeno di soffrire, come l’amico e medico di famiglia ricorda a Philip Roth in Patrimonio (Einaudi, traduzione di Vincenzo Mantovani), allo stesso modo, non si può impedire al figlio di sentirsi impotente di fronte all’inesorabile invecchiamento o morte di un genitore, e ovviamente di soffrirne. Forse la scrittura potrà riparare? Come Roth, e molti altri (penso a Paul Auster dell’Invenzione della solitudine, a Annie Ernaux di Una donna, a Roland Barthes di Dove lei non è), anche per lo scrittore, sociologo e filosofo francese Didier Eribon la scrittura di vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo è insorta nel momento del lutto materno, così com’era nato dal lutto paterno il precedente libro, Ritorno a Reims (Bompiani, traduzione di Annalisa Milani).
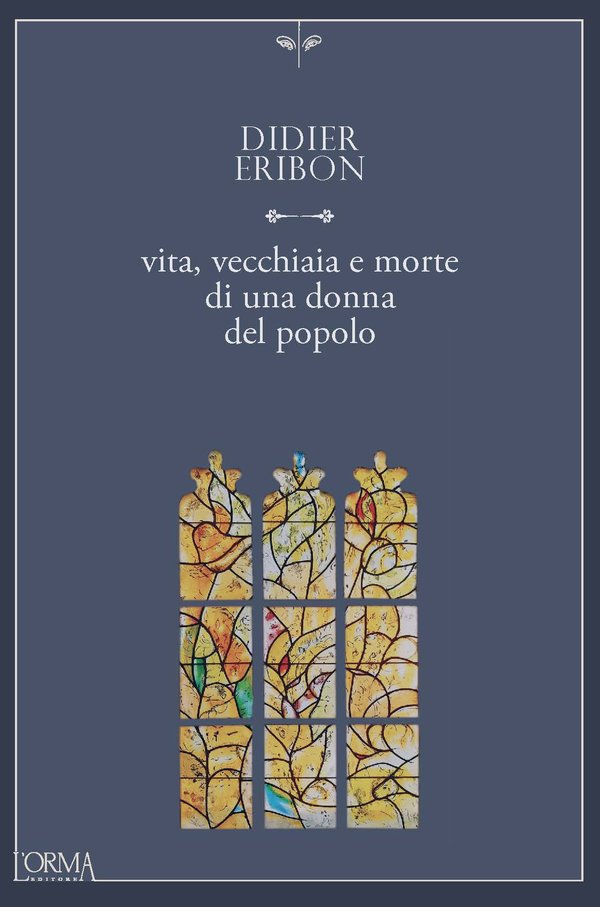
Dopo aver convinto la madre a entrare in una casa di riposo, Didier si congeda da lei il secondo giorno dal suo ricovero, promettendole di ritornare presto a visitarla – pur sapendo benissimo che quel “presto” è una misera bugia – e le rivolge una frase – «Vedrai che starai bene» – di cui si sarebbe poi vergognato, ricordandosi che è la stessa che dà il titolo a una canzone francese in cui a una signora che sta per entrare in una casa di riposo vengono rivolte esattamente le stesse parole: rassicurazioni più per lenire il senso di colpa dei figli che per tranquillizzarla. “Vedrai che starai bene” è una frase banale e allo stesso tempo crudele per la menzogna che contiene: sebbene Didier incoraggi la madre a seguire il maggior numero di corsi e di attività, prova orrore di fronte alla lista di attività a cui la madre deve partecipare per evitare, come dicono le infermiere, che si “lasci andare”; per non parlare dell’impossibilità di farsi una doccia tutti giorni per mancanza di personale, di potere prendere un vestito o un oggetto dal proprio armadio perché chiuso a chiave, di alzarsi autonomamente a causa delle sbarre attorno al letto.
Come si può stare bene quando si è obbligati a lasciare la propria casa, luogo non solo fisico ma anche simbolico della propria esistenza, per entrare in un posto dove è pressoché impossibile sottrarsi alla “sociabilità imposta” e dove prima o poi, andremo a morire? Entrare in una casa di riposo, scrive Eribon, è uno sradicamento dal passato e dal presente, è quello che lui definisce un “locus certus”, in quanto ciò che caratterizza la casa di riposo rispetto alle altre istituzioni totali (prigione, ospedale psichiatrico, caserma…) è che la reclusione ci accompagnerà fino alla morte.
Dopo solo sette settimane nella casa di riposo la madre di Eribon muore, o meglio si lascia morire senza aver rivisto il proprio figlio. La morte della madre recide la genealogia familiare, allontanando per sempre il figlio dalle proprie origini, quelle origini che lui stesso aveva tradito compiendo un salto di classe: da qui la necessità di scrivere della vita della madre, immergersi nella sua lingua sconosciuta, come quando Didier perlustra il dizionario del dialetto della Champagne. Un modo per addolcire il proprio percorso di transfuga di classe, di cui parla lungamente in Ritorno a Reims e che nella letteratura francese, da Annie Ernaux a Édouard Louis, è un tema molto sentito.
«Ero un figlio, e non lo sono più»: oltre all’indignazione e alla denuncia, che fanno di vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo un vero e proprio libro politico, nel testo di Eribon c’è anche lo spazio per un’accorata disamina dei sentimenti contrastanti che si provano di fronte al lutto, primo fra tutti il rimpianto.
Ma siamo sicuri che la morte dei genitori ci tolga da questa posizione di figlio? Si è sempre figli, anche laddove non si conosce l’identità dei padri e delle madri o si è scelto di negarla.

Dalla necessità di mettere le proprie madri in una casa di riposo prende le mosse anche l’originale romanzo d’esordio di Fiammetta Palpati, La casa delle orfane bianche. Natàlia, Lucia e Germana, tre figlie di una certa età, tre “bambine attempate”, hanno la strampalata idea di rinchiudersi sotto lo stesso tetto insieme alle loro rispettive madri, Pina, Felicita e Adele, tre “vecchie bambine”. Ma la casa, una tipica abitazione rustica con il giardino, da nido si trasforma quasi subito in covo, e la dolcezza ed entusiasmo iniziali delle figlie vengono immediatamente sostituite dalla durezza dei continui rimproveri: «Adesso è questa la tua casa, mamma», dice Lucia a Pina, «ti ho sistemato le fotografie sul comodino. I vestiti nell’armadio. È la quindicesima volta che me lo chiedi. Io dormirò nella camera sopra la tua. Non volevi che vivessimo sotto lo stesso tetto?». Sin dall’inizio Pina rifiuta la convivenza, chiedendo addirittura alla figlia di essere mandata in una casa di riposo: «Rimettimi al Bonvecchi», le dice con una espressione dialettale, che il narratore, definito sin dal principio “imperfetto”, ci spiega così: «Sicché, come si rimettono negli stiletti – e non appena cala la luce, o grandina forte, o il vento infuria – galline, conigli, tacchini, analogamente si rimettono uomini e donne negli ospizi che qui, per gioco linguistico prendono nome di Bonvecchi». Del resto è lo stesso narratore a sottolineare il pericolo dell’impresa, in quanto, «checché se ne possa pensare, animali e anziani aborrono gli spostamenti».
Il romanzo di Palpati ha un esplicito impianto teatrale, a partire dalla presentazione iniziale dei personaggi alla divisione in due atti, intervallata da un breve scambio di battute, un “chiacchiericcio” tra gli spettatori che si incontrano nel foyer, in cui l’ironia e il sarcasmo, cifra stilistica di Palpati, sono portate all’estremo:
«Ecco che vuol dire, sacrificarsi per i figli».
«Che matte».
«Che bastarde».
«Hai visto?».
«Sarà diventata omosessuale per il trauma infantile».
«Ma come si fa a trattare così delle povere vecchie».
«Io credo che il futuro sarà questo co-housing».
«In nord Europa già lo fanno».
«Altro che famiglia e famiglia».
«Comunque ci sono certi ospizi dove i vecchi stanno benissimo».
«E poi dici: fa’ figli, che saranno il bastone della tua vecchiaia».
«Ma quelle sono pazze, oltre che vecchie».
D’altra parte sono in primis le figlie a scambiarsi battutine velenose sullo stato delle proprie madri: per esempio Pina viene definita un «Lerch travestito da nonna»; lo stesso del narratore, con il suo sguardo impietoso, non risparmia nessuno, indugiando sulla descrizione del corpo delle madri, che possiamo considerare il protagonista assoluto del libro: così Felicita rimane «con le braccia penzoloni, le ginocchia che molleggiano e la dentiera come fieno tra i denti di un ruminante» e «la testa di Adele che cade riversa all’indietro come una di quelle bambole contese, che finiscono disarticolate». Viene in mente l’incipit indimenticabile del Fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini (Mondadori).
La casa delle orfane bianche è un romanzo corale in cui le voci si intrecciano fino a confondersi: una confusione ricercata che anticipa la decisione, presa dalle figlie a un certo punto della narrazione, di scambiarsi le madri, sperando forse di mettere da parte gli antichi rancori, di essere con le madri delle altre più comprensive, generose e gentili. Ovviamente non sarà così. Il bisogno di essere amate è ciò che accomuna le figlie e le rispettive madri, ma l’amore, si sa, fa presto a prendere derive inaspettate. A peggiorare il quadro è l’incapacità di ciascuna coppia di interpretare il proprio ruolo, tant’è che quando Lucia chiede a Germana cosa vorrebbe dalla madre, la risposta è «essere sua figlia, per una volta» e quando Germana a sua volta rivolge la stessa domanda a Lucia, la risposta è «vorrei che fosse madre, per una volta». Il problema, come ha osservato Alessandro Zaccuri nella bella postfazione, è che le figlie sono orfane, nonostante la morte delle madri non sia ancora avvenuta, «orfane da una vita, solo che se ne accorgono solo ora, mentre accudiscono queste vecchie tornate bambine».
A turbare ancora di più la convivenza, e nel contempo a salvaguardarla, è l’arrivo si Suor Modestina, che con il suo corpo ingombrante e piagato, per nulla modesto, diventa l’ospite inaspettata che innesta una confessione dopo l’altra. Suor Modestina è un personaggio emblematico, e sebbene rimanga fino alla fine il dubbio che si tratti di un’impostora, di fatto resta la Madre di tutti, che con il suo aspetto e comportamento bizzarri riesce a instaurare un rapporto di vicinanza e sorellanza, che al netto di tutto mi sembra una delle vie più interessanti per affrontare la relazione tra madri e figlie e prospettare, nonostante tutto e tutte, una meravigliosa solidarietà femminile.
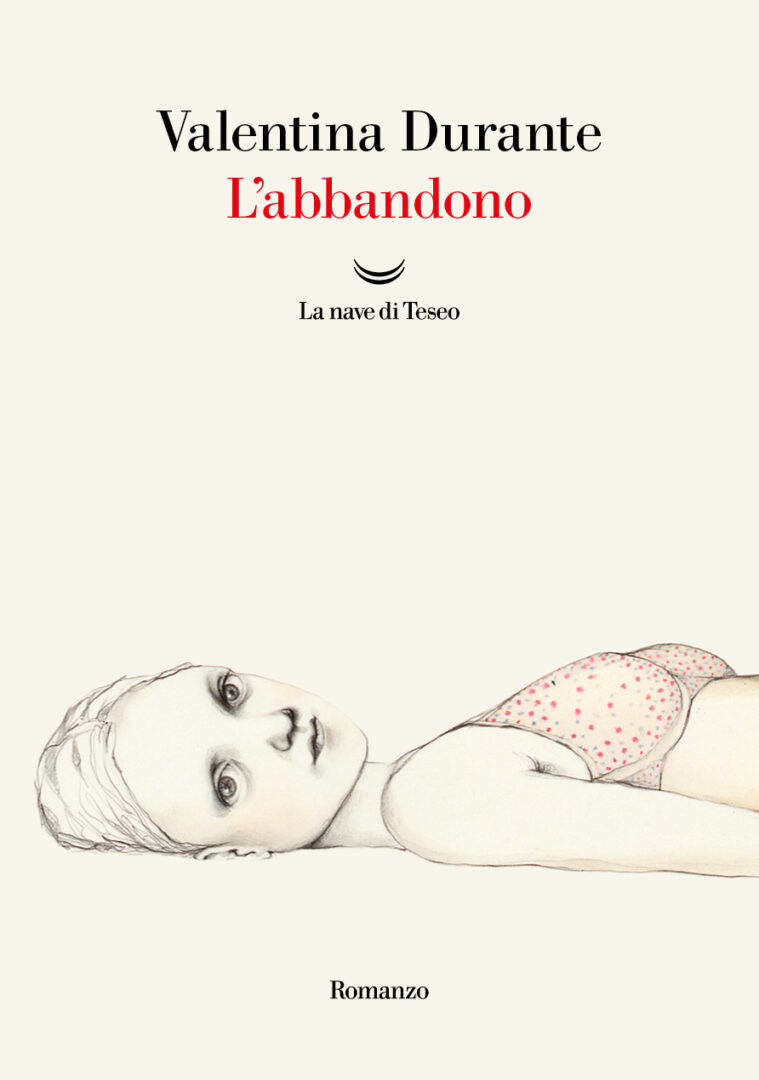
Cupo, feroce e sicuramente meno speranzoso è l’Abbandonodi Valentina Durante, in cui già il titolo lascia prefigurare lo stato di prostrazione e solitudine in cui vivono personaggi, tutti vittime di un abbandono e a loro volta carnefici: «Papà, lo sai quanto sarebbe semplice ucciderti?» – pensa tra sé la figlia Anna – «basterebbe raddoppiare la dose di Medrol e dimezzare quella di Galvus. Tutti penserebbero a un errore: una persona anziana, con tutte quelle malattie, tutte quelle magagne da gestire, nonostante gli anni, a causa degli anni …».
A seguito dalla separazione dal marito, a trentotto anni Anna è ritornata a vivere nella casa dell’infanzia insieme al padre, un tempo insegnante spietato di Lettere, ora pensionato ipocondriaco. La scelta di Anna, voce narrante della storia, non è dunque dettata dalla volontà di accudire il genitore, bensì dalla necessità di coniugare la propria situazione economica e sentimentale precaria all’entrata in una casa di riposo della zia, la sorella della madre, che fino ad allora si era presa cura del padre così come si era occupata di tutta la famiglia quando la madre di Anna era venuta precocemente a mancare lasciando il padre solo con due figli, Anna e il fratello Stefano.
Ciò che colpisce, sin dall’inizio del romanzo, è l’ingombro del corpo paterno che Durante descrive con una prosa chirurgica. Del corpo del padre non solo non ci si può sbarazzare ma è anche impossibile recidere i legami che come le ventose di un polipo risucchiano la figlia:
«Me lo immagino tutto, mio padre, come un polpo, con queste ventose che si attaccano dove lui vuole, dove lui desidera afferrarsi e non lasciano più andare, questi tentacoli di polpo che è nato, ha riempito pelle e vene, stomaco e intestini, adesso la pelle è vizza, le vene portano sangue non più buono, lo stomaco e gli intestini si riempiono e si vuotano anche con sofferenza e fanno cattivo odore, e questo si sente, io lo sento: è l’odore della vecchiaia. O l’odore di mio padre e basta, bambino nato già vecchio, con la fine incistata nel principio.
Salvo che il polpo di cuori ne ha tre, mentre io, nel petto di mio padre, a malapena riesco a figurarmene uno, un muscolo cardiaco minuscolo che pulsa a fianco come un palloncino sgonfio.»
L’indugiare sulle parti del corpo e su tutto ciò che è corporeo può considerarsi un topos nella letteratura che affronta la vecchiaia e la malattia di un nostro caro che invecchiando si avvicina alla morte: dalla “merda” in Patrimonio di Roth alla piaga putrescente di Suor Modestina nella Casa delle orfane bianche. Nell’Abbandono, il corpo è molto presente: non solo quello scomodo e talvolta maleodorante del padre, ma anche quello rappresentato per sineddoche dalla mani della protagonista, nascoste dentro un paio di guanti e quello anonimo dei cadaveri non riconosciuti che il padre esplora in misteriosi dossier che intervallano la narrazione. Allo sguardo del chirurgo si aggiunge quello del medico legale, tanto che il romanzo di Durante può essere letto come una sorta di autopsia del passato e del presente. Se infatti la convivenza da adulta con un padre vecchio e malandato è già di per sé problematica ed estenuante, nel caso di Anna diviene un vaso di Pandora pronto a rovesciare un passato doloroso. La narrazione di una convivenza difficile con il proprio padre si trasforma nella convivenza impossibile con il passato che riconquista prepotentemente la scena con flashback di grande intensità, talora indimenticabili. E il passato per Anna non significa solo padre e zia insieme al ricordo sbiadito della madre ma anche e soprattutto fratello, con cui Anna condivide un legame morboso e indissolubile nonché un indicibile segreto.
L’importanza del legame tra fratelli, anticipato dall’esergo tratto da Caino di Gualtieri parrebbe mettere in secondo piano quello con il padre, che Anna è riuscita a uccidere, perlomeno metaforicamente. E tuttavia la dura figura paterna continua ad avere, insieme all’assenza materna, una profonda influenza sui fratelli, così come lo statuto di sorella, tanto più perché portato allo stremo, continua a mantenere Anna nel limbo delle figlie. Forse perché, come ha osservato Eribon, una volta che ha smesso di essere figlio, ha avuto la strana impressione di essere tornato «in modo vago e lontano un fratello» e «con questa mediazione» di essere rimasto «un figlio malgrado tutto, giacché essere fratello implica essere ancora figlio».
Insomma non si smette mai di essere figli e figlie.
