Ogni tanto mi sveglio con una strana urgenza (o nostalgia) addosso. Mi manca qualcuno con cui parlare di letteratura. No, non di libri. È diverso: di letteratura. La differenza è sottile, ma decisiva. Forse mi inganno, e credo di avere idealizzato quelle conversazioni lunghe e sovreccitate che facevo uscendo dalla facoltà di Lettere quindici anni fa. Perfino per email: email lunghissime come quelle che si scambiano le due protagoniste del romanzo più recente di Sally Rooney, Dove sei mondo bello. Che a me è piaciuto: proprio per quelle lunghissime email sulla letteratura contemporanea, sul marxismo, sul romanticismo… E d’altra parte non mi ha stupito che, al contrario, alcuni fan di Rooney della prima ora abbiano avuto da ridire proprio sulle email: troppo lunghe! Chi si scambia più email così lunghe e articolate nell’epoca in corso? Quasi nessuno. Ci vuole tempo, ci vuole dedizione. Ci vuole anche un argomento appassionante: come la letteratura, appunto, quando non è solo un semplice “parlare di libri”.
Nella minuscola porzione o bolla di mondo di cui faccio parte per mestiere, di libri si parla continuamente. Spesso perdendo di vista l’indifferenza (che a tratti mi pare perfino sana) del resto degli umani agli oggetti su cui continuiamo a scambiarci veloci, approssimativi, esteriori, stucchevoli o irritati, ghignanti pareri tra addetti ai lavori e ai livori. Com’è il nuovo libro di? Hai visto, è in classifica? Ma secondo te va allo Strega? No, forse va al Campiello. Forse da nessuna parte.
I libri di cui parliamo, in larga parte, non li acquistiamo: arrivano. Pacchi di carta imbottita e gialla, scatole che si accatastano nelle portinerie. Gli uffici stampa mandano, mandano quasi tutto a chi scrive sui vecchi giornali, sui vecchi siti web, o ha una pagina Instagram, un profilo TikTok da almeno un migliaio di follower. Il corriere suona, scarica il pacco. Lo apri, getti un’occhiata veloce. C’è la dedica? Non c’è la dedica. Mi interessa? Non mi interessa. È il libro di un amico, di un’amica? Devo scriverne? Devo presentarlo?
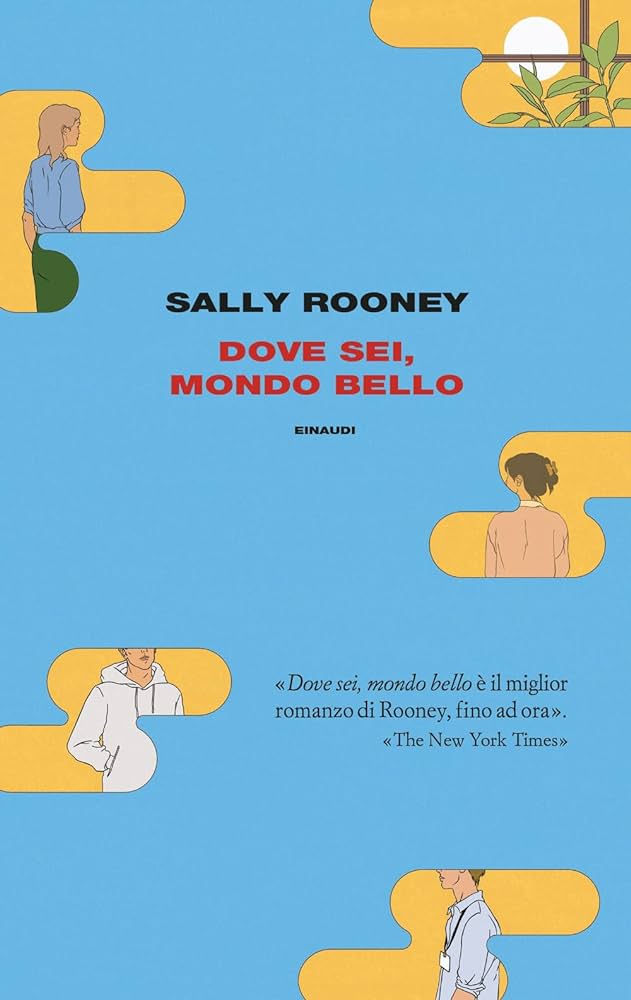
La scrivania dei caporedattori dei vecchi giornali è letteralmente invasa. Un assedio. Torri minacciose, cataste. Non frequento granché le redazioni, ma quando ci metto piede resto attonito: libri impilati ovunque, perfino lungo i corridoi. Il colpo d’occhio non comunica vitalità. Ha qualcosa di mortifero. Mi chiedo solo: che fine faranno? Dove vanno a vivere una seconda vita – se l’avranno – i libri che i caporedattori non hanno nemmeno il tempo di sfogliare?
E poi penso: non li amano, non possono più amarli. Non li amano come li amavano da giovanissimi; hanno una confidenza pluridecennale con quegli oggetti cartacei, sanno annusarli, qualcosa intuiscono già rigirandosi la copia fra le mani, ma non amano i libri. O non allo stesso modo di un tempo, non più. Sono troppi. Così, di tutta la narrativa italiana contemporanea passata sulle scrivanie in questi anni niente si è davvero fermato nella memoria. Niente, quasi niente ha fatto la differenza.
Gli uffici stampa mandano le mail circolari con le novità – sapendo da subito, da sempre, ciò su cui davvero “si punta”; sanno che una porzione di quella newsletter o di quella email inviata con malinconico e arreso automatismo è fatta di titoli che avranno poche chance di esistere agli occhi dei professionisti. Zero. Solo il lettore casuale potrà – misteriosamente e imprevedibilmente – dare udienza, offrire un’occasione di riscatto.
La verità è che nemmeno direttori editoriali e uffici stampa hanno il tempo di leggere tutti i libri che devono pubblicare e promuovere: è un dato di fatto. Non un’accusa, tanto meno una colpa. E il più delle volte – anche se è un fatto inconfessabile – non amano i libri che devono promuovere: e non perché non siano amabili, ma perché è difficile amare qualcosa per ufficio, per dovere. È difficile amare nella routine. Li ho visti accendersi per libri di altre case editrici che non fossero la loro: ed era un modo (perfino commovente) di ricordarsi di avere, in stagioni remote, amato i libri profondamente.
E gli scrittori? Molti scrittori leggono poco. Non hanno tempo di leggere, devono scrivere. Devono parlare dei loro libri in pubblico. Ogni tanto, con dita pigre, si trovano a compulsare – per intuirne al volo la sostanza, o il segreto – il volume di qualcuno che ha più fortuna di loro. Poi lo lasciano cadere. C’era un tempo di passione arroventata, di volumi pieni di orecchie, di segni a matita. Ora l’entusiasmo è di maniera, ed è difficile che sia autentico se va travasato in 5000 battute spazi inclusi a proposito di una qualche bozza scorsa in pdf.
Non è facile amare il troppo, l’esubero, la ripetizione. La passione calda si raffredda, o finisce per conservare una tepidezza costante – l’anticamera dell’assuefazione.
Nelle redazioni dei programmi televisivi o radiofonici passano ogni giorno decine di libri, finiscono nelle mani dei conduttori per il tempo della registrazione o della diretta, poi vengono abbandonati. Nelle officine degli editor, le prime bozze si riempiono di post it, poi diventano seconde bozze, si va in stampa: è passata un’altra stagione, e il tempo per leggere altro si è sfarinato, non c’è più.
Non è carino dirlo, anzi è fastidioso, ma è così. È grave? No, è inevitabile.
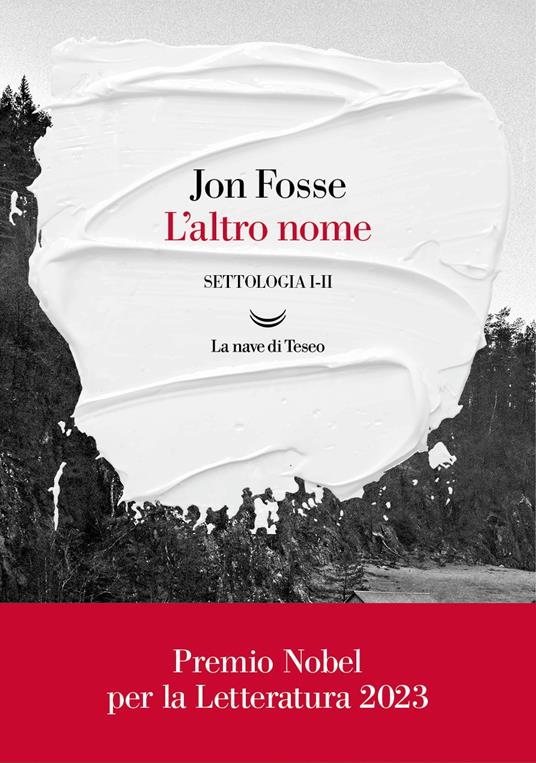
Però mi fa venire una insopportabile nostalgia di gente con cui parlare di letteratura; e so di non poterla trovare dove i libri circolano in tale sovrabbondanza, nel regno della produzione-comunicazione editoriale. Che constatazione ingenua, Di Paolo! Sembri quel Lucien delle Illusioni perdute di Balzac. Ma guarda che sei ridicolo alla tua età: non fare il ragazzetto lagnoso in cerca di attenzione, di affetto, di carezze. Hai avuto abbastanza, forse anche troppo. Sì, per carità, ho avuto abbastanza. Però ho voglia di parlare di letteratura! Sai che ti dico? Faccio un bel post su Facebook. E che senso ha? Non lo so, magari trovo qualcuno che ha il mio stesso desiderio. Non è facilissimo. Il giorno in cui ho postato un brano dell’autore norvegese Jon Fosse, fresco di Nobel, molti commenti erano del tipo: non mi attrae, non mi piace, mi lascia perplesso. Legittimo, per carità, tanto più che Fosse usa la punteggiatura in modo eccentrico, anzi spesso ne fa a meno; riduce all’osso la trama, che diventa un pretesto per scommettere tutto sulla lingua. È – si direbbe con un aggettivo da cui gli uffici marketing degli editori sono terrorizzati – “letterario”.
Lavora sulla prosa come si lavora sulla poesia. Il problema – se posso chiamarlo così – è che uscendo dalla scuola abbiamo pochi contatti con questo tipo di scelte estetiche e il rischio di giudicare difficile ciò che è solo differente è altissimo. Il rischio, soprattutto, di rigettare alla prima occhiata una occasione di scoperta – con la rozza dinamica mi piace/non mi piace che è pericolosa se applicata alla letteratura, come ha fatto osservare Rosella Postorino.
Il punto non è se ci piace o non ci piace uno come Fosse, se ci piace o non ci piace uno come Saramago. Ma che cosa provano a offrire con il lavoro sulla lingua, sulle articolazioni della sintassi. Non ci interessa? Vogliamo che tutto sia piano, trasparente, senza scogli? Va bene. Ma questo alla lunga condiziona gli autori (gli editori sono già condizionati abbastanza), li scoraggia a provare, a sperimentare – e non per il gusto di complicare le cose, che è sciocco, ma di non accomodarsi senza dubbi sulla strada più battuta.
Un buon lettore ha tutto il diritto di scegliere ma anche il dovere minimo di provare. Come in gelateria: d’accordo i soliti amati gusti, ma ogni tanto qualcosa di diverso. Per non anestetizzare il palato. Nel contesto social in cui si parla di libri (vale anche per il cinema), assai circoscritto, è comunque penoso cogliere l’atteggiamento del “non l’ho letto e non mi piace”. È triste, anzi. Indice di una pigrizia mentale e di un’aria di sufficienza che mi sgomenta. Bisogna osare anche come lettori, non fidarsi solo del già visto e del già letto. Farsi sfidare. Per poi magari confermarsi in un pregiudizio, ma senza diventarne ostaggi.
Perché sennò scrittori come Saramago e Fosse non avranno più cittadinanza. E leggeremo solo recensioni – mi è capitato, e mi riguardava – in cui candidamente il recensore scrive che il “filo narrativo si perde lasciando il romanzo senza romanzo”. Può darsi che sia vero e che il libro sia brutto; il problema però è che non si è accorto che un romanzo non lineare non è un caso, un incidente, un errore, ma una precisa intenzione. Con una storia anche piuttosto lunga.
Vedete? Bisognerebbe inventare una versione di Tinder per gente che non ha voglia di parlare di libri ma ha voglia di parlare di letteratura. Qual è la differenza? Mi rendo conto che non è facile spiegarla: c’entra, intanto, l’accalorarsi. È il contrario del “commentino”. Quello comincia con una specie di interiezione, di ghignetto complice, infastidito, distante. Ehm. Eh. Uh. Ah. Oh. Il più delle volte il tessuto acustico di una conversazione sui libri di gente che lavora coi libri è questo. Ehm. Eh. Uh. Ah. Oh. Qualche volta anche boh, mah. E poi: ma va allo Strega?
L’accalorarsi non si traduce in monosillabi: è lo slancio con cui si interroga un’opera senza ficcarla nelle categorie del giudizio, l’emozione con cui si esplora un paragrafo, un verso, solo con l’ansia di comprendere, di arrivare al cuore di qualcosa. Si polverizzano le preferenze dettate da parentele e simpatie, snobismi e anti-snobismi per partito preso: c’è, insomma, un’adesione, qualche volta un abbandono. Che non saprei descrivere meglio di così, se non ricorrendo a un libro.
L’ho letto con una commozione strana, che cresceva pagina dopo pagina. Ho fissato nella mente lo spicchio del sedile sul treno in cui l’ho letto, e anche la luce di un pomeriggio che diventa sera. Forse ero commosso proprio dal riconoscimento di… Cosa? Una materia vischiosa, impura, un umore, un modo di stare al mondo, un modo di sentire, di maturare un’ossessione. Un’ambizione estetica. Ecco: abbiamo ancora ambizioni estetiche, scrivendo? Se lo chiede più qualcuno? (Un personaggio del romanzo di Sally Rooney, presumo, se lo chiederebbe). Che cos’è una ambizione estetica?
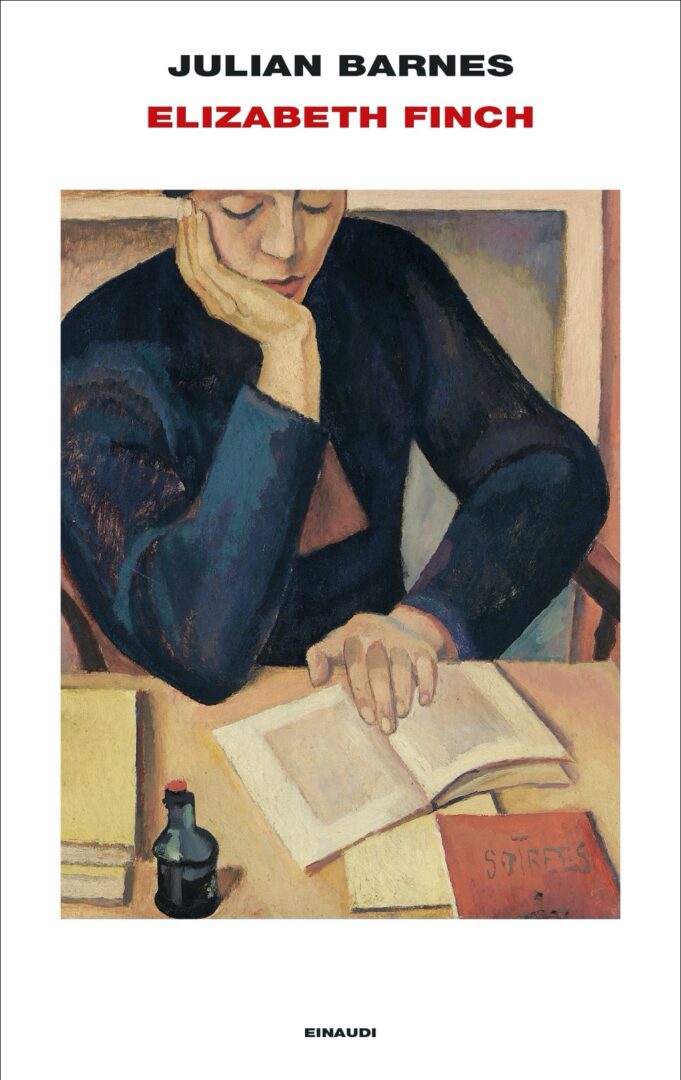
Fatto è che questo libro – Elizabeth Finch di Julian Barnes (Einaudi, nella traduzione di Susanna Basso) – mi ha fatto avvertire l’elettrica urgenza di interpellare, come a vent’anni, gente disponibile a “parlare di letteratura”. Mica facile trovarla. Spesso c’è fra i librai, qualche volta tra i professori, qualche volta tra gli studenti, anche quelli che lo restano a vita; o fra gli iscritti a qualche benemerito circolo di lettura. Nessuna voglia di sentire ehm, eh, uh, ah, oh: una impellenza di condividere all’istante, anzi istante per istante, le sensazioni che la prosa di Barnes stava producendo in me. Senti che frase, leggi! Una sola singola frase così esatta, così stupefacente proprio per la sua esattezza. Ci si può quasi eccitare per una frase? Una eccitazione mentale, un tremore calmo, la meraviglia di vedere lessico e sintassi incarnare il lavorio dell’intelligenza, portarlo a frutto. Cavare piacere dalle parole. C’è gente, nel mondo dei libri, che se ne ricorda? Forse sì. Forse sempre meno. E comunque: sempre più a fatica.
Barnes sta descrivendo, attraverso la voce di un io narrante maschile che un po’ gli somiglia, una donna sfuggente e magnetica, una docente di storia le cui lezioni l’hanno incantato. Lei muore; lui cerca di capire chi fosse. Chi fosse veramente Elizabeth Finch. Leggo:
«Non si scordava mai dei compleanni. O dei Natali. Se li mandavo su in città [i nipoti di Elizabeth] andava sempre ad aspettarli al treno. Sapevano di potersi fidare completamente. Li portava ai musei o alle mostre, ma era in grado di rendere la cosa divertente per loro. Non tipo “Guardate, questo è il capolavoro di un grande maestro”, no, li metteva davanti al dipinto e dopo un po’ magari diceva: “Lo vedete lo scoiattolo là dietro?”»
Lo vedete lo scoiattolo là dietro? Basta una domanda così, posta così, per fare esistere un carattere, una visione delle cose, un modo di essere. Lo vedete lo scoiattolo là dietro? Parlare di letteratura significa passare mezzora sullo scoiattolo là dietro: vederlo, stanarlo, intanto. E poi contemplarlo. E perderlo di vista, e stanarlo, e contemplarlo di nuovo. Leggo:
«Mi ha detto una cosa stramba quando era in ospedale. Strana intendo, non buffa. Era tremendo vederla così, ridotta pelle e ossa. Non che sia mai stata in carne, nemmeno nei momenti migliori. Anche se devo riconoscere che riusciva a far sembrare elegante perfino un camice da ospedale. Io ero agitatissimo, come è facile immaginare. Ma sapevo che non avrebbe voluto vedermi crollare, o dirle tutto quello che non le avevo detto prima. Perciò mi uscì solo un “È un gran figlio di puttana, il cancro, Liz, un grande, un grandissimo figlio di puttana”. Girò la testa verso di me, e mi guardò con quei suoi occhi – si ricorda, che occhi grandi aveva – che adesso parevano ancora più enormi in quella specie di teschio rattrappito. Sorrise senza forza e sussurrò: “Il cancro, mio caro Cristopher, se ne frega dell’etica”. Che cosa intendeva secondo lei?»
Trascrivo e mi emoziono di nuovo. Per l’aspetto oggettivamente doloroso della questione, sì, certo, ma anche o soprattutto per come è reso. L’eleganza di lei in un camice da ospedale! La frase di lui (è il fratello di Elizabeth), una frase sincera ma sciocca. La risposta di lei. E un attimo prima: «Si ricorda, che occhi grandi aveva». Non basta: «Parevano ancora più enormi in quella specie di teschio rattrappito». In-quella-specie-di-teschio-rattrappito. Gli occhi enormi. «Il cancro se ne frega dell’etica». Una frase detta sorridendo. Sorridendo, però, «senza forza». E non basta: c’è infine la domanda del fratello che non capisce.
«Che cosa intendeva secondo lei?». Che cosa intendeva secondo voi?
Ecco la domanda della letteratura. Che cosa intende secondo me? E non c’è sequenza di ehm, eh, uh, ah, oh che tenga. C’è una frase che arriva come una sberla, a cui bisogna reagire. Ho mandato a due o tre persone via WhatsApp la pagina in questione. Non so cosa stessero facendo in quel momento, ma ero nello stato d’animo di un lunare corriere che suona a tutti i citofoni possibili: scenda, c’è una raccomandata per lei!
Che raccomandata? Ecco. Questa pagina.
Ha tempo di parlarne con me almeno una mezzora? Ha tempo di pensare all’eleganza di quel pigiama? A quegli occhi che sembrano enormi? Al teschio rattrappito che un giorno saremo? A un sorriso senza forza. Al fatto che il cancro se ne frega dell’etica?
Pensavo a un sacco di gente che conosco nel mondo dei libri. Un’ampia rubrica che ho scorso mentalmente. Pensavo a quanto sarebbe parso inopportuno alla gran parte di loro che mi mettessi, su due piedi, all’improvviso, a parlare di letteratura. Ma che vuoi adesso? Ne parliamo un’altra volta. Ci sono altre urgenze. Scadenze, figlio mio, scadenza! Lo so. Lo so benissimo. Libri da commissionare, da chiudere, da correggere, soprattutto da promuovere: con una stanchezza irredimibile, una stanchezza assurda – quella per cui, a ogni salone, fiera, festival, premio, dovremmo abbracciarci tutti e sfogarci un po’ e dirci a vicenda: non è niente, non è niente, sono solo libri.
Però penso che potremmo tornare – noi gente dei libri, dico – a essere più utili alla causa se rimettessimo a fuoco, almeno a giorni alterni, l’amore lontano che ci ha portati qui. Se tra libro e libro – libro condiviso, libro con il like, libro senza like, libro per cui mi aspetto il like, libro fotografato sul pavimento, sul tavolo con la frutta, al mare, al cesso, libro che ti faccio mandare, libro che potresti farmi mandare, libro che forse va al premio, libro che è bellissimo senza averlo letto, ehm, eh, uh, ah, oh – se insomma tra libro e libro, dessimo un po’ di fiato a un altro discorso, a un discorso per l’appunto amoroso, gratuito… Ecco, mi dico che saremmo più contagiosi se provassimo un po’ tutti a parlare di letteratura come Baricco con le maniche di camicia arrotolate parlava una volta di Céline, se dessimo al vasto mondo che non legge l’occasione per avere il dubbio di perdersi qualcosa non leggendo; se riflettessimo su quanto poco erotizzante è il piacere stanco, esausto, che si intuisce sulle facce di chi sta da troppi anni in mezzo ai libri…
In copertina:
Illusions Perdues, illustrazione di Adrien Moreau, 1897
