«‘Ha la solita scimmia che le si arrampica sulla schiena?’ domandò l’uomo con la pipa». Da questa domanda deriva il titolo della prima edizione italiana di Junky (La scimmia sulla schiena) di William S. Burroughs, il romanzo autobiografico, che ripercorre i 15 anni da tossicomane dello scrittore americano, riproposto da Adelphi in una nuova traduzione (di Andrew Tanzi) e con un’introduzione di Oliver Harris e un’appendice che include fra l’altro la prefazione di Allen Ginsberg all’edizione americana del 1977.
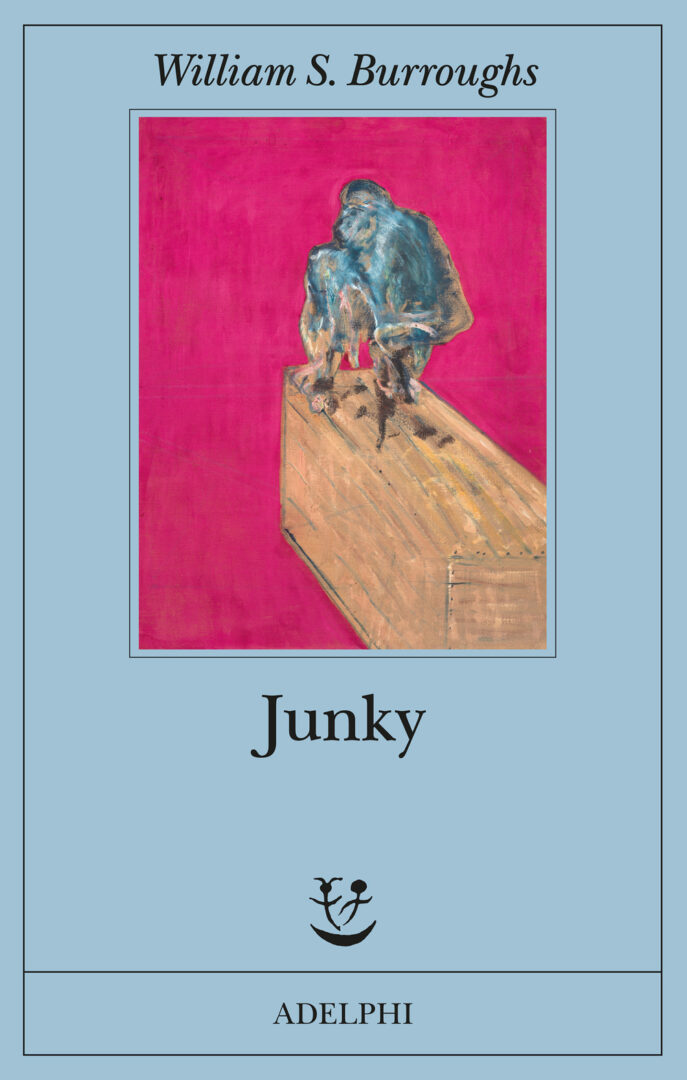
Da sempre legato alle culture sperimentali e alle avanguardie di tutto il mondo, alla cultura underground – quel grande mixer di gruppi e genti così diverse tra loro che si identificano nell’equivoco –, sperimentatore nella pittura come nelle lettere – celebre è la tecnica del cut-up, di cui è chiara espressione quell’indecifrabile capolavoro che è Naked Lunch (1959) – Burroughs ha raccontato apertamente la propria esistenza di tossicomane, e in uno stile per lui insolito, per paradosso cristallino e lineare, in Junky. Burroughs si è spesso ritrovato incasellato in quel calderone che prende il nome di Beat Generation, a fianco di autori che per il loro stile e le tematiche inconsuete dei loro scritti sono stati con molta faciloneria etichettati come “beats”. In realtà, se è vero che l’autore del Pasto nudo condivise per breve tempo le strade di autori come Allen Ginsberg, Gregory Corso o Jack Kerouac, è tuttavia da ritenersi un irregolare. A Ginsberg, d’altra parte, lo legava la devozione verso un altro irregolare, questa volta delle lettere francesi, come Jean Genet, del quale apprezzava in particolare quel “formidabile” romanzo che è Notre-Dame-des-Fleurs («odioso e prestigioso», annoterà Cocteau, ma vergato da «mano innocente, libera da ogni costrizione»), e notoriamente l’amore per i ragazzi; ugualmente subì l’influenza di scrittori come Conrad, Joyce, Céline, Cocteau e Beckett. Degli scrittori “beats” non condivideva esattamente le stesse posizioni, ma anzi rifiutava una delle loro prerogative come la non-violenza, che accomunava questi ultimi al movimento hippie. Sono celebri, del resto, i molti scatti di Kate Simon che vedono Burroughs con in pugno una rivoltella da diverse angolature o l’episodio del 6 settembre 1951, quando all’interno del suo piccolo appartamento in Messico, uccise la moglie, Joan Vollmer, giocando a Guglielmo Tell. In un’intervista affermò deciso: «Io non credo alla non-violenza; le persone al potere non si autodepongono, nessuno manda fiori ai poliziotti se non tirandoli da una finestra e dentro a un vaso».

In Junky, Burroughs spiega di non essere stato in grado di scrivere nulla mentre era sotto l’influenza di droghe, tranne che sotto effetto di cannabis, sostanza che sembrava addirittura accelerare le sue associazioni di pensiero. Diversamente, quando assumeva eroina, la sua capacità di percepire sia i dettagli che l’intero processo psicofisico risultava notevolmente compromessa: “Un artista – chiarì in un’intervista – deve poter dominare i suoi sensi e la sua coscienza”; in ogni caso, è del parere che gli scrittori non debbano precludersi alcuna strada, in quanto ogni esperienza è sempre proficua,“anche la più distruttrice”. Il suo uso delle sostanze psicotrope o stupefacenti va decisamente al di là di una dimensione ricreativa o peggio autodistruttiva, e prospetta un’alternativa all’esistenza comune, piccolo-borghese, accendendo uno stimolo verso un “allargamento della coscienza”: qualcosa difficile da spiegare, a cui si potrebbe arrivare anche senza droga; mentre con gli allucinogeni, il più interessante dei quali è per B. lo yage, usato dagli «indios lungo gli altari tributari del Rio delle Amazzoni», si potrebbe giungere a un ampliamento delle percezioni con più facilità, ma il rischio della dipendenza è sempre dietro l’angolo. Sarebbe però da sempliciotti credere che le droghe possano da sole produrre una trasformazione radicale della coscienza (“in Marocco si fuma legalmente da secoli e non è successo niente di speciale”, osserva con sarcasmo in un’intervista). La domanda sorge spontanea e Burroughs non esita a porla: perché si diventa tossicodipendenti?
«La risposta è che in genere non si ha intenzione di diventarlo. Non è che una mattina ti svegli e decidi di essere un tossico. Devi farti due volte al giorno per almeno tre mesi per sviluppare una qualche dipendenza. E non sai davvero cos’è la scimmia finché non hai sperimentato varie dipendenze. Mi ci sono voluti quasi sei mesi per sviluppare la prima dipendenza, e ai tempi i sintomi dell’astinenza erano lievi. Penso di non esagerare se dico che ci vogliono un annetto buono e varie centinaia di buchi per diventare un tossico.»
La vera piaga è l’eroina (la «scimmia» che occorre numerose volte nelle pagine di questo romanzo autobiografico), a causa della quale lo scrittore stava per rimetterci la vita. Tutto ebbe inizio per curiosità, poi come tanti altri tossicomani anche Burroughs finì per assuefarsi e nel giro di sei mesi non poté più farne a meno. Era giunto al limite della sopportazione, non si lavava più né si cambiava d’abito né si spogliava quasi più, salvo per conficcare ogni ora l’ago di una siringa ipodermica nella carne legnosa dello stadio finale della droga, fino a quando non sentì parlare di apomorfina e poté scacciare via da sé la «scimmia sulla schiena».
