Questa intervista è apparsa precendemente su Quimera Rivista de Literatura, ed è stata tradotta per Limina da Serena Bianchi.
***
«Scrivo dalla prospettiva dell’adolescenza, perché secondo me è quello il luogo la rovina, è lì che si perde tutta la tenerezza.»
di Eva Díaz Riobello
Dopo l’ottima accoglienza ricevuta dalla sua prima raccolta, Pelea de gallos, [1] la scrittrice ecuadoriana María Fernanda Ampuero (Guayaquil, 1976) torna al racconto con Sacrifici umani (Gran vía, 2022), un repertorio di storie con cui l’autrice ci porta all’interno del suo universo crudo e terrificante e ci obbliga a guardare in faccia alcuni dei grandi mali della nostra società: la disuguaglianza, il dramma dell’immigrazione, la violenza di genere.
Hai scritto questo libro durante il lockdown, tuttavia nelle tue storie la pandemia non compare.
Non ho mai sentito il desiderio di sedermi a scrivere della pandemia, anche se si potrebbe pensare il contrario, visto che vengo da Guayaquil e le immagini della devastazione che il Covid-19 ha causato dalle mie parti sono diventate il simbolo di questa sciagura mondiale, della povertà. Avrei potuto farlo, avrebbe fatto da detonatore a storie terrificanti su zombi e ladri di cadaveri, ma non ho mai avuto intenzione di parlare della pandemia. Quello che ho fatto, invece, è stato usare le sensazioni che la pandemia mi suscitava per creare l’atmosfera delle mie storie. La sensazione dominante di qualcosa di definitivo, di assurdo, del fatto che non c’è niente di garantito. Ecco credo nel libro ci sia un po’ di questo: un senso di desolazione, di sofferenza per quanto a volte sia difficile rimanere vivi. Una sorte di terrore esistenzialista dovuto al fatto che il libro è stato scritto in pieno lockdown.
Eppure, davanti all’orrore che ci circonda, tu prendi altri orrori che esistevano già e ce li piazzi davanti agli occhi quasi a dire: «Questo c’era anche prima ed è ciò che sta rendendo così terribile la pandemia».
Nel libro ci sono diversi racconti, anche ambientati a Guayaquil come Invasioni, che spiegano come la progressiva disuguaglianza sociale e umana finisca per confinare le persone a una sorta di apartheid, precludendo l’accesso a un sacco di cose essenziali, come poter contare sull’arrivo di un’ambulanza se ne hai bisogno. Non l’ho pianificato, c’erano alcuni temi di cui volevo parlare, temi di cui voglio sempre parlare. Non è stata una scelta del tutto consapevole. Avevo sensazioni terribili, come quando ho scritto Pelea de gallos. A quei tempi non c’era la pandemia, ma nella mia vita stavano accadendo cose davvero feroci. È proprio questo ciò che faccio: uso questo territorio mio di lutto e conflitto per parlare di orrori antichi quasi quanto l’umanità.
Il primo racconto del libro, Biografia, è un pugno nello stomaco. Attraverso la figura della protagonista attiri lo sguardo del lettore verso molte realtà sottaciute: la precarietà degli immigrati senza documenti, la crudeltà del sistema, la violenza di genere, i maltrattamenti sugli anziani… Non dai tregua. Fino a che punto ti ha segnato la tua esperienza personale?
Innanzitutto, se ci fai caso, quando parliamo di immigrazione, come di molte altre tematiche complesse, tendiamo a utilizzare eufemismi che, a furia di essere ripetuti, perdono significato. Nel “primo mondo” è una pratica diffusa quella di togliere profondità all’immigrazione e a cosa significhi essere immigrati con espressioni di questo genere. Come quando si dice che le persone “emigrano in cerca di una vita migliore”. Niente affatto. In realtà chi emigra sa bene che la sua vita sarà peggiore, decisamente peggiore. La gente non ha la minima idea di cosa significhi non avere documenti di identità. Ti assicuro che potrei dirtelo a parole mie, dirtelo, dirtelo e ancora dirtelo. Significa, per esempio, che non puoi andare in un qualsiasi negozio Vodafone a comprare un telefono, che non puoi proprio averlo un telefono, come non puoi avere un conto in banca. Significa che ogni volta che vedi una retata ti cade il mondo addosso e inizi a pensare “Qual è la cosa peggiore che può capitarmi? Che mi arrestino? Che mi rimpatrino? Poco male, me ne torno nella mia terra, non sembra poi così tremendo”. E invece no, quello che ti capita è che ti rinchiudono in un centro di permanenza per stranieri, dove a stento riesce a entrare qualche Ong, dove non fanno entrare amici o familiari, e possono tenerti lì fino a novanta giorni, in mezzo a un mucchio di sconosciuti, in condizioni così misere che non riusciresti nemmeno a immaginarle. Con un freddo spietato in inverno e un caldo sconvolgente in estate. E tu pensi: “Mi terranno prigioniera per novanta giorni, fino a che non ci sarà un volo o non gli verrà voglia di farmi uscire di qua”. E poi sta di fatto che non puoi tornare nel tuo Paese, quindi se i tuoi genitori o i tuoi figli si ammalano… Ho sentito un sacco di casi di gente a cui sono morti i genitori, che non ha potuto lasciare la Spagna ed è stata costretta a vivere il dolore da sola. Senza nessuno che gli chieda qualcosa.
I benpensanti credono che tutto sommato viviamo bene, che un immigrato senza documenti quando si ammala possa andare in ospedale, che abbia una certa libertà di movimento… Nessuno si domanda com’è possibile che se un giorno i tuoi datori di lavoro decidono di pagarti la metà di quanto pattuito tu non possa ricorrere alla giustizia. Quando mi hanno rubato il passaporto in metro la mia prima reazione è stata andare alla polizia. A un certo punto, l’agente che mi interrogava ha cominciato a chiedermi quando fossi arrivata in Spagna, dove vivessi, se avessi il NIE e così mi sono resa conto che ero io a trovarmi nei guai. Il fatto che la tua condizione di essere umano sia accompagnata dall’epiteto “clandestino” è terribile. Maria Fernanda “la clandestina”. Io sono molte cose, ma di sicuro non sono una clandestina. E “immigrato clandestino” è diventata un’espressione talmente diffusa che nessuno gli dà più peso, ma stiamo pur sempre parlando di una persona. E come ti dicevo, non voglio neanche una vita migliore, voglio una vita. Perché un ecuadoriano decide di andar via? Gli ecuadoriani sono molto attaccati alla loro terra. Va via perché nel suo quel Paese è impossibile vivere, impossibile! Per non parlare poi dei siriani o degli afgani. Per lo meno in Ecuador abbiamo le strade, c’è una stabilità apparente. I bambini, però, non hanno niente, non c’è niente. Pensavo che una volta qui avrei avuto molto da imparare dalle crisi e dai processi migratori della Spagna, ma non è così.
È quello che capita alla protagonista di Biografia.
Biografia ha parecchio a che vedere con la mia vita, con la mia disperazione. C’è una frase in questo racconto terribile che credo riassuma la sensazione che ho provato per tanto tempo. Mi riferisco a quando la protagonista si siede fuori a un bar a prendere un caffè e dice: «Sono una persona normale». Io sono una giornalista, una tipa combattiva, non ho mai avuto paura della polizia e sono sempre stata dalla parte di chi denuncia. Qui mi sono sentita come se mi avessero privato delle mani e della voce, perché quando vedevo un’ingiustizia non potevo denunciarla. Se i miei capi decidevano di non pagarmi, non potevo fare altro che andarmene e perdere un mese e mezzo di lavoro. Per questo sono finita a fare come la protagonista del racconto, ho pubblicato un annuncio: “Scriverò la tua biografia”.
In questa storia c’è molto di me, con la differenza che in qualsiasi momento io potevo chiamare i miei genitori e chiedere loro i soldi per il biglietto di ritorno. Molti questa possibilità non ce l’hanno e tornano a casa con un debito insanabile. Questo racconto è tante cose. Innanzitutto volevo togliermi la soddisfazione di vedere se sapevo scrivere qualcosa di davvero spaventoso, usando tutti gli strumenti del genere horror, della suspense: una donna che si mette in casa di uno sconosciuto, con riferimenti a Misery, ma anche a Dracula e a Hansel e Gretel. Al tempo stesso volevo parlare di immigrazione, qualcosa che è stato così doloroso per me. Continua a essere doloroso anche parlarne nelle interviste, nonostante siano passati tanti anni da quando ero senza documenti. Ma noto che non è cambiato granché. Prima di diventare regolare ho corso tanti di quei pericoli. Per quanto il racconto Biografia sia terribile, credo che il lettore non arrivi a capire davvero come mi sentivo ogni giorno. Nessuno dovrebbe essere terrorizzato per il solo fatto di essere vivo. In Biografia c’è molto di vero. Per scrivere la biografia dell’uomo che aveva risposto all’annuncio andai fino a Sant Cugat [2] . Ovviamente non andò come nel racconto, però ci successero parecchie cose strane: la casa era assai fuori mano, l’uomo aveva molti cani e c’erano di mezzo la droga e una madre che era convinto gli parlasse da morta. Era un tipo strano, non mi diede nulla da mangiare in tutta la giornata… Lì cominciai a spaventarmi.
Ho corso un rischio tremendo, ma ho preso molto da questa esperienza per parlare di immigrati scomparsi. I nomi citati nel racconto sono reali, sono di ragazze sparite quando si trovavano già sul territorio spagnolo. Ebbene sì, queste cose succedono anche qui, nel nostro Paese, eppure nessuno si preoccupa di cercarle. Sono le ultime tra gli ultimi, il grande sacrificio umano.
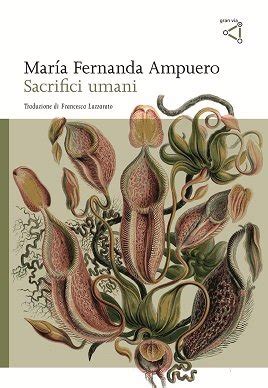
Impossibile non associare il titolo Sacrifici umani ai rituali delle civiltà precolombiane, anche se parli di qualcosa che ha luogo ai giorni nostri e di fronte alla vista impassibile di un mondo che si suppone avanzato. Oltre duemila anni di evoluzione sono consistiti nel voltarsi dall’altra parte?
Nella maggior parte delle culture i sacrifici si praticavano per un presunto bene comune. I più famosi sono gli Aztechi, che sacrificavano i nemici. Mentre lavoravo al libro, però, ho scoperto che gli Incas praticavano sacrifici umani ancora più crudeli: sceglievano come vittime i bambini, li drogavano con la yucca fermentata e li seppellivano sulle montagne ancora vivi. E altrettanto crudeli erano i sacrifici delle vergini, perché gli dei prediligevano le donne pure, le adolescenti. Io credo che anche se oggi ci consideriamo molto più evoluti, moderni, atei e tutto il resto, in realtà continuiamo a fare le stesse cose.
Mentre io e te stiamo parlando, in qualche paesino del Ghana o del Senegal un ragazzo o una ragazza sta pensando “Me ne vado”. E sa che potrebbe non fare ritorno, ma la sua famiglia ha una sola gallina per sfamare otto persone. Il Mediterraneo, dove d’estate ci facciamo il bagno, è un mare di cadaveri: nuotiamo sui figli di qualcuno. È questa l’altra faccia dell’immigrazione: quando vedi che non puoi sfamare tuo figlio, te ne vai. Questo non si può non comprendere. Vedere i tuoi figli piangere per la fame, consapevole del fatto che se rimani nel tuo Paese sei condannato a non poterti permettere nemmeno di sognare qualcosa di meglio, che dovrai rassegnarti a una vita di servizio, di precarietà, di fame, di tristezza… e tutto questo sapendo che ci sono Paesi dove le cose vanno in maniera diversa, dove non si muore di parto o di malattie perfettamente curabili. Come fai a non volertene andare? Come si fa a non comprendere una sensazione così? Per questo considero il migrante il sacrificio umano contemporaneo per eccellenza, qualcuno che sacrifica, spesso in senso letterale, la propria vita. Perché c’è un’altra cosa che ti succede quando sei un migrante, oltre a patire tutte le paure e la sofferenza che ti sto raccontando, ed è che non torni più a essere la persona di prima. Provi sulla tua pelle che basta prendere un volo di poche ore e atterrare a Madrid con l’intenzione di fermarti a vivere lì, per trasformarti nel nemico, in una persona da respingere. Questo non può che cambiarti la vita, un peso del genere sul cuore è impossibile da sopportare. Volevo solo essere la tua vicina di casa, non sono venuta per derubarti, non sono venuta a rovinare la tua città.
Una delle cose che più mi catturano del tuo stile è la capacità di costruire atmosfere terrificanti che chiamano in causa con forza i sensi del lettore. Come ci lavori?
Comincio adesso ad accorgermi di avere l’ossessione per determinate atmosfere. Mi ossessiona il cattivo odore, per esempio, perché la puzza di un corpo in decomposizione è qualcosa che non dimentichi, ti rimane attaccata alle fosse nasali. Ci sono odori così violenti da farti vomitare, che ti prendono alla bocca dello stomaco. Ovviamente letteratura e cinema non possono farteli percepire, ma per me è importante che tu li senta. Adesso che vivo sulla spiaggia, per esempio, capita che compaiano tartarughe marine morte, o uccelli, o pesci. Beh, si sente da chilometri di distanza, è qualcosa di terribile, rivoltante, che fa paura. Credo sia qualcosa di primordiale ed è questo che mi piace del genere horror: arriva fino alla parte primitiva di te. Per di più – e questo sì che l’ho studiato moltissimo per tutta la vita, visto che sono una patita del genere fin da quando avevo sette anni – chi scrive horror sa, per esempio, che hai una paura viscerale degli insetti. Perché? Perché quando vivevamo nelle caverne non potevamo sapere se la puntura di un ragno ci avrebbe ucciso. I film dell’orrore, in generale, provocano piccoli spaventi prima dello spavento grande: un insetto o un topo… E poi ci sono i mostri con i denti aguzzi, come i vampiri, che rappresentano tutte le bestie che ci fanno paura.
E il buio.
Il buio, esattamente. Al buio siamo spacciati. Quando si spostava in un posto nuovo, l’uomo primitivo non sapeva dove rifugiarsi o se sarebbe stato al sicuro. Per questo il tema della casa nuova ci fa tanta paura. All’interno del genere horror è quasi un cliché traslocare in una nuova casa, soprattutto se in campagna, perché la campagna nasconde anche ulteriori pericoli: gli animali selvatici sono più vicini, gli insetti sono più vicini.
Il fatto che i teschi ci facciano così paura è altrettanto primitivo, perché è quello che c’è dentro di noi quando non siamo più qui. Ci spaventa la vecchiaia, perché rappresenta il commiato e molti fantasmi vengono raffigurati come persone anziane. Quindi, visto che queste cose le so e ne sono ossessionata, le voglio utilizzare e per farlo devo costruire un luogo insieme al lettore. E ritengo che debba puzzare. Ho la sensazione che quello che succede nei posti dove c’è cattivo odore non vada mai a finire bene. In un modo o nell’altro qualcosa di terribile ti deve capitare. E credo che per generare un’atmosfera davvero spaventosa sia indispensabile ricorrere ai sensi, perché la paura proviene da ciò che è corporeo: cominci ad avere sudori freddi, ti si dilatano le pupille. Quella che si genera quando si guardano film o si leggono libri horror è una reazione fisica concreta, che sfugge al nostro controllo.
Molti dei racconti sono narrati dal punto di vista di adolescenti, ma sempre outsider: emarginate per colpa del fisico, della povertà o di entrambe le cose. Fino a che punto l’adolescenza è una fabbrica di mostri?
Durante l’infanzia c’è già molta sofferenza riguardo ciò di cui scrivo e per di più la cosa triste è che essendo ancora innocenti non si riesce a capire bene quello che succede. Ma lettore e autrice lo sanno bene cosa quel bambino stia vedendo e questo, come nel racconto Credenti, suscita una gran pena.
Durante l’adolescenza, però, inizi a realizzare e, se non hai qualcuno accanto, la tua vita sbanda sull’abisso senza alcun controllo. È come stare in mezzo alle sabbie mobili e, senza nulla a cui aggrapparti, sprofondare. Io penso di non essermi mai ripresa dall’adolescenza, per me è stata come una malattia che mi ha lasciato gli strascichi della donna che sono oggi. E mi fa rabbia, credo nello sguardo delle adolescenti proprio perché mi fa molta rabbia il fatto che allora nessuno mi vedesse. Nessuno. Eppure intorno a me c’erano tanti adulti, non ero una ragazzina abbandonata, non ho avuto una vita catastrofica: i miei genitori erano entrambi vivi, avevo fratelli, nonni, zii, cugini, di tutto. C’era molta gente che, presumibilmente, si prendeva cura di me, ma era un prendersi cura limitato al mondo esteriore e alla fine erano proprio loro a farmi del male. Ancora oggi non mi spiego perché nessuno mi abbia mai detto “Tu vali”. Nemmeno da adulta.
Qualche anno fa ho chiesto a mia madre se quando ero piccola mi abbracciasse e lei è scoppiata a piangere: «Perché me lo chiedi? Perché credi che non ti abbracciassi? Se eri la bimba più meravigliosa che si potesse avere». Io le ho risposto: «Perché non ho ricordi di te che mi abbracciavi dopo». Quando aveva smesso di abbracciarmi? A quello si riferiva la mia domanda, non c’era cattiveria. Capisco che è una domanda terribile da fare a una madre e non so bene quale risposta mi aspettassi. Ho riflettuto a lungo su quale fosse il momento in cui avevo smesso di essere abbracciabile, su quando avevo smesso di essere la neonata bella, visto che tutti, altra cosa tristissima, dicono di me che ero la bimba più bella di sempre, che appena nata ero perfetta, cicciottella, con le guance paffute, comunicativa. Beh io ho continuato a essere una bambina comunicativa e poi un’adolescente comunicativa, ma allora perché a quel tempo non mi amavano più nello stesso modo? Durante l’adolescenza c’è tanto dolore anche perché vivi ogni cosa in maniera così trascendentale che poi diventa trascendentale. L’idea che ho di me stessa, di quanto io sia o meno “meritevole d’amore”, è rimasta marchiata a fuoco per via di quello che mi dicevano da adolescente. A quei tempi si parlava solo di quanto fossi difficile, problematica, intensa, emotiva e bla bla bla…
È un po’ come una profezia autoavverante, dicono determinate cose su di te e tu, che non sai bene cosa sia questa roba della personalità, pensi che abbiano ragione. Voglio dire che per tutta la vita la mia famiglia mi ha detto di essere molte cose che in realtà io non sono. Ho dovuto esserle per compiacere l’idea predeterminata che loro avevano di me. Per questo motivo scrivo dalla prospettiva dell’adolescenza, perché secondo me è quello il luogo della rovina, è lì che si perde tutta la tenerezza. Ecco perché gli adolescenti del libro sono così soli, perché l’adolescenza è il momento in cui i genitori pensano: “Ormai quel che è fatto è fatto”, non rendendosi conto che attraversare il confine tra infanzia ed età adulta è un po’ come nascere di nuovo, ma da soli. Da una bambina nasce una donna e questa parte è tremenda, perché cominciano a dirti come deve essere una donna, cosa si deve aspettare dalla vita. Ti dicono che per le donne il mondo è pericoloso, che devi per forza trovare fidanzato… e se non realizzi tutte quelle che ti propinano come conditio sine qua non per essere donna, allora cosa sei? Se non sei attraente, se non hai un fidanzato, se porti gli occhiali, hai l’acne e svariati chili di troppo… Un mostro, ecco quello che sono. Ed è un genere di cose che ti porti dietro per tutta la vita.
Tra i racconti in cui denunci la violenza sulle donne, merita un’attenzione speciale Lorena, un omaggio a Lorena Bobbitt, il cui crimine ai tempi venne letto come un aneddoto divertente, mentre in realtà nascondeva una tragica storia di maltrattamento.
Per una vita sono stata in debito con questa storia, fin da quando a vent’anni sono entrata a far parte della redazione di un quotidiano. Lorena Bobbitt era della costa come me. Lei e il suo caso, diventato una notizia di portata internazionale, per noi ecuadoriani sono stati molto di più. Per il resto del mondo è difficile mettersi nei nostri panni in relazione alle notizie sul proprio paese. L’Ecuador non è la Spagna, il Messico o l’Argentina, che finiscono costantemente sulle pagine dei giornali. L’Ecuador non ci è abituato. Immagina un Paese che nessuno conosce, sempre all’ombra delle notizie, che all’improvviso diventa trending topic mondiale. Immagina le bambine di fronte alla grande popolarità che stava avendo una loro connazionale. Quanto è successo è diventato una storiella spiritosa da raccontare tra le risatine e lei il simbolo della donna pazza. Ma era pure ecuadoriana e a tutte le ecuadoriane è capitato almeno una volta nella vita di essere chiamate Lorena per scherno. Ai tempi il presidente era Abdalá Bucaram, un folle e ridicolo megalomane, uno di quei personaggi che si trovano solo in America Latina. Quando Lorena Bobbitt venne in Ecuador lui l’accolse con tutti gli onori e l’intero Paese commentò: «Guarda questo pazzo». È vero, è stato un politico terribile e corrotto, ma in quell’occasione fece la cosa giusta, diede importanza a questa donna come persona. Tutti, però, lo criticarono. A nessuno interessavano le cause di quella vicenda, è l’invisibilità del visibile. Lorena aveva vissuto torture, una violenza domestica inimmaginabile di cui ancora oggi non sappiamo tutto, perché ci sono cose che non ha potuto dire pubblicamente. Io sono convinta, a giudicare da come scoppiò a piangere durante il processo, che suo marito l’aveva torturata anche sessualmente. E ciononostante del caso di una vittima di tortura non rimane che un aneddoto emblematico e divertente. La gente rideva di lei e nessuno si concentrava su di lui. Lui è stato non solo perdonato, ma osannato. Ecco perché mi sentivo in debito. Qualche anno fa finalmente il cineasta Jordan Peele ha fatto un documentario su Lorena Bobbitt con il focus giusto. Avrei sempre voluto intervistarla, sognavo di scrivere un libro in cui potesse raccontare la sua storia in prima persona e così, alla fine, ho usato la fiction. Sentivo di dover fare qualcosa, fosse anche solo scrivere il suo cognome da nubile. Di fatto lei è stata Lorena Bobbitt per soli tre anni, non ha più quel cognome.
Che progetti hai adesso?
Il mio sogno è che le mie storie arrivino sul grande schermo. Io sono, ovviamente, figlia della lettura, ma questa generazione pretende di andare al cinema. E io nutro un immenso rispetto per la narrativa cinematografica, impazzirei di gioia a immaginare che qualcosa di mio diventi un film horror: dover pensare alla musica, alla scenografia… che poi, a dire il vero, è quello che faccio già quando scrivo.
Note
[1] Pelea de Gallos (2018, Páginas de Espuma, Madrid) è la raccolta di racconti che ha fatto conoscere María Fernanda Ampuero e il suo stile al pubblico internazionale. Alla sua ottava edizione in Spagna e tradotto in inglese con il titolo di Cockfight, al momento è ancora inedito in Italia.
[2] Sant Cugat del Vallès, comune spagnolo di situato nella comunità autonoma della Catalogna.
Copertina – Stefano Pollio tramite Unsplash
