Ci sono scritti che trovano lettori perché non li cercano, che rifiutano qualsiasi forma di negoziato con un saeculum in attesa di una redenzione troppo semplice. Scritti che si sottraggono alle locuzioni e ai costrutti del paniere angusto di chi crede che la salvezza sia merce che va in saldo. Scritti che impongono la disciplina rigida della lettura severa, maculati dell’aristocratico e irremovibile senso di chi traccia i confini del Bene e del Male non per la via del frusto raziocinio ma per ispirazione divina. E così chi li scrive pretende consacrare il pomerio di una cittadella per pochissimi, eletti non per sola grazia, ma per opera di inclemente scarnificazione a mondare in loro tutto quanto è umano, quindi sordido. Di questo spirito di reazione letteraria, che profuma di antiquariato nobile e poco intramondano, non c’è incarnazione più tangibile e appuntita che l’opera di Cristina Campo.
Professionista della pseudonimia sin dall’età più tenera, Vittoria Guerrini nasce e muore malata: il dotto di Botallo pervio, cioè la mancata chiusura del canale tra arteria polmonare e aorta, che desterà scompensi e crisi di cui non si libererà mai. Ma di crepacuore Vittoria morrà per ben altre e più monde ragioni che non un organo mal concepito: la sua insistita pervicacia nel sostenere cause dichiarate perse sin nell’ultimo grado di giudizio – benché, ella confidava, di giudizio umano si trattasse, mentre accorta e spietata molava il trionfante ricorso presso il Tribunale della Giustizia universale della Seconda venuta. È di questa donna pia, che negli ultimi anni della sua vita si fa consumare le carni dal dolore per il trionfo dei riformatori al Concilio Vaticano II, e non della scrittrice Campo, che qui vorrò scrivere. Non tanto per amore di una cronaca che oggi sa di ritaglio di pagina ingiallito, quanto perché i suoi ultimi anni offrono la chiave per apprezzare appieno una scrittura che altrimenti si potrebbe intendere come irriducibile difesa di un’aristocrazia morale e stilistica un po’ fine a sé. All’opposto, Vittoria sempre ritenne che la scrittura fosse al servizio del più sommo degli scopi e che il suo uso della parola, di millimetrico chiarore e bellezza abbacinante, non dovesse mai sopravanzare quest’umile certezza. E se di Vittoria Guerrini lo scrivente, ahimè, non condivide la fede, specie in una forma così virile e superegoica, questo non farà da limite, perché la lettura dei suoi testi ispira quel senso primitivo di devozione che fa da viatico verso l’Ineffabile – e che in quest’Entità non-detta si creda o meno, a chi legge i suoi testi sembra comunque di star traversando porte regali aperte sul soprannaturale.
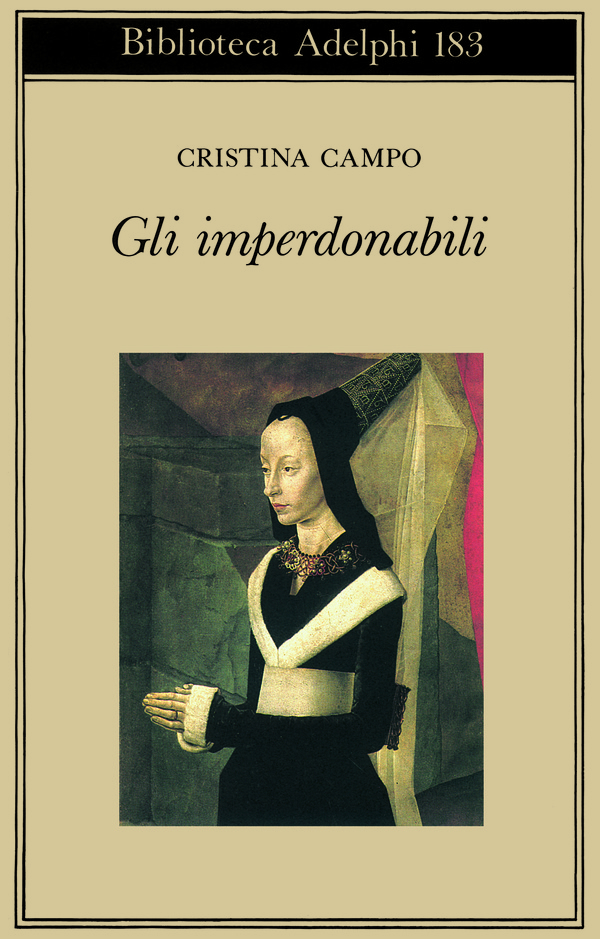
Invero la sua devozione, mai pietosa, gravida di uno zelotismo umorale e un po’ folle, precede la conversione al cattolicesimo più tradizionalista di metà anni Sessanta. Nasce il 29 aprile 1923 in una famiglia che appoggia il regime fascista senza alcun indugio e alla sua caduta inizia a contare i giorni che separano un mondo in debito di guida dal tracollo per eccesso di libertà. Il padre Guido, direttore di conservatorio e compositore di fama, non fa mistero della sua sfiducia nei confronti del sistema democratico, né dissimula il proprio antisemitismo (tratto che, sia detto, la figlia non eredita). Per parte sua, Vittoria, a mo’ di provocazione in una società che a suo giudizio volta pagina con eccessiva leggerezza, a voce alta loda le gesta di Mussolini nella Firenze del Secondo dopoguerra. Eppure, non è tanto la sfiducia nella democrazia che rende Vittoria riottosa alla socialità postbellica. A suo giudizio, l’errore fa uso abbondante di maschere e sa indossare quelle che offrono una giustificazione comoda: lo stato di cose che principia con la fine del fascismo non è che una delle mille forme di una ben più preoccupante rinuncia collettiva a quella pratica intransigente della perfezione che sola consente l’esperienza del vero. Solo verso gli anni Sessanta, questo “vero” s’incoronerà di maiuscola, per assumere il volto lacrimoso di Cristo. Ma al di là della strada particolare che imboccò in quegli anni, è in questo radicatissimo convincimento della necessità di perfezione che bisogna cercare l’anima “campale” di Vittoria Guerrini – anima che riluce di una coerenza corrosiva e un po’ sfiancante, o che quantomeno ha corroso e sfiancato lei sino a strapparle la vita ancor giovane, il 10 gennaio 1977.
Per tutta la sua vita, Campo si dà a un costante esercizio verso una raffinatezza sempre più equilibrata ma sempre più gravosa per chi se ne dota. Un rituale della perfezione, appunto. E in effetti Vittoria muove da quella intuizione che, in Sacrificio, di Andrej Tarkovskij, il protagonista Alexander rende con parole che confeziona ad uso futuro del giovanissimo figlio: «Di’ pure quello che vuoi, ma un metodo, un sistema, ha il suo valore. Sai, talvolta mi dico che, se ogni giorno, esattamente alla stessa ora, facessimo la stessa identica azione, come un rituale, nello stesso identico modo, sistematicamente, ogni giorno alla stessa ora, il mondo cambierebbe». Non c’è modo più stringato ed efficace di spiegare la furia iconolatra di Campo nella difesa del rito tradizionale: solo il rito, l’azione ripetuta con metodo e precisione ossessiva, è in grado di sostenere la vita. Eppure, a metà degli anni Sessanta, dopo la morte del padre, il cui funerale fu celebrato nell’abbazia di Sant’Anselmo all’Aventino con una sontuosa messa da requiem, Campo “inventa” la propria fede per congegnarsi un’origine mistica di questa sua smania febbrile e metodica. La sua passione trova un oggetto naturale nella tradizione millenaria della liturgia latina proprio quando questa affronta la precipitosa fine che gli tocca in sorte.
L’8 dicembre del 1965, dopo tre anni di lavori, si chiude a Roma il Concilio Vaticano II. La cultura post-conciliare del decennio a venire ne declina gli esiti nel senso di una grande rottura col passato, pienamente visibile nella rivoluzione che ebbe a subire l’ordinamento rituale della messa, rispetto al tradizionale rito stabilito nel 1570 col Messale Romano di Pio V, in lingua latina, con l’altare rivolto verso il Tabernacolo e il sacerdote rivolto verso Dio, con le spalle al popolo, e molti altri aspetti che marcano differenze rimarchevoli. Per Campo il sostanziale prosciugamento della liturgia, resa più celebrazione festiva che pratica rituale, assieme alla dismissione del latino, segna un lutto che non troverà elaborazione. La Chiesa pone fine a quelle ritualità che sole fanno da chiave per decrittare il mistero dell’esistenza. La riduzione di quei movimenti obbligati che forgiano le condotte oltreché le anime, la volgarizzazione della lingua liturgica universale, l’apertura a un pluralismo delle fedi che per lei è deliberata inclinazione psicotica: tutto questo a suo giudizio significa la resa della Chiesa a una modernità che già da tempo aveva fatto strame dell’arte e della bellezza. In Campo cresce come pianta infestante l’«ansia nervosa di una spoliazione e purgazione totali, unita ad una natura sin troppo consapevole della propria oscura, macerata, altera torbidezza» (Cristina Campo, Sotto falso nome, Adelphi 1998, p. 70).
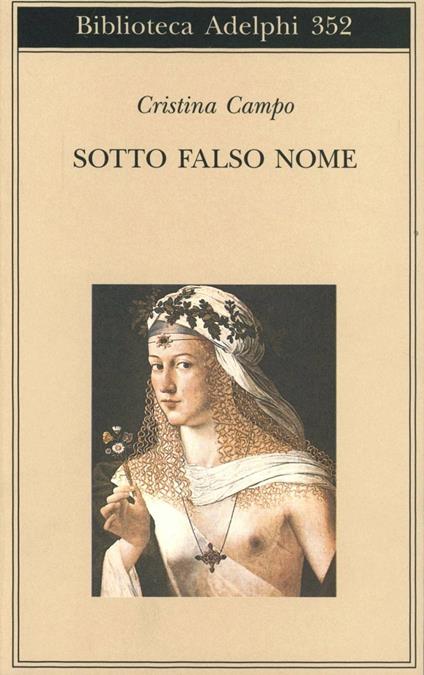
Ma varrà la pena insistere: il suo attivismo a favore del rito latino fu tutto fuorché brama di visibilità o passione per le cause perse. Le asperità del culto tridentino non sono che la forma incarnata delle pratiche di perfezionamento cui si presta da decenni: «Chi aborre, dunque, dalla perfezione? Si sarebbe tentati di sospettare coloro che sanno di che cosa la perfezione sia fatta, quel che costi ottenerla: le vigilie notturne, i duri mattutini, i voti di castità, obbedienza, povertà che essa impone» (Cristina Campo, Gli imperdonabili, Adelphi 1985, p. 79). E proprio come la liturgia è rivolta al Cristo e ne intensifica il contatto vitale, lo stile è sentimento della vita, vitalità procurata dall’esercizio ripetuto e meticoloso: «Che cosa è stile? La prima immagine che si presenti è questa: una virtù polare grazie alla quale il sentimento della vita sia nello stesso tempo rarefatto e intensificato. Cosicché, grazie a un movimento simultaneo e contraddittorio, là dove l’artista concentra al massimo l’oggetto riducendolo, come i pittori T’ang, a quell’unico profilo, a quella pura linea dall’alto al basso che è, per così dire, la pronuncia stessa dell’anima, il lettore lo senta in sé moltiplicarsi, esaltarsi in armoniche innumerevoli» (Campo, Gli imperdonabili, p. 81).
Ma se è vero, com’è vero, che questo breve scritto non vuol essere pura celebrazione, e al di là della dubbia mia titolazione a parlare di uno stile davvero perfetto, vorrei qui rilevare lo spessore teorico dell’intuizione di Campo – intuizione che non è affatto esito di quell’oscurantismo metafisico di cui lei e la sua cerchia furono più volte accusati. All’opposto, quel modo di concepire il rito ha da qualche decennio acquisito un valore scientifico nel campo dell’antropologia della religione – si pensi ai lavori di Roy Rappaport e di Adam Seligman, oltreché, naturalmente, di Émile Durkheim – per cui il rito è l’atto sociale fondamentale, senza il quale non si dà società. Senza entrare in tecnicismi, superflui in questa sede, il rito può intendersi come la sequenza di atti ed enunciati formali più o meno invarianti, non interamente codificati da chi li esegue o li pronuncia. In ciò si perfeziona l’idea che, proprio come ritiene Campo, il rito sia l’attuazione e la trasmissione di un significato non interamente comprensibile da chi pratica. Un modo della comunicazione che non presuppone la chiara comprensione dei suoi termini. Se questa, per Campo, era la ragione per difendere il latino e respingere la volgarizzazione della liturgia, lo stesso vale per poesia e letteratura, che andavano rinunciando alla perfezione dello stile per una chiarezza e una semplicità che di fatto smerciano inganni. Per Campo, che di sé diceva «ha scritto poco e le piacerebbe avere scritto meno», la parola, lirica o letteraria, è il momento fatale in cui si cerca un’aderenza non linguistica ma pratica all’ordine delle cose, che mai sta scritto in caratteri leggibili all’occhio dell’essere umano. La parola, mediante l’opera di costante ricerca di perfezione, deve approssimarla, coglierla, intuirla in una visione che sia percezione dell’esistenza reale e che scacci la presunzione umana di comprendere e sciogliere in termini semplici.
Sicché il rito, proprio come la letteratura e la poesia, non è questione di fruizione, ma di pratica. Nell’esecuzione del rituale, l’attore prende parte all’ordine liturgico, mentre voce e corpo si fanno strumenti di trasmissione e reiterazione di significati. Solo attraverso questa pratica l’attore entra in una relazione con il messaggio del rito – messaggio canonico, che sta e riposa nei suoi effetti. E, se per Tarkovskij, l’effetto par excellence è il miglioramento del mondo, per Campo è un sentimento della vita rarefatto e intensificato. Ma è probabile che Tarkovskij e Cristina intendano la stessa cosa. Quando piange l’eutanasia del rito tridentino, Cristina piange invero il collasso della cultura occidentale. Non solo la Chiesa universale perde l’amore per una pratica che sola è garante della vita sociale, ma tutta l’arte moderna perde quella proclività per la perfezione che ella chiama “attenzione”: «Se dunque l’attenzione è attesa, accettazione fervente, impavida del reale, l’immaginazione è impazienza, fuga nell’arbitrario: eterno labirinto senza filo di Arianna. Per questo l’arte antica è sintetica, l’arte moderna analitica; un’arte in gran parte di pura scomposizione, come si conviene ad un tempo nutrito di terrore» (Campo, Gli imperdonabili, p. 167). Sintesi come riconciliazione di elementi che stanno assieme solo per mistero e che l’analisi – sinonimo, se si vuole, del razionalismo illuministico, fonte d’ogni male – scompone senza poi saper ricongiungere.
«L’attenzione è il solo cammino verso l’inesprimibile, la sola strada al mistero. Infatti è solidamente ancorata nel reale, e soltanto per allusioni celate nel reale si manifesta il mistero» (p. 167). Cristina come Cenerentola e Belinda, per cui la cui perdita delle cose è guadagno, e la cui pratica di rinuncia è «amorosa rieducazione di un’anima – di una attenzione – affinché dalla vista si sollevi alla percezione. Percepire è riconoscere ciò che soltanto ha valore, ciò che soltanto esiste veramente» (Campo, Gli imperdonabili, p. 10). Il mondo che la circonda, il mondo della letteratura dominante e della chiesa post-conciliare, viene vissuto nel filtro di una vita che non è più e che si ripresenta sotto le spoglie oniriche di quell’infanzia per la quale Campo sparge ovunque semi di nostalgia:
«Uno spazio assoluto, si direbbe. Fatto invece proprio di quei divieti, di quei confini invisibili, così simili ai lacci della metrica, ai puri anelli della rima. La memoria vi insiste a volte sino al tormento, come intorno a un’estasi negata. E di tempo in tempo, con una pervicacia angelica e crudele, un sogno ricorrente ce li presenta di colpo – l’orto concluso di cui si cerca piangendo l’entrata, la casa deserta o distrutta, l’acqua invisibile che potrebbe parlarci, come il fiume Scamandro, se solo arrivassimo a tuffarvi una mano… Per altri può essere musica inafferrabile, voce dietro multiple porte, parola o lingua perfetta che nell’atto di scriverla si cancella»
(Campo, Gli imperdonabili, pp. 20-21).
Quello di Campo è un repertorio di oggetti ingestibili e tormentosi: ineffabile e tremenda, la parola perfetta che lega e riflette l’ordine delle cose, cui si giunge per oblazione e tragica catarsi. Ma ha ragione Guido Ceronetti, alfiere anzitempo della forza unica di testi miracolosi: «Queste Cose Scritte non contengono la minima, la più impercettibile traccia d’impostura. Il mendacium ci viene colato incessantemente nello stomaco indifeso, conficcato nella carne, sparso sopra i capelli, incollato alle fibre, con ogni mezzo, con furore, e un’orribile assuefazione, peggiore della morte, ci minaccia tutti. Per poter resistere, ci vuole un’ascesi del ribrezzo» (G. Ceronetti, Cristina Campo o della perfezione, in Cristina Campo, Gli imperdonabili, p. 281). A cent’anni dalla sua nascita, forse Cristina Campo offre una via per il riscatto di un mondo letterario che ha abbracciato il saeculum della lingua facile, rassicurante, terapeutica. Per fare letteratura e poesia, e per fruirne, bisogna pure un po’ soffrire. Forse non dalla posizione estrema auspicata da Campo, eppure liberi da quelle odierne volgarizzazioni della lingua, che lusingano, rassicurano, persino accarezzano, per lasciarci nella nostra cronica condizione di minorità.
Immagine di copertina: Cristina Campo
