A Maria Nicola,
per i pinguini troppo soli.
Roberto Bolaño pubblica I detective selvaggi (Adelphi) nel 1998, quando ha già diverse opere alle spalle ed è un autore affermato. È il suo libro-mondo, il suo romanzo più lungo e complesso, la cronaca non soltanto della sua giovinezza poetica ma anche della sua scrittura e dei suoi sogni. I Detective è un omaggio alla poesia sconfitta, che per Bolaño è l’unica che conti, e al disincanto di una generazione, la sua, sopravvissuta a colpi di Stato e utopie e orrori e amori; è un’ode ai molti sudamericani perduti nel mondo. Ma cominciamo dalla fine.
Quando il giovane poeta Juan García Madero comincia a tenere il proprio diario, che dà inizio al romanzo, crede nella parola scritta, mentre quando il libro volge al termine e Madero e Lupe sono in fuga nel deserto di Sonora il diario contiene solo rapidi appunti presi di sfuggita, poche righe circondate dal silenzio e infine, da ultimo, una domanda malinconica, «Cosa si vede dalla finestra?», con un rettangolo che dà sul mondo fuori dal diario e dunque fuori dal romanzo. Il finale può essere un omaggio alle tante poesie “disegnate” di Nicanor Parra, poeta molto amato da Bolaño, o un rimando a poeti francesi quali Jean Cocteau o Eugène Guillevic, che usava anch’egli forme geometriche nelle proprie poesie (nella raccolta Euclidiennes), oltre naturalmente che un richiamo alla poetessa realvisceralista Cesárea Tinajero. E tuttavia il silenzio di Madero, il rarefarsi della sua scrittura in quel febbraio del 1976 a Sonora, è anche e innanzitutto il silenzio di Arthur Rimbaud, il poeta adolescente per antonomasia, che a soli vent’anni ha detto addio alla letteratura. È probabile che dopo il 1976, come Rimbaud, neanche Juan García Madero abbia più scritto poesie.
Per Bolaño non solamente la poesia ma anche i poeti devono estinguersi, fuggire, procacciare in silenzio l’avventura poetica (e antipoetica) che alla poesia reale corrisponde, infine morire nell’oblio da vivi, finché altri poeti non si illuderanno di poter raccogliere i pochi passi e i pochi versi da loro amati e poi rinnegati e lasciati al vento e quindi perduti. L’avventura poetica, tutto quanto circonda la vita devastata di chi scrive o ha scritto e tace, è a un tempo il riflesso e il rovescio della poesia stessa, la promessa mai fatta eppure mantenuta del poeta adolescente e non (Parra è morto a centotré anni) di rispettare la dignità della parola. Non si scrive più perché altrimenti ci si sporcherebbe; non si scrive più perché si è scritto troppo, o troppo poco, e perché c’è troppo da scrivere, come diceva il giovane Stendhal (“Ho troppo da scrivere, ecco perché non scrivo nulla”), e la poesia è silenzio e fuga e incanto e ribellione al verbo.
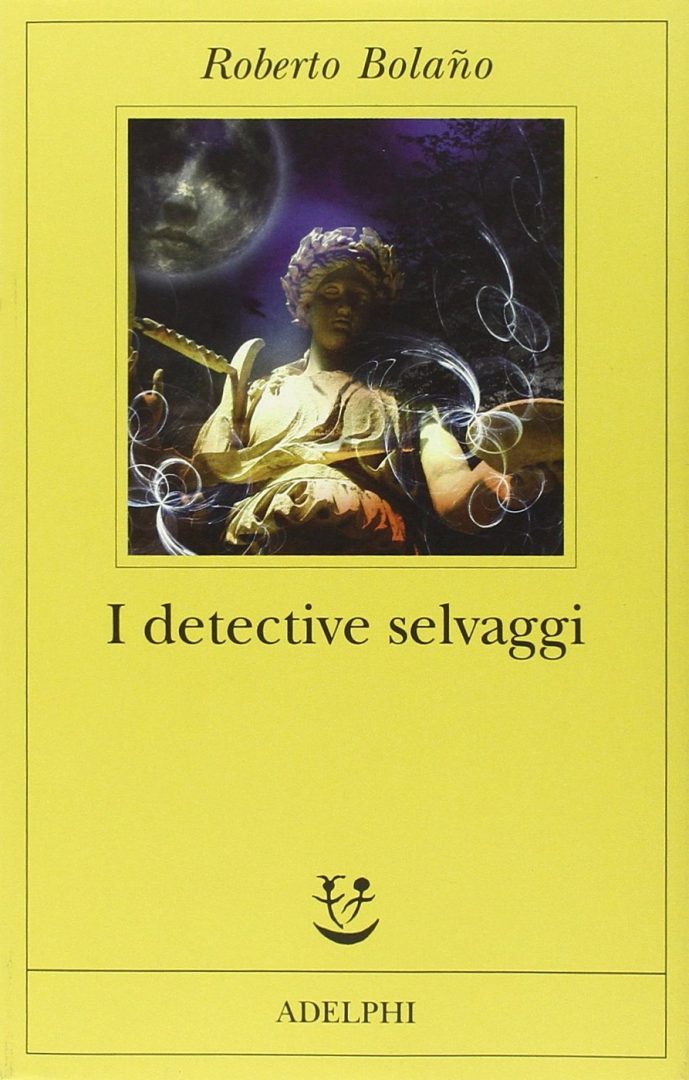
Naturalmente Roberto Bolaño ha scritto fino alla morte, sebbene abbia affermato più volte che se fosse stato ricco avrebbe scritto solo una o due poesie all’anno, ma noi non gli crediamo. Perseverare, continuare a scrivere romanzi e racconti e saggi e persino poesie, non arrendersi al silenzio pur nella coscienza della vanità di ogni parola scritta, può anche essere un atto nobile, un atto sacro e necessario proprio perché votato alla sconfitta, perché “un giorno l’Opera muore, come muoiono tutte le cose, come si estingueranno il sole e la Terra e il Sistema Solare e la Galassia e la più recondita memoria degli uomini”, come dice Iñaki Echavarne ne I detective selvaggi. Arturo Belano, alter ego di Bolaño nel romanzo, ha lo stesso nome di Arthur Rimbaud, ma pure un cognome che rimanda alla parola novela, cioè “romanzo” (la b e la v in America Latina si pronunciano quasi allo stesso modo), come già osservava Enrique Vila-Matas in Dalla città nervosa, quindi i Detective è il grande romanzo di un poeta che avrebbe potuto tacere e non lo ha fatto.
Ciononostante, come Rimbaud, Belano finisce in Africa, in guerra, dove cerca la morte e il silenzio (e l’orrore del poeta) che alla morte e alla guerra soggiacciono; dopo le pagine africane, nella seconda parte del romanzo, di lui non si hanno infatti più notizie. È notte fonda. Belano, Jacobo Urenda e il fotografo López Lobo vegliano con molti altri nell’oscurità, insonni, nel cuore di tenebra della guerra africana. È Jacobo Urenda a raccontare. Sente dei bisbigli intorno a sé, al buio, in gio e in mano, in lingua mandingo e in krhan, in inglese e in spagnolo, e di colpo tutte le lingue del mondo gli paiono abominevoli. Dopodiché aggiunge:
«Dirlo adesso, lo so, è uno sproposito. Tutte le lingue, tutti i mormorii sono una maniera vicaria di preservare per un intervallo di tempo aleatorio la nostra identità.»
Dunque scrivere, come parlare, come raccontare una storia, è un modo di negarsi al silenzio e all’orrore dell’oblio e di ricordare l’uomo, ciò che siamo o siamo stati o abbiamo creduto di essere, seppure per un intervallo di tempo aleatorio. Pure per questo bisogna continuare a scrivere, a raccontare, perché il destino di Rimbaud, come il destino di ogni poeta, può anche essere fatto di voci e vite che si negano al silenzio e al vuoto e che si raccontano. In questo senso I detective selvaggi è un grande libro umano, un molteplice sfilacciarsi di voci umane che, inseguendo i fantasmi di Arturo Belano e Ulises Lima, narrano la propria storia, ovvero la storia della poesia, della letteratura, dei libri e persino del mercato letterario, dell’editoria, come nei brani tratti dalla fiera del Libro di Madrid, in cui ogni scrittore fa fronte a proprio modo al divario spaventevole che divide l’atto privato di scrivere e di essere poeti dall’atto sociale di pubblicare, di farsi leggere, di essere riconosciuti in quanto poeti.
Se le ultime tracce di Belano si perdono in Africa, nell’insensatezza della guerra, Ulises Lima finisce invece in un giardino messicano, il Parque Hundido, camminando insieme (ma in senso opposto) a un altro poeta universalmente riconosciuto, il premio Nobel Octavio Paz, lui che non è nominato in nessuna antologia di poeti e che pure è poeta come e forse più di Paz. I realvisceralisti avversavano la poesia di Paz e dei suoi accoliti, come quella di Neruda. Lima si dichiara il penultimo poeta realvisceralista rimasto in Messico. La segretaria di Paz, che racconta l’incontro, lo invita a sedersi con il premio Nobel, e lui acconsente. Sono al Parque Hundido, cioè “Parco Affondato”, luogo che richiama alla mente una frase del romanzo: «Il poeta non muore, sprofonda, ma non muore», detta da Hugo Montero, una delle tante voci del romanzo. Octavio Paz e Ulises Lima sono sprofondati nel malinconico oblio che a ogni poeta corrisponde, seduti l’uno di fianco all’altro in un giardino messicano. Paz ricorda Cesárea Tinajero e i realvisceralisti. La segretaria di Paz si allontana, lasciandoli parlare. Finalmente Ulises Lima si alza e porge la mano al premio Nobel, che gliela stringe. È un momento di grande pietà e poesia; poi i due poeti si separano per sempre.
Di Ulises Lima – che nella “realtà” è Mario Santiago, grande amico di Bolaño morto investito da un’auto poco prima dell’uscita del romanzo – non sapremo altro. La seconda parte del libro si avvia alla conclusione e i poeti scompaiono. Il mondo dei Detective è una successione di racconti che potrebbe durare per sempre e che tuttavia deve finire, un rincorrersi di destini incrociati e sovrapposti che cercano continuamente un centro, un significato dell’esistenza e della poesia, e non lo trovano, non possono trovarlo perché o non c’è o ha le sue fragili fondamenta nel silenzio e quindi deve essere taciuto e dimenticato.
I poeti taceranno e dimenticheranno e saranno a loro volta dimenticati, succedendosi nel tempo. Il diario di Juan García Madero – la narrazione – riprende. Siamo stati in Israele, a Parigi, in Spagna, in Messico, in Liberia e altrove, ovunque ci abbiano portati le tumultuose voci della sezione centrale del romanzo; infine ritorniamo da Juan García Madero, giovane poeta pieno di speranze, da Lima e da Belano e da Lupe, in una macchina che si allontana per sempre nel deserto, e parliamo di poesia. Roberto Bolaño non ha mai dimenticato l’incanto della poesia vissuta, l’ingenuità e la sacra libertà della sua adolescenza poetica.
In un certo senso, come lo stesso Juan García Madero, che probabilmente cesserà di scrivere ma di certo non cesserà di amare la poesia, Bolaño non ha mai smesso di essere o di sentirsi “adolescente”, sulla pagina e nella vita. Una parte non trascurabile del suo fascino, che alla sua opera è connesso, riguarda i suoi atteggiamenti e i suoi gusti letterari e perfino i suoi insulti, perché per lui scrivere significa trovarsi in un costante stato di sovversione estetica e poetica e romanzesca e non c’è poeta che – come un bambino – non sia anche un guerriero. «Io ho speranza nei bambini» ha detto nella sua ultima intervista, poco prima di morire. «Nei bambini che scopano come bambini e nei guerrieri che combattono da valorosi.» Così Roberto Bolaño combatteva (canagliescamente, adorabilmente), nelle opere e altrove. Così – secondo lui – Luis Sepúlveda avrebbe dovuto «essere mandato nella Corea del Nord per almeno nove anni», come ha affermato in un’altra intervista. Così Isabel Allende è una «escribidora», una scribacchina, come Marcela Serrano o Arturo Pérez-Reverte o Paulo Coelho o molti altri supposti scrittori fin troppo celebrati e magnificati dal mondo editoriale. Così, nel caso di Osvaldo Soriano, che pure per Bolaño era un buon romanziere minore, «bisogna avere il cervello pieno di materia fecale per pensare che a partire di lì si possa fondare una corrente letteraria». Così Enrique Vila-Matas, suo amico e ammiratore, ha potuto confessare, poco dopo la sua morte: «Grazie al fatto che avevo l’impressione che Roberto Bolaño leggesse tutto, vissi in uno stato di costante rigore letterario, perché lui aveva alzato l’asticella della qualità molto in alto e io non desideravo deluderlo.»

I romanzi e i racconti e le poesie di Bolaño sono vivi. Molti autori di diverse generazioni e lingue e culture si rifanno a lui, alle sue strutture romanzesche e al suo senso dell’estetica, taluni addirittura alla sua integrità artistica. I detective selvaggi, come 2666, è uno dei grandi romanzi del nostro tempo, un’opera che si raffronta al silenzio e all’oblio della poesia e che nondimeno la racconta. È anche una grande opera morale; non a caso Bolaño amava molto Blaise Pascal. «Tutto questo ha una soluzione?» si chiede Sebastián Urrutia Lacroix, nel finale apocalittico di Notturno cileno, pubblicato quattro anni dopo i Detective e un anno prima della sua morte. La risposta – «E allora passano a una velocità da vertigine i visi che ho ammirato, i visi che ho amato, invidiato, disprezzato. I visi che ho protetto, quelli che ho attaccato, i visi da cui mi sono difeso, quelli che ho cercato invano» – è una tormenta di merda. Ma rimane anche altro. Benno von Arcimboldi, indimenticabile personaggio bolaniano, siede al tavolino di un bar di Amburgo e ordina un Fürst Pückler, un tipico gelato tedesco. Si avvicina un uomo anziano. È Alexander Fürst Pückler, antenato dello scrittore a cui si deve il nome del gelato che mangia Arcimboldi, e quel dolce è tutto quanto resta dell’opera di Fürst Pückler, che oggi nessuno legge né ricorda più. «Che eredità misteriosa, non crede?» dice l’uomo anziano. È il finale di 2666. Arcimboldi concorda e se ne va, di ritorno in Messico, e il romanzo – come la vita del suo autore – si conclude.
Così, fra tormente di merda e gelati mai dimenticati, nell’oblio della parola e della poesia che tale parola non riscatta né può assolvere, fra voci e personaggi che si susseguono nel tempo e che il tempo annullano o sconvolgono, continuiamo a rileggere e ad amare quel grande scrittore e poeta che è stato Roberto Bolaño.
Illustrazione copertina di Eleonora Reggiori
