Zachor, Ricorda, è l’imperativo ebraico. Così fondamentale da incombere non solo sugli esseri umani ma anche su Dio. La memoria è un dovere, prima ancora che un bisogno o uno sterile esercizio mentale. Ho letto, tutto d’un fiato, Il pane perduto di Edith Bruck (La nave di Teseo). Non solo perché è un romanzo breve (difficile dire se romanzo, racconto o memoir: la materia che tratta rende arduo ridurlo a un genere) ma perché straordinariamente intenso, come la donna che lo ha scritto. Il passato non è passato, non è relegato a uno sfondo lontano, inaccessibile al presente. Edith Bruck si inserisce, con grande forza narrativa, in questa dimensione simultanea del tempo che è contemporaneamente presente, passato e futuro. Gli attimi di cui è composta la vita non se ne vanno via per sempre, perché si fondono in un amalgama infinito che rende coevi tutti gli avvenimenti dell’esistenza. Se pure appare come una linea retta, il tempo non è che un segmento di una circonferenza dal raggio infinito, in cui la memoria è materia viva, presente, pulsante, dolorosa. Anche se imparentati, memoria e ricordi non sono la stessa cosa: mentre i primi sono statici e, in questa loro dimensione, finiscono per sbiadire e sfumare, la memoria asseconda la natura circolare del tempo, avvince la fine all’inizio, in un legame in cui non è possibile distinguere l’una dall’altro. E così Edith, a 90 anni, torna ad essere la Ditke del 1944, una tredicenne vispa, intelligente, dal cuore tenerissimo, ultima di sei figli di una povera famiglia ebrea, in un piccolo villaggio dell’Ungheria, dove corre scalza e spensierata, le bionde trecce sballonzolanti.
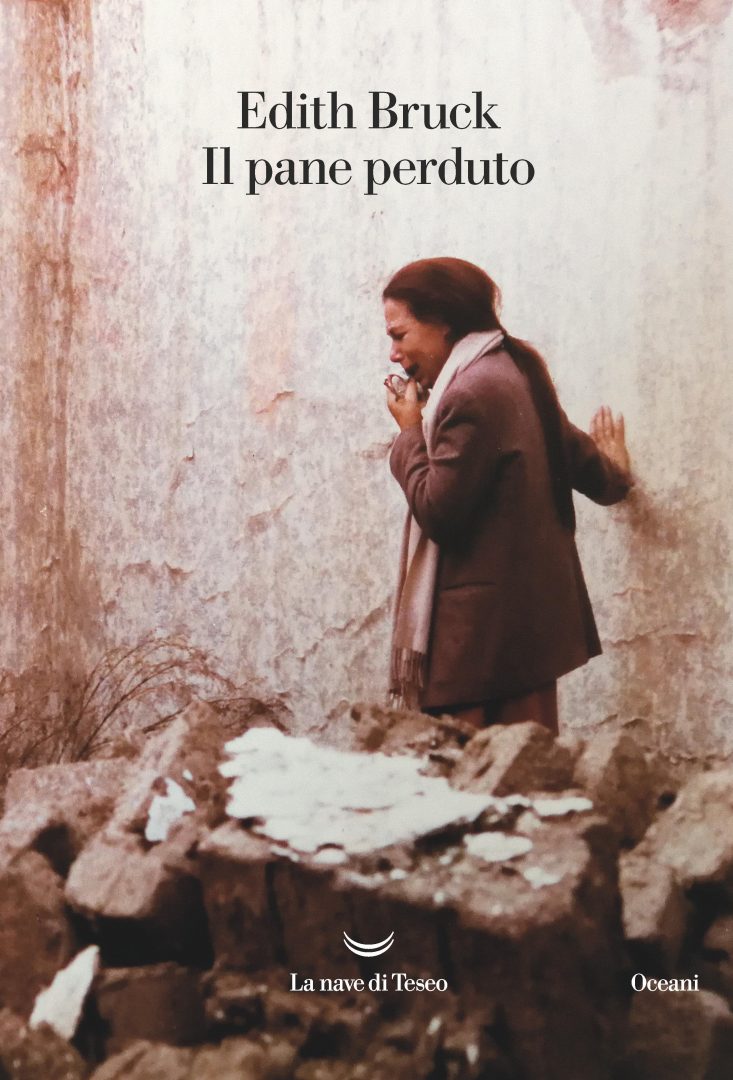
Ma l’odio antisemita monta di giorno in giorno. Ditke se ne accorge: «Heil Hitler», la saluta il maestro. Lei e i suoi fratelli non conoscono Hitler o poco sanno di lui. Il padre e la madre cercano di rassicurarli: la prima invocando la protezione di Dio, il secondo bestemmiando, sbattendo la porta, andandosene, confidando nell’imminente fine della guerra. E poi i canti osceni dei giovani in strada. La bambina non capisce e domanda alla madre: «Perché non ci vogliono? Anche noi siamo ungheresi, no?».
Le restrizioni antisemite, progressivamente imposte dal regime filonazista di Ferenc Szálasi, si fanno sentire e, in poco tempo, tutto cambia. Ineluttabile come la primavera che l’accompagna, arriva Pesach, la Pasqua ebraica, dove si narra e si celebra l’uscita degli ebrei schiavi dall’Egitto. Ma ha un sapore tragico quella Pesach del ‘44: la festa della liberazione prelude allo sconvolgimento della vita della famiglia di Edith, come di quella delle altre famiglie ebree del piccolo villaggio. Tensione estrema e sofferenza permeano il racconto di quel pane che la madre impasta con la gioia di chi pregusta il momento in cui lo riassaggerà, dopo aver rigorosamente osservato per otto giorni il divieto di mangiare cibi lievitati. All’alba, le mani della madre lo inforneranno. Ma la pasta, lavorata con tanto amore, non diventerà mai il pane agognato, la donna non nutrirà di quello i suoi figli.I gendarmi ungheresi irrompono con violenza, strappano Ditke e la sua famiglia dalla casa appena costruita con miseri risparmi. È l’inizio di una vicenda agghiacciante che l’autrice racconta con la potenza evocativa che solo la verità possiede. Difficile, per esempio, rappresentare l’odio con tanta vividezza come fa Edith Bruck: quest’odio, così estraneo e pure così riconoscibile da chi ne è stato vittima, che non smette ciclicamente di far capolino, rialzare la testa, quasi a ricordare che l’uomo è sempre uguale a se stesso. Edith dichiara che questo libro, come quelli che l’hanno preceduto, è un monito contro l’odio, l’antisemitismo, qualsiasi forma di razzismo, di discriminazione. Lei non perdona perché non può farlo a nome di chi non c’è più, ma non odia, ci tiene a ribadirlo. L’odio le era entrato nella carne viva quando le hanno marchiato il suo nuovo nome, il numero 11152. Conforta però sapere che anche l’amore entra nella carne: ed è l’amore per sua madre, finita nelle camere a gas, appena arrivata ad Auschwitz. Alla madre perduta vanno le invocazioni, le preghiere, i pensieri e le speranze della bimba e della donna che diventerà. All’anima di questa madre, Edith dedica versi struggenti nella raccolta di poesie Tempi (La nave di Teseo):
«Mi dicevi di pregare
prima di dormire
e io mormoravo
qualche poesia imparata a scuola.
Adesso penso a te
tutte le sere
prima di dormire
e so che tu sei stata
e sei la mia salvezza….»
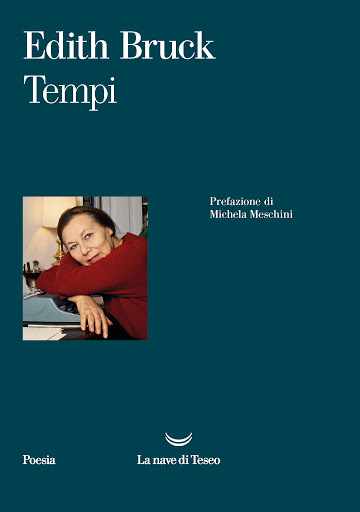
A questo Dio che la madre interpellava su ogni cosa, dalla più grande alla più piccola, Edith Bruck si appella nelle ultime pagine del romanzo, con una lunga, sofferta, lettera. Lo fa in nome di quella donna che, a fronte di tanta devozione, è stata tradita da Colui in cui aveva così fervidamente creduto. C’è rabbia nella parole che gli rivolge: come si fa a non arrabbiarsi con Lui se le preghiere non servono a niente, se non cambiano niente e nessuno? Talvolta, le figure di Dio e della madre si confondano, si sovrappongono: «eri sempre tu che mi hai rimesso alla luce». La lettera a Dio è forse un estremo tentativo di rendere giustizia a quelle ombre, non solo dei suoi cari, di unirsi al loro grido, spento da gran tempo, verso il silenzio di Dio.
