Ottanta battiti d’ali al secondo, l’esercizio mesmerizzante per restare immobili nella tempesta. Lo sa bene il colibrì, che possiede la straordinaria abilità di rimanere sospeso a mezz’aria per cibarsi del nettare dei fiori. E, proprio come il volatile appartenente alla famiglia dei Trochilidi, sembra dispiegare le sue traiettorie di volo Marco Carrera, l’oculista oftalmologo protagonista di Il colibrì, nuovo acclamato romanzo di Sandro Veronesi edito in ottobre da La nave di Teseo; un uomo che rimane fermamente ancorato al suo mondo mentre tutto intorno sembra mutare di forma e di segno, sottoposto all’azione erosiva del tempo.
Già, il tempo. Perché Il colibrì si presenta tra le mani del lettore come una di quelle linee temporali che le insegnanti facevano costruire a scuola con fogli, forbici e colla per comprendere il meccanismo cronologico. Ma Veronesi, rispettoso verso la tradizione letteraria sin dai tempi di Per dove parte questo treno allegro (Theoria, 1988) e allo stesso tempo profondo innovatore della scrittura di fine secolo come dimostra Venite venite B-52 (Feltrinelli, 1995), gioca barthesianamente a smontare l’orologio per capire cos’è il tempo. Così, la storia di Carrera non può che essere ricucita come un foglio strappato in mille pezzi e pazientemente ricomposto, attraverso un bricolage metaletterario che sa combinare i generi e i registri, nella creazione di un nuovo modo di intendere il romanzo realista affacciato sul Ventunesimo Secolo.
Nei buchi neri e negli strappi di una narrazione dal battito irregolare, emerge la vita del protagonista, della voce assente del fratello Giacomo, della sorella Irene morta suicida, dell’amore segreto Luisa Lattes, della moglie Marina e della figlia Adele. Carrera affronterà il tema della separazione e poi del dolore senza mai progettare piani di fuga, ma piuttosto restando stoicamente immobile, coricato sulla riva della storia italiana degli ultimi decenni, tra lettere, tracce psicanalitiche e sogni. Fino all’arrivo di una nuova speranza che, forse, assumerà la forza di una preghiera «per lui, e per tutte le navi in mare».
Ne abbiamo parlato con l’autore, in esclusiva per Limina.
Il colibrì esce a distanza di tredici anni dal Premio Strega di Caos Calmo. Si sente cambiato, come narratore?
Sì, perché in tredici anni si cambia per forza. Non credo siano dei cambiamenti irreversibili, sono piuttosto degli assestamenti, dei colpi di barra. Teoricamente, vista l’età, dovrei andare verso la stabilità, ma non è così. Non so dire quali cambiamenti ci siano stati da un romanzo all’altro; piuttosto, li vedo direttamente sul libro, mentre sono lì. Attraverso la scrittura mi rendo conto di cosa mi riesce difficile o più facile, di cosa mi sento portato a fare. Magari riesco persino a superare il passato.
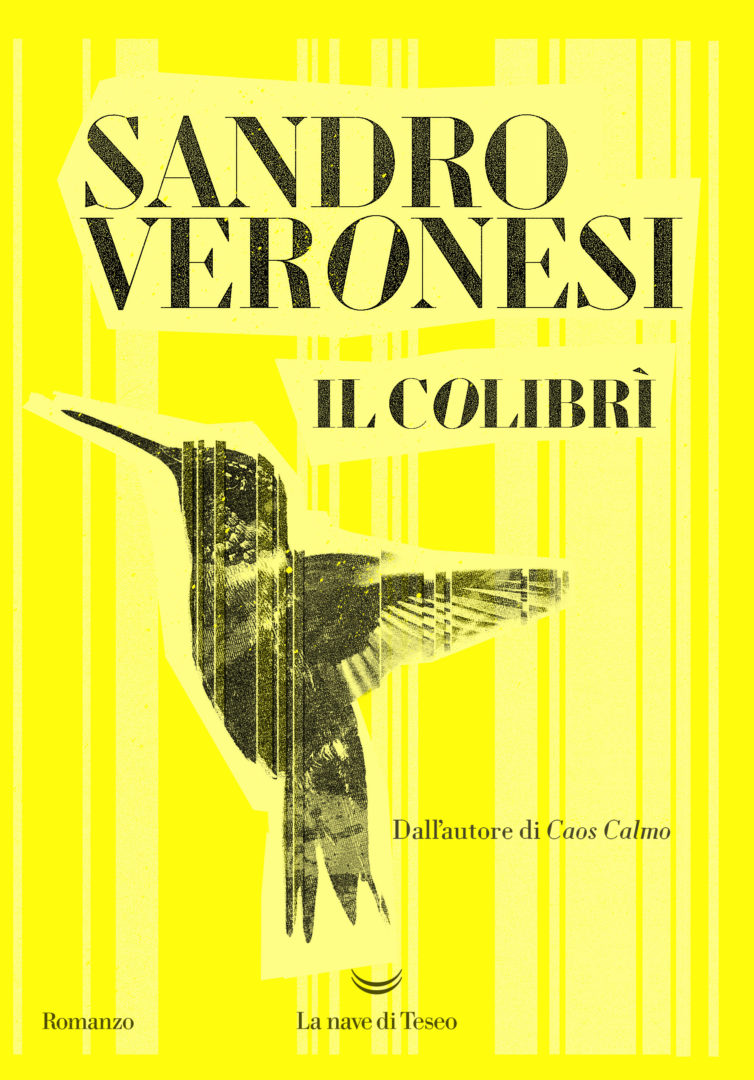
Qual è la fonte sorgiva della scrittura di questo romanzo?
Questa volta, non so dire da dove nasca il mio lavoro. Altre volte sono partito da immagini primarie, da spunti. Invece con Il colibrì c’è stato qualcosa che evidentemente è venuto dal profondo, e su cui io non ho giurisdizione ma che ho solo potuto gestire una volta affiorato in superficie. Certamente c’è da considerare una riflessione che ho fatto in questi ultimi vent’anni sul dolore nella nostra società e nella nostra cultura, via via sempre più demonizzato e che invece rappresenta non solo una certezza ma anche un’energia, una forma di cambiamento. Il dolore è l’oggetto dei nostri desideri e della nostra libido, e quindi qualcosa di catartico, necessario. La nostra cultura non lo premia, si compatiscono gli esseri umani che soffrono. Invece, per certi versi, possono essere considerati degli eletti, dei privilegiati.
Dunque potremmo considerare la perdita come un motore vitale.
É chiaro che la perdita è pur sempre una perdita. E in questa perdita c’è un pezzo di noi che non torna di più, in lutto. Ma è anche un motore per un rinnovamento. É così nella natura, nelle forme animali. Ed è molto più faticosamente così per l’uomo. Se in natura queste perdite sono da considerarsi anche come eventi catartici o di rinnovamento, non c’è ragione di pensare che non possa essere così anche per l’uomo.
Eppure del dolore si continua ad avere paura, è il grande rimosso della nostra società. Si potrebbe leggere Il colibrì come un attacco alla patina conformista del nostro tempo, e in particolar modo alla famiglia borghese?
L’attacco è nei fatti. La famiglia che cerca a tutti i costi di mostrare il benessere, magari nascondendo la sofferenza, produce ulteriore dolore. E lo produce nel peggiore dei modi, censurandolo. E quindi crea, soprattutto nei figli, un doppio legame che diventa difficile da gestire. Un tempo la famiglia borghese era quella che aveva vissuto in maniera meno ingessata rispetto all’aristocrazia i cambiamenti portati dal progresso e quindi si pensava fosse quella più illuminata. Poi però si è arenata, diventando un po’ il contrario, e oggi possiamo dire che tutte le famiglie sono borghesi. Oggi si discute dentro il Parlamento se debbano per forza essere formate da persone di sesso diverso, e quindi mi pare che sul concetto di famiglia siamo molto indietro. In generale, c’è qualcosa che non funziona tra il dentro e il fuori dei nuclei famigliari, ed è molto probabile che il risultato sia il dolore, la sofferenza.
In questa tensione nella quale le relazioni sembrano sempre sul punto di spezzarsi, lei scrive un romanzo nel quale le persone per stare insieme devono inventarsi fili invisibili che le leghino a qualcuno, come fa Adele, la figlia del protagonista.
Quel filo che lega insieme le persone mostra tutta l’ambivalenza di queste relazioni. Può essere sia un legame che un enorme problema, ma è pur sempre una metafora della famiglia. Il filo che lega Marco Carrera alla figlia è una bella immagine, che però porterà al dramma.
Recidendo il filo, si guadagna libertà ma si può smarrire la via. «Per andare dove non sai/devi passare per dove non sai» scrive San Giovanni della Croce in un passaggio che sottolinea. E dunque il suo romanzo è popolato di personaggi che intraprendono direzioni sbagliate, fughe asimmetriche e spesso nocive, come i fagiani che si gettano nel fuoco che vengono evocati in una lettera di Marco a Luisa.
Penso al problema del falso movimento. Nel romanzo abbiamo un protagonista che cerca di stare fermo, e l’immagine dei fagiani è il contrario di quello che fa Marco; vengono puniti per essersi mossi in maniera irrazionale. Marco Carrera invece è consapevole che molto spesso le cose sono destinate a peggiorare e quindi tanto vale serbarle così come uno le ha conosciute. Personalmente sono per il cambiamento, un uomo del Ventesimo Secolo, non ho mai personalmente praticato la conservazione come forma di sopravvivenza. Invece, forse, è proprio il caso di guardare a quello che fa Carrera, perché c’è la possibilità che il nostro tempo ci abbia ingannati, ci abbia suggerito che il cambiamento è sempre e comunque sacro e invece non lo è. E il cambiamento nella sua scrittura viene reso percepibile da un montaggio quasi cinematografico, costruito sullo sfalsamento dei piani temporali e sul cambio del punto di vista della narrazione. I salti temporali sono dovuti soprattutto all’esigenza narrativa di rendere meno terribile l’impatto con le tragedie presenti in questa storia. Attraverso questo montaggio, quando viene descritta una tragedia il lettore è già stato nell’indomani di quel dramma, ha già visto che il mondo non è finito, mentre nel momento in cui accade una tragedia si ha la sensazione che tutto finisca. Per quanto riguarda il montaggio, poi, si tratta di una tradizione narrativa che viene da lontano.
Che quindi non ha a che fare con il cinema?
Qui mi pare ci sia un equivoco: per quanto riguarda la scrittura di montaggio, o per immagini, la letteratura l’ha fatto ben prima che il cinema lo inventasse. Il cinema è debitore, e non creditore, della letteratura. Di tutte le sue tecniche, non ce n’è una che non sia già stata precedentemente utilizzata dai narratori. Naturalmente sono tecniche che utilizzano linguaggi diversi; quello cinematografico ha bisogno di una troupe e della tecnologia, mentre quello letterario ha semplicemente bisogno di un bravo scrittore. Il cinema ha semplicemente trovato il modo di riprodurre immagini come immagini, e non come pagine che evocano immagini. Victor Hugo ad esempio è uno scrittore che sembra abbia inventato il cinema, tanto sono piene di immagini le sue pagine. Il che significa che uno scrittore quando scrive pensa alla tradizione letteraria e non allo spin-off, magari più popolare, ricavato al cinema. E questo, per quanto mi riguarda, spiega perchè io valga poco come scrittore di sceneggiature: lo specifico della scrittura cinematografica è ben diverso da quello che io pratico nell’evocare immagini o nel montarle. É un’altra cosa.

La scrittura di Il colibrì ingloba forme anche eterogenee di racconto possibile. Ad una narrazione tradizionale si sommano come doppi letterari gli scambi epistolari, gli elenchi e le liste di oggetti, gli interventi per convegni universitari, le e-mail e persino gli scambi di sms. Il romanzo oggi sta mutando in qualcosa di nuovo?
Quello che so è che è già tanto che oggi i romanzi vengano ancora scritti e pubblicati. Sono tempi in cui bisogna cercare di resistere, e basta. Io non ho inventato niente, ci sono romanzi sperimentali da oltre cent’anni, e non ritengo Il colibrì un’opera sperimentale. Oggi si smette di avere a che fare con la necessità e con la fede di esprimersi attraverso la narrativa di finzione, che forse è quella che meglio racconta la verità proprio perché non ha obblighi di fornire prove. In fondo, l’unica prova in letteratura è una pagina ben scritta. É una grande opportunità per leggere la realtà in cui si vive, ma soprattutto per ragionare in termini che siano diversi da quelli della cronologia, della storia della cronaca. Ci sono cose che passano inosservate e poi si rivelano quelle che ti trascinano giù nei sentimenti più profondi, quando si vive una vita senza pensare, senza troppo riflettere su ciò che si fa. Il romanzo, quando è bello, è un modo di trascinarti nel profondo in maniera piacevole. E ciò vale anche quando il romanzo non passa dei momenti particolarmente floridi, come in questo momento.
Ma la scrittura sopravvive. Forse perchè è un modo di piegare il tempo, l’inevitabile caducità delle cose?
Lo è molto più la lettura. É una cosa che sento più forte quando leggo, piuttosto che quando scrivo. Perché scrivere porta con sé la fatica, il dolore del dover riaprire le ferite del profondo. La scrittura per me è semplicemente una cosa necessaria, mentre prima era stata un grande desiderio. Dopo aver avverato il desiderio, è subentrata l’esigenza. Un’esigenza che non produce benessere, quando scrivo non sto bene, e devo resistere perché non c’è nessuno che mi obbliga, è un lavoro di autodisciplina.
Eppure da quelle ferite riaperte è riuscito a creare una galleria di donne che non si dimenticano facilmente. Adele, Irene, Luisa, Marina, Miraijin. Ha voluto scrivere un romanzo al femminile?
Non avevo la consapevolezza, e non l’ho nemmeno ora, di aver scritto un romanzo sulla sfera femminile. Per me quello che veramente conta è la condizione umana, non tanto declinata nei generi. É vero che è il romanzo con più personaggi femminili che io abbia scritto, e questi personaggi coprono uno spettro piuttosto ampio della femminilità, e quindi in un certo senso danno anche conto di una forma di empatia nei confronti della condizione femminile. Ma non era un intento programmatico, soprattutto perché per quanto mi riguarda un romanzo non ha mai nulla di programmatico. Le cose affiorano con una loro logica armonica.
Anche «L’uomo nuovo» che lei auspica è di sesso femminile. Chi è questa bambina che rende luminoso il finale della sua opera?
Per me è una speranza. E lo è per Carrera. Ho voluto mettere in scena un personaggio che da un certo momento in poi ci crede. Ci crede sul serio che questa bambina possa essere l’uomo nuovo. All’inizio poteva sembrare una forma di condiscendenza nei confronti della figlia, ma da un certo punto in poi, non avendo più altra scelta, Carrera non può fare altro. Del resto, non è mai successo nulla di importante nella storia senza che ci si credesse. Come nel Colibrì, non accadono le cose per caso. I veri cambiamenti avvengono perché qualcuno ci crede.
