Oltre che da un’intesa profonda, cresciuta nel corso di vent’anni di amicizia, Eva e Jake sono legati (l’uno all’insaputa dell’altra) dal ricorso a una metafora aerea per descrivere la propria condizione: la prima, riflettendo sul disagio che ha sconvolto la sua esistenza altoborghese dopo la vittoria di Donald Trump – disagio al quale ha reagito acquistando un appartamento a Venezia in cui poter fuggire –, confessa all’amica Min (una specie di dama di compagnia) di sentirsi perennemente su un areo, costretta a ripetere in continuazione, senza mai potersi confondere, «L’aereo non si schianterà, l’aereo non si schianterà» – anche la più piccola distrazione potrebbe risultare fatale; il secondo, durante una lunga passeggiata confessionale assieme a Bruce, il marito di Eva (uno dei momenti più belli del libro, che sembra uscire da una memoria veneziana di Harold Brodkey) racconta di aver vissuto gli ultimi trent’anni (ne ha poco più di cinquanta) «a volare in tondo in attesa del permesso di atterrare». Nel freddo di un inverno in Connecticut sta ricordando di Venezia, appunto, dei suoi vent’anni, di un amante (il primo) morto di Aids, Vincent («un nome che è l’anagramma di Venice con una “t” appiccicata in fondo»), di una bellezza sciupata dal troppo desiderio di vivere e godere. Di come, dopo quell’episodio, abbia deciso di non toccare più terra, di non concedersi più niente di così bello e puro. Jake è un arredatore d’interni – si è occupato di tutte le abitazioni di Eva e Bruce – ma confessa di non sapere che cosa sia una casa (soprattutto la sua), o che cosa dovrebbe essere.
Di questo stare faticosamente dentro la vita che si abita (le “mura”), sfuggendo o aspettando, ben preparati, qualche tipo di disastro, il titolo originale del nuovo romanzo di David Leavitt, Shelter In Place, evoca una dimensione ben precisa, di tipo emergenziale, quella del “restare dove si è”, senza muoversi o fuggire, nell’attesa che ciò che ha costretto a “barricarsi dentro” sia passato. Ma nell’ovvia necessità di trovare un’alternativa, la scelta de Il decoro per l’edizione italiana (SEM libri) funziona altrettanto bene, perché racconta di come tutti o quasi i personaggi del libro – a quelli già citati si aggiungono la divorziata Sandra, aspirante scrittrice, la coppia di editor Aaron e Rachel, il socio in affari di Jake, Pablo, più una costellazione di bellissime figure minori – provano a reagire a quell’emergenza perenne che è la vita, o in cui si è trasformata, più o meno inaspettatamente, la vita per colpa di un’elezione presidenziale o perché, come accade a Bruce – che resta a lungo fuori fuoco (alle “dipendenze” narrative di Eva) per poi stagliarsi, felice, in una bellissima luce primaverile, nell’ultima immagine del libro –, si varca un confine senza neppure accorgersene, dopo aver creduto che «la rotta fosse già tracciata». Bruce, un consulente patrimoniale tanto ricco da non sapere quanto, non capisce come e perché sia successo ma, appunto, al termine del romanzo (Eva a Venezia con Min) sta sorridendo, in giardino, accanto a un’altra donna, ed è una delle rare volte, lungo tutto il libro, in cui uno dei personaggi sperimenta una gioia pura – che poi significa: senza alcun decoro. All’interno della casa, Jake e Rachel assistono muti. Ma la felicità di Bruce è anche quella di chi non si rende conto di essere guardato: non gli interessa più.
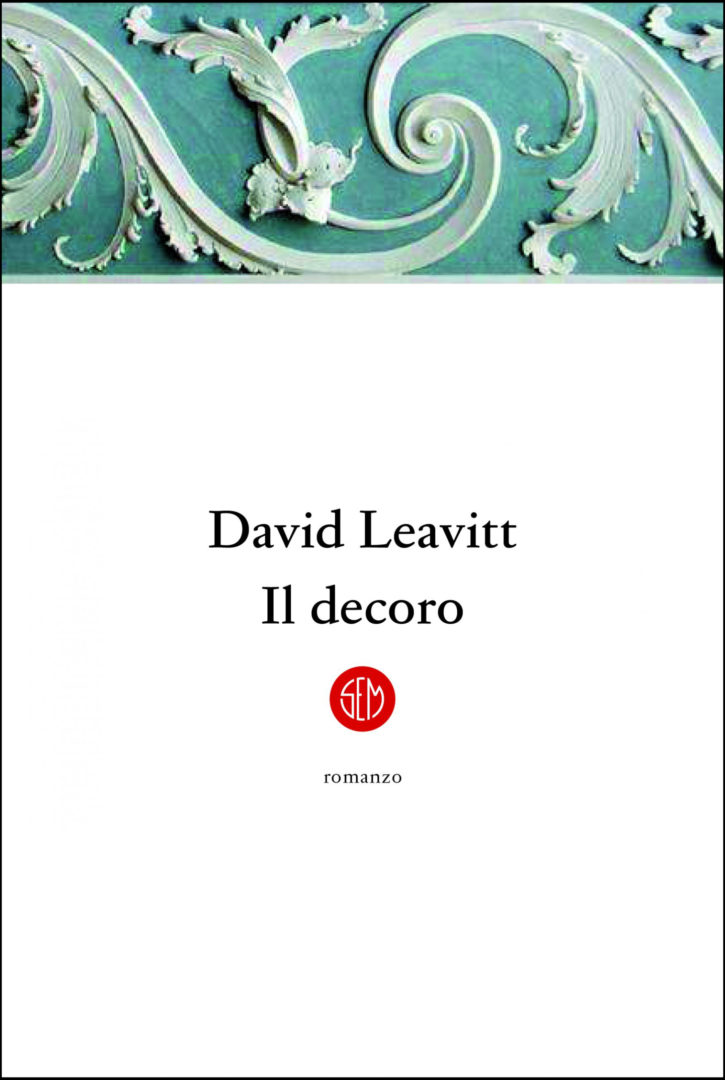
Decoro, in effetti, significa anche questo (forse, soprattutto questo): vivere chiusi tra le mura resistenti dello sguardo dell’Altro. Nel ricordo di Jake, non a caso, Vincent è un’ultima occhiata da un letto d’ospedale; e poi tutte quelle case che Eva compra e vende e si fa arredare dall’amico: perché i suoi ospiti – e a casa sua c’è sempre qualche ospite – la possano vedere per quello che desidera si veda. Del resto, per quanto decoro suoni un po’ più gentile di conformismo (mentre evoca l’idea supplementare di scenario), rimanda pur sempre a un restringimento di campo, e Leavitt è bravissimo a trasformare la metafora spaziale – aerei in volo, case, Stati Uniti ed Europa, libertà e prigionia… – in uno dei principi guida dei moltissimi dialoghi di cui si compone il romanzo (nel quale succede pochissimo). Così, per esempio, entrare in dettagli raccapriccianti è, per Eva, un crimine imperdonabile (se ne macchia Matt, uno dei tanti giovani omosessuali e di bell’aspetto di cui adora circondarsi “scenograficamente” e che ingaggia come cuochi, e per questo sarà allontanato); Trump è nominabile solo attraverso l’aggiramento lessicale di una perifrasi; di questioni spinose come i rapporti di genere o la sicurezza personale si palleggia audacemente, e con una buona dose di riferimenti letterari e citazioni, ma solo fino a quando le parole non cominciano a condurre in «un posto dove nessuno di noi vuole andare» (Jake).
Del resto, le tradizioni cui Leavitt si ricollega questa volta sono, espressamente, quella del romanzo statunitense borghese “d’interni” (Richard Yates e John Cheever, per citarne solo due) e quella, borghese in modo diverso, del grande racconto ottocentesco ed europeo, due tradizioni che gli servono per cogliere confini e misure della buona borghesia bianca, ricca, colta e liberal dell’America contemporanea, che egli osserva da lontano, in modo insieme fotografico e teatrale, esattamente come farebbe un Balzac (senza per questo scadere in un facile sociologismo). Anche se, alla fine del romanzo, il “genere” cui viene maggiormente da pensare è quello, pittorico, dei conversation pieces – un’altra tradizione europea e borghese, animata da un desiderio “scultoreo” di autorappresentazione, di campitura finemente organizzata di convenzioni, decoro, status sociale. In fondo, la crisi personale di Jake – il personaggio più umbratile e dolente del libro – e le sue tante esitazioni professionali nascono proprio dalla coscienza dell’ormai avvenuto e irreversibile scambio tra immagine e realtà, modello e singolarità. Non a caso, nel corso delle tante conversazioni che trascinano il romanzo, Jake spesso tace, o scompare improvvisamente con la scusa di far passeggiare i cani di Eva e Bruce (tre Bedligton), o sembra che non ci sia, ritirato da qualche parte, se non proprio in fuga dalla cornice. Non vuole entrare del tutto nel quadro, e finisce così per somigliare a una figura ricorrente del conversation piece, quella del personaggio che dall’interno spinge lo sguardo fuori campo, verso lo spettatore (e potrebbe anche essere una richiesta di aiuto, non solo un invito narcisistico).
Secondo la stessa logica “perimetrica”, per quanta attualità e storia recente ci siano ne Il decoro, a Leavitt interessa soltanto come e quanto esse entrano (hanno il permesso di entrare) nelle vite dei suoi personaggi, quanto spazio reale possono guadagnarsi all’interno delle esistenze privilegiate e tutto sommato protette (anche se percorse da nevrosi e paure quotidiane) di uomini e donne che sembrano passare il tempo a definirsi e anzi a darsi una forma in un complicato gioco (più o meno consapevole) di rispecchiamenti. Da un certo punto di vista, attraverso uno stile pacato e iperrealista, Leavitt doppia il mestiere di Jake, e dentro uno spazio spiccatamente teatrale e spesso totale (ma quasi tutti i personaggi hanno un loro capitolo o passaggio “privato”), organizza una sequenza di scene per poi innescare il gioco (non di rado al dolce e rispettoso massacro) dei ruoli. È così che il romanzo, al di qua di qualsiasi frettoloso giudizio morale, riesce, insieme, a consegnare un ritratto tagliente di una certa America e a rinnovare la riflessione su uno dei grandi temi che attraversano tutta la narrativa intimista, più che minimalista, dello scrittore fin da Ballo di famiglia, quello della coscienza, spesso dolente, di ciò che non si è – non si è più, non si è diventati, non si potrà più essere.
Così, anche l’indecorosa eccezione di Bruce non coincide fino in fondo con qualche miracolosa soluzione, né tantomeno appare come la rivendicazione di un uomo che ha finalmente deciso di percorrere una strada diversa. Bruce non ha scelto un bel niente: forse si è distratto un attimo, e l’areo è caduto; forse, dopo tanti anni in volo, qualcuno l’ha costretto ad atterrare. Il contrario di decoro, nel suo caso, non è indecenza o disonore, ma spreco. Bruce, a differenza degli altri personaggi, ha scelto – questo sì – di saltare la battuta prevista dal dialogo: «Non c’erano risposte a quelle domande. Non ce ne sono mai, quando le domande riguardano il modo in cui le cose sarebbero potute andare se non fosse cambiato qualcosa. E qualcosa era cambiato». Che cosa, però, non lo sa.
Photo credits:
Gregory Crewdson, Plate 19
