«Venne preso da una grandissima ammirazione per Ibsen: un’ammirazione che ebbe l’effetto di una ventata improvvisa sulle vele d’un panfilo nella bonaccia o di un colpo di timone su un battello alla deriva»: così Stanislaus Joyce, nella sua autobiografia Il guardiano di mio fratello, affermava del fratello maggiore James, studente a Dublino fra college e università, negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, quando vide pubblicato il suo primo articolo, in cui recensiva l’ultima pièce del grande drammaturgo norvegese Quando noi morti ci destiamo, sulla Fortnightly Review (ricavandone 12 ghinee, con stupore dei suoi compagni studenti), sostenendo si trattasse «di una delle opere più grandi dell’autore, se non proprio la migliore». Ibsen venne a conoscenza delle benevole parole che Joyce aveva speso per lui e volle ringraziandolo scrivendogli tramite il suo traduttore William Archer. Sfogliando le raccolte di lettere oggi in commercio di James Joyce, le prime in ordine cronologico sono esattamente quelle inerenti la breve ma significativa corrispondenza del 1900 e 1901 in cui uno sconosciuto studente di Dublino si rivolgeva con grande ammirazione all’illustre maestro di settantratré anni già celebre in Europa (meno nella provinciale Irlanda) e che, ormai anziano e malato, sarebbe morto pochi anni dopo. «Sono un giovane irlandese di diciott’anni e conserverò nel cuore le parole di Ibsen per tutta la vita», scrisse, e se consideriamo che Joyce non fu mai un idolatra – gli scrisse anche questo – e rari saranno i casi in cui rivolgerà tanta ammirazione a un artista suo contemporaneo, allora è evidente che Ibsen aveva già lasciato il segno in lui, fin dalle prime letture che Joyce affrontava in originale studiando il norvegese e fino alle rappresentazioni teatrali cui poté assistere soprattutto a Trieste, Zurigo e Parigi.
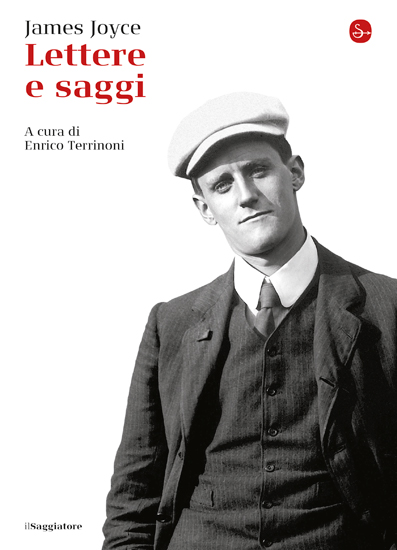
Nelle Conversazioni con Arthur Power, Joyce definì Ibsen «un bel drammaturgo che ha scritto drammi seri che interessano la nostra generazione […] si può dire che l’ha in gran misura formata lui. Le sue idee sono diventate parte della nostra vita, anche se non ce ne rendiamo conto». E di questo Ibsen era capace proprio perché, come Joyce sosteneva nella sua sopracitata recensione, «ha scelto le esistenze medie, nella loro implacabile verità […] come un eroe si districa tra le prove dell’esistenza terrena […] come in cima a un’alta vetta, gode di una visione perfetta, ha l’imparzialità degli angeli, la vista di chi può fissare il sole con gli occhi aperti». Non è proprio dalla rappresentazione della vita vera che prendono linfa le storie dei Dublinesi? Non è anche dello Stephen Dedalus del Ritratto dell’artista da giovane l’ideale di artista «come il Dio della creazione, che rimane dentro o dietro o al di là o al di sopra della sua opera, invisibile, sottilizzato fino a svanire, indifferente, intento a limarsi le unghie» e la cui missione primaria sia quella di «incontrare per la milionesima volta la realtà dell’esperienza e a forgiare nella fucina della mia anima la coscienza increata della mia razza», dunque delle nostre generazioni?
In tale opera di esplorazione intima e spregiudicata dell’esistenza, Ibsen e Joyce trovano un vettore comune: la donna. «La conoscenza che Ibsen ha del genere umano non è mai tanto evidente quanto nei suoi ritratti femminili […] sembra conoscere le donne meglio di quanto si conoscano loro stesse […] averne scandagliato i più profondi recessi», rivela Joyce nel suo articolo. Per quanto la compagna Nora sostenesse quanto invece di donne non capisse proprio nulla, è indubbio che Joyce portò nelle sue opere la nuova centralità dei personaggi femminili che aveva ammirato in Ibsen.
Ellida, ovvero La donna del mare che rinuncia in extremis a fuggire dalla sua famiglia con il suo amante lontano, un marinaio misterioso, può ricordarci la medesima rinuncia finale di Evelin nei Dublinesi, che deciderà di non prendere assieme al suo la nave dal porto di Dublino con il suo ragazzo, anch’esso marinaio. Ma l’essenza di una donna del mare ci ricorda anche di altre donne “acquatiche” joyceane, come la ragazza uccello marino del Ritratto o Anna Livia Plurabelle, la donna-fiume in Finnegans Wake.
Nel poemetto Giacomo Joyce, viene citata esplicitamente Hedda Gabler (la sua donna ibseniana preferita), «Una ragazza a cavallo. Hedda!», rivelandoci un feticismo per le ragazze cavallerizze che ritornerà evidente nel personaggio di Mrs Yelverton Barry del quindicesimo episodio di Ulisse. Rimanendo fra le pagine di quest’ultima opera, la più acclamata di Joyce, sappiamo bene che essa si conclude col celebre monologo di una donna, Molly. Anche nell’opera più celebre di Ibsen, Casa di bambola, è ancora affidata alle parole definitive di una donna la chiusura dell’ultimo atto, una donna di nome Nora (che Ibsen avesse condizionato Joyce anche nel nome della sua futura compagna?).
Non si entra e non si esce indenni dalle case nei drammi di Ibsen. È in quelle case che si giocano le gelosie, i tradimenti, le dissolutezze delle famiglie e dove si impara a mettere le redini agli scandali, cosicché non possano trapelare fuori dalla porta.
«Spettri, la cui azione si svolge in un salotto qualsiasi, ha una portata universale», dice Joyce stesso nel suo saggio Dramma e vita del 1900. Trentaquattro anni dopo a Parigi compose addirittura una poesia satirica, Epilogo a Spettri di Ibsen, in cui si divertì a dar voce al defunto Almig, complicando e rivelando le paternità (legittime e non) dei figli Regina e Osvald.
Quel che è certo è che fin da giovane Joyce soffrì sulla sua pelle l’irretimento e la decadenza del contesto famigliare e sociale in cui era cresciuto; basti pensare ai dissesti finanziari nei quali il padre John aveva trascinato l’intera famiglia, e che il giovane James subì prima ancora di ritrovarli rappresentati fra le pagine di Casa di bambola, L’anitra selvatica o John Gabriel Borkman. Non appena gli fu possibile abbandonò il suo focolare e si mise presto al lavoro per ricostruire impietosamente, nei racconti dei Dublinesi, quelle inettitudini degli adulti che ricadevano sui figli e che tramite loro si perpetuavano: i grandi non sono più in grado di assicurare ai piccoli la loro felicità ed emancipazione. Sarà infatti il più grande dolore nella vita di Joyce quello di non essere riuscito a salvare la amatissima figlia Lucia dai suoi profondi disagi psichici; quel dolore che in Spettri è la vedova Helene a soffrire per via del figlio Osvald, afflitto da una insanabile sindrome depressiva. Così come nelle opere di Ibsen i genitori non sono in grado di educare e crescere adeguatamente i propri figli, affidati alle sole balie e governanti, in Esuli, unico lavoro teatrale pubblicato da Joyce, il piccolo Archie è educato da una cameriera e un’insegnante di piano, mentre i genitori sono coinvolti in un intreccio, più o meno complice, di tresche sentimentali. Dalla sua terra natia Stephen Dedalus si autoesilia a Parigi, la stessa città dove trova rifugio Osvald in Spettri. Lascia la sua casa anche Erhart in John Gabriel Borkman e più di tutti a fuggire è Peer Gynt a «cercare sfortuna» (direbbe Dedalus), per l’impellente necessità di esprimere a pieno sé stessi, di liberarsi a qualunque costo dai vincoli gettati sulla propria anima dalla società, contro cui non rimane che opporsi, a rischio di venirne del tutto esclusi. Entrambi i due autori erano inoltre cresciuti in paesi cattolici, Irlanda e Norvegia, e la religione divenne per entrambi una delle prime istituzioni da aggredire in favore di una rinascita della cultura laica, come testimoniano le opere L’apostasia di Cesare e Brand e l’ateismo di Dedalus e Bloom, i protagonisti di Ulisse.

O ci si prende fin da subito la libertà di vivere o si muore prima del tempo; e «ciò che è irrimediabilmente perduto lo vediamo solo quando noi morti ci destiamo», sono le drammatiche parole di Irena nell’ultima opera di Ibsen, recensita da Joyce. Sono forse le stesse parole che avrebbe pensato la protagonista nel celebre racconto dal titolo non casuale: I morti. Qui è Gretta Conroy a rievocare un amore giovanile, drammaticamente interrotto, durante una bufera di neve che chiude il racconto seppellendo i vivi e i morti e che risuona come una potente eco della valanga che travolge Irena e Arnold nella conclusione di Quando noi morti ci destiamo.
Joyce lottò fino in fondo e per tutta la vita per prendersi la sua libertà di artista, pagando il caro prezzo dell’ostilità verso l’anticonformismo delle sue opere, che furono più volte duramente ostacolate dalla censura. Il biografo Richard Ellmann narra come nel 1936, a Parigi, Joyce confidasse al critico tedesco Richard Kerr: «La gente si mette a giudicare immorale un autore che si rifiuta di tacere su quello che in ogni caso esiste. Immorale! Perché? È un segno di moralità non soltanto dire ciò che si crede vero, ma anche creare un’opera d’arte con enormi sacrifici. Anche questo è morale. Ammiro Ibsen proprio per queste due ragioni: la sua moralità consisteva non solamente nel proclamare i suoi ideali etici, ma anche nel lottare fieramente per rendere perfetta la sua opera».
Morte e idealismo in Ibsen sono compagni di viaggio inseparabili e un numero li sugella: il tredici. L’Anitra Selvatica si apre durante un pranzo a casa del commerciante Werle che manifesta la sua preoccupazione sul numero degli invitati al figlio Gregers: «Non l’hai notato nemmeno tu? […] Eravamo tredici a tavola. […] Siamo sempre stati abituati ad essere dodici»; l’ultimo atto si chiuderà con lo sconfitto idealista Gregers avviato verso la sua fine costatando di essere lui stesso «il tredicesimo a tavola». Da profondo superstizioso qual era Joyce, è più che plausibile che dalle pagine di Ibsen abbia voluto trasferire lo sfortunato numero in Ade, il sesto episodio di Ulisse, dove Bloom conta i presenti al funerale di un suo amico: «Dodici. Io sono tredici. No. Il tizio col macintosh è il tredici. Il numero della morte». Tredici: il giorno della morte della madre di Joyce, rievocata fin dall’inizio dello stesso Ulisse.
Ancora nel 1936, nel corso di un soggiorno estivo in Danimarca, in un’intervista rilasciata al giornalista Ole Vinding, Joyce disse di Ibsen: «È il più grande drammaturgo che io conosca. Nessuno sa costruire un dramma meglio di lui. Non c’è una parola superflua, nelle sue opere». Quando infine Vinding gli chiese se ritenesse che Ibsen fosse superiore a Shakespeare, Joyce rispose: «Lo supera di una buona testa e delle spalle, quando si viene al dramma. Nessuno lo raggiunge, lì. È molto difficile che Ibsen possa invecchiare; si rinnoverà a ogni generazione. I suoi problemi saranno visti da un angolo sempre nuovo, col passare del tempo».
Alla luce delle evoluzioni e contraddizioni della società attuale, non si può certo dargli torto: Henrik Ibsen può ancora essere un autore in grado di parlare oggi alle nostre generazioni, risvegliandone e forgiandone le coscienze. Joyce disapprovava difatti l’insolenza della critica dell’epoca, che paragonava lo scomodo e impietoso drammaturgo norvegese a un «cane che fruga nell’immondizia»: se il dito nella piaga dell’anima prima o poi va affondato, è proprio perché non si può evitare per sempre di rivolgere lo sguardo al suo interno. In questo senso non potremmo ritrovare corrispondenza più intima fra le parole di Hjalmar ne L’anitra selvatica, «È buona cosa immergersi nelle tenebre dell’esistenza, ogni tanto», e i pensieri del monologo interiore di Stephen in Ulisse: «Trovi le mie parole oscure. L’oscurità è nelle nostre anime, non credi?»
Per approfondimenti sulle tematiche che accomunano Joyce e Ibsen, ci si può riferire alla recente video intervista “Joyce + Ibsen” a tre esperti in materia come Giuseppe Manfridi, Paolo Puppa e Paolo Quazzolo, disponibile su YouTube:
Illustrazione di copertina di Francesca Lippa @vecchiajane
