New York è la sua foresta di kelp. Viene da correnti più calde e spazi immensamente ascissi, ma New York vista con lei ha il baluginio verticale del seducente amo celato, cui abboccare mai.
Elizabeth Hardwick dimostra che la pensabilità di una vita sta tutta nel liquore di Notti insonni (Blackie Edizioni), basculanti come taccuini mitilideschi, come schizoanalisi brille, bolle di quel «fondale» che cita chi conosce la protagonista. Didion e Durastanti hanno nuotato assieme al critico letterario più composito del Secolo breve (Lexington, 1916 – Manhattan, 2007), ci permettono un’immersione stanata.
Sleepless Nights viene editato nel 1979. L’autrice ha 63 anni – una relazione dorsale con Robert Lowell, diverse pubblicazioni perlescenti; autorizza l’inutilità di dimensionare le proprie memorie e collocarle a manciate, krill per pescigatto, dal bovindo di una graziosa suite. Nel piacimento di fogli intimi, oscuri: lettere, sogni, ricordi, filigrane romanzate.
La biografia si trova volendo in multipli indirizzari online. Qui c’è «meditazione».
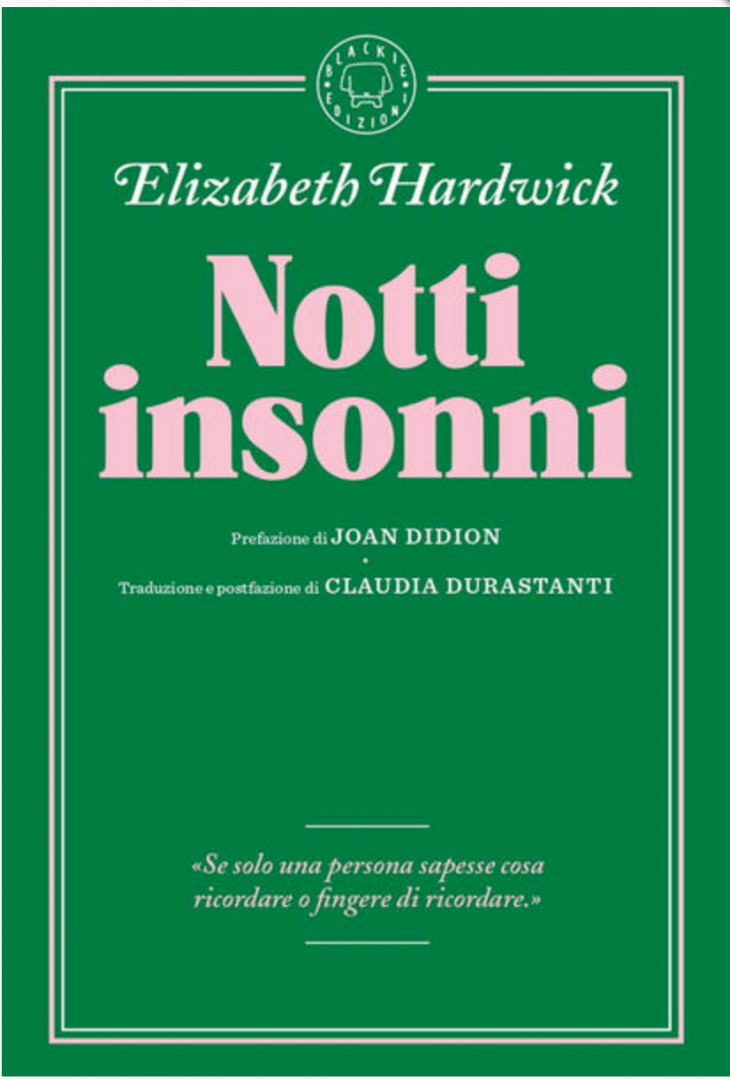
Il dato storico importa per l’orma digitale depositata sopra «quanto poco sappiamo di noi stessi», su «quanta perplessità lasciano i nostri souvenir e le nostre icone». Non preme.
Meglio quindi accatastare tutto, al pari dei ciaffi nelle vetrine-ripostiglio – «gli orologi morti, i lunghi anelli ovali per il mignolino, gli articoli di legno levigato a forma di testa africana dal mento lungo, i portachiavi dell’Empire State Building». Via.
La scrittrice allontana con raziocinio l’ordinario, salva fantastiche progettualità: «È giugno. Ecco cosa ho deciso di fare con la mia vita proprio adesso. Mi dedicherò a un lavoro di memoria trasformata e persino distorta».
La straordinaria penetrazione visiva di Hardwick ricorda Janet Frame, quanto ad arrendevolezza, distacco e misticismo eretico. Uniche, tuttavia, le sue fiammate linguistiche, tentativi mercuriali di tassonomia anatomica, sociologica – «Lo capisco dai miei calcoli indecenti basati sulla matematica dello snobismo. Per la vergogna ho prestato attenzione a vestiti, scarpe, anelli, orologi, accenti, denti (…)».
È un laboratorio che mischia osservazione ed esperienza, i test consumano pelle e abiti, sporcano tutto fuorché la percettibilità. Lei scova la fuffa che riempie i corpi di molti viventi, li paragona spesso all’inanimato o al bestiale rendendoli raffinati pupazzi da prosa.
Forse, è la residuale d’una specie moderna nata non in cattività.
«Quando viaggi, la prima scoperta che fai è che non esisti».
L’autrice a casa esiste troppo. Così si sposta. La tana nel Kentucky contrappone al mondo una specifica, amata «corruzione» («cresce dentro di te come i tuoi molari»). Le metropoli, appena più purificate, le regalano accoglienza ma a lei piaceranno per sempre «le città dalle dimensioni ragionevoli, le capitali provinciali» dove vomitare e tradirsi nel whiskey, alla luce del sole. Dove il «pozzo di disgrazia», la «macchia della paranoia» allargano nella contraddittorietà del giudizio e della confessione pubblici. Lì, la «piacevole truculenza di un’errata collocazione» può invasare tanto di Coltrane tanto di wood aged.

Seduction and Betrayal lo esemplifica, gli abbracci – Mary McCarthy, Susan Sontag, Billie Holiday… – lo provano.
Il pronunciato femminismo di Hardwick si tiene lontano da parossismi vulvodiniaci, da un’arrabbiata campagna mestruale. Constata i meccanismi di compensazione del gentil sesso al cospetto dell’ingombranza fisica, della forza, dell’ammaliante bestial dominio («Ogni donna che abbia mai sentito un uomo storcerle il polso, si trova al cospetto di un fatto della natura che induce remissività», cita Didion riferendosi a un saggio hardwickiano su Simone de Beauvoir). Poi livella, non avvantaggia né risparmia: «le donne della chiesa, ingobbite dal peso del loro aberrante settarismo», le prostitute per caso e per scelta.
Durante i ‘40, all’Hotel Schuyler, 57 West 45th Street, tra femmine sole ed emancipate, in mezzo agli irregolari, cuce dal parapetto teorie orosolubili sulla «grande tradizione classica» di marito-e-moglie («litigare è come affilare lame arrugginite»).
Mitigata dalla certezza che «i deboli hanno un senso purissimo della storia», dopo adolescenze palpeggiate e libertine semina amplessi ignifughi rimembrati senza amarezza. Uomini-saracinesca in grado di abbattersi sul corpo con la liceità del diluvio irrorano vallate.
La «fertilità fatidica» della madre (ebbe nove figli) emerge come un inoltre cui far spallucce: una sazietà nota eppure intimamente sconosciuta.
Mentre si pensa che l’autrice abbia vissuto tanto, quindi anche drammaticamente, ecco: «A dire il vero, ci son stati momenti, mesi, persino anni che sono stati magici». Dopotutto «a volte la pioggia era bellissima».
Non ottimismo freak. Poeticità, dice, trasfigurato dalla «sedentaria mancanza di sonno», il manoscritto. Che per lunghi tratti si rivela un viaggio alla finestra. Anche se lei disfa valigie vere incontro a «gente vera: che non somigliava per niente a tua madre e a tuo padre», anche se l’andirivieni («dal Kentucky a New York, poi a Boston, fino al Maine, l’Europa…») mutila e orripilizza il suo mobilio.
«Ecco cos’ho visto ieri». Ad Hardwick piace affacciarsi a descrivere «il canto dei furgoncini grezzi e striduli per la strada», asili e atelier, conversazioni tra bramini, albicanti protégé. Tutto nell’estro di circoncisioni temporali attorno al folto di piante-fallo, all’andatura di donne-uccello.
Dicono sia lettura difficile. Complessa, certo, per chi cerca trama.
Nell’intero dell’opera, che si può (questo è vero) mettere per comodità nel decanter, resta facile pronunciare fasi riducibili alla norma umana: tempo-spazio, sogno-veglia. Serve forse a dire a se stessi «ho capito». Eppure, la gravità di dimenticarsi lo stare dinnanzi a colei che sottolinea «e comunque mi piace essere compresa da quelli di cui mi importa» è peccaminosa.
Le Notti insonni sono tarocchi. Hanno i propri personaggi, disposizioni giostrabili, decifrazioni arcane. Nella coscienza «mareale», dentro il flusso, si pesca.
Photo Credits: Blackie Edizioni
