Nel dir cocotte, “loro” oggi non saprebbero dove metter mano – né sulle cosce tremule alla giarrettiera, né sulle pirofile fumanti –, quand’invece “lui” affondò il gusto in entrambe, con la voracità di un ermellino in estro. Tra i pasti. Un appetito per Parigi è di Abbott Joseph Liebling la sentenza sull’universo di culi e culinarie, soprattutto, deglassato tra il 1926-‘27 e il 1939. L’Oltralpe allora aveva un’odorosa sensualità spiccatissima, che ferì quasi mortalmente il giovane giornalista americano (fedele al New Yorker per oltre trent’anni, scrisse di sport, politica, vini e cibo), più che la guerra, sogguardata dal fronte europeo (con i suoi reportage al fulmicotone, guadagnò la Legion d’Honneur). Tanto da battere lunghi articoli incentrati su infinite entrée e docce di Tavel, poi raccolti in «Between meals: an appetite for Paris» da Simon & Schuster, nella New York dei Sessanta.
Questo libro ha capitoli sagaci, mette fame e nausea insieme: irresistibile nausea, per il totale corrispondentismo in cui vive Liebling: il coeur de boeuf sfrigolante aglio nel suo piatto è il medesimo che gli batte in petto, pompando Chablis.
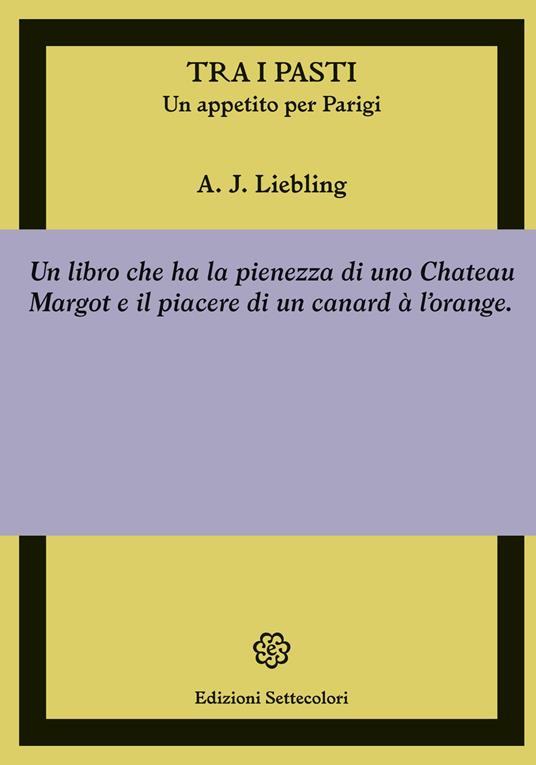
L’autore racconta di come, invece di studiare alla Sorbona sotto sovvenzione paterna, passò due interi anni a gozzovigliare tra gli arrondissements della Ville Lumière – una mano alla forchetta, l’altra ai seni di spicce eintrîneuses. Lui, ch’era passable, e con vanto («passabile è la cosa migliore per un uomo. Chi è passabile sfugge all’attenzione. Essere passabile è come un vestito decente. Ti permette di entrare dappertutto. Passabile e possibile sono alleati per libera associazione»), andava meglio di un segugio a stanare eccellenti bettole, raccogliendo solleticanti palpatine.
J. L. non s’accontenta della narrazione pura, la vuol didattica. Cerca d’insegnare “come” operar uguale a lui, e divertire un mondo pancia e dintorni. Sul gentil sesso non fa mistero, seppur per galanteria lesini consigli e li riduca a chiosa, nello scritto; spetta a James Salter farne specifico ritratto:
«Benché fisicamente poco attraente, Liebling piaceva alle donne. Calvo, sovrappeso e buon mangiatore, così si descriveva. Era timido e incline a lunghi silenzi. Aveva i piedi piatti e camminava con fatica, soprattutto nella mezza età, quando era diventato talmente grasso che secondo un collega scrittore era impossibile camminargli accanto sul marciapiede. Nonostante ciò, le donne gli si affezionavano, anche le più belle. Come spiegò a un amico, era perché le faceva sentire intelligenti: non si trattava di una tattica, era sincero».
Schietto, a dir il vero, su tutto. Lui, che sogna sbronze totali, diurne e «americane», rotea la flûte in faccia a dietisti e luminari, pure letterari. Contro alla madeleine di Proust gioca la carta di «uccellini, coniglio in umido, trippa ripiena e Côte Rôtie», qualcosa di più «robusto» di un «biscottino», seppur impastato col brandy («quantità che non basterebbe a ubriacare un pettirosso»). Ai camici bianchi riporta l’esempio di arzilli ottantenni, «socievoli e indenni dalle ulcere derivanti dalla preoccupazione di una dieta equilibrata. Ma in Francia costoro non hanno più emuli, da quando i medici hanno scoperto l’esistenza del fegato umano (…) una cautela assillante ha sostituito l’antica temerarietà; il fegato è diventato il fulcro della mentalità da linea Maginot».
La sua Parigi personale, una sorta di libanese e stratificata Byblos, viene vissuta sia solo sia accompagnato da comparse; sullo sfondo puntellano amicizie colossali con le quali condividere il requisito primo per «scrivere bene di cibo» (ecco, le vere lezioni soffritte al lettore), ossia l’appetito. Yves Mirande è una di queste. Commediografo, tra gli ultimi grandi gastronomi di Francia, un piccolo allegro autore di vaudeville e libretti di operette, spartiva assieme a J. L. la dilatazione dello stomaco. Specialmente quando si prospettava la Truite sur Bleu, «una trota viva fatta semplicemente morire nell’acqua bollente, come un imperatore romano nel suo bagno».
Mentre continua il vademecum alla Artusi – «il secondo requisito è fare l’apprendistato di mangiatore quando si hanno abbastanza soldi per pagare il conto ma non abbastanza da restare indifferenti di fronte al totale» –, Liebling seguita a descrivere la tavola come cartina tornasole delle frequentazioni, regalando scorci psico-sociali estremamente volatili, terribilmente immortali, che gli valgono massime accademiche («se è vero che con il passare degli anni un uomo deve imparare ad andare d’accordo con gli altri, questo è un motivo in più per vivere un periodo della sua vita in cui debba andare d’accordo soltanto con se stesso»).
Nello sperimentare al Restaurant des Beaux-Arts in rue Bonaparte la libertà dall’handicap paralizzante dell’agiatezza, secondo cui «un uomo ricco nell’adolescenza è praticamente condannato a essere un dilettante a tavola», l’ironico giornalista ritrova le Paris della sua esistenza. Inizia con un utopico suk infantile, sorvegliato da Fräulein musone, abbagliato dalla madre, bella come Lilian Russell, stordito da guerra e ostriche tifiche. Prosegue sottobraccio a Waverly Root, prima che diventi autore di «The food of France», leccando olio provenzale, istruendosi sul Borgogna, seduto a un desco in cui non è dato menù. Finisce con «gli ultimi bagliori», dopo un’assenza di dodici anni; nel ’39, Liebling scarpina la Parigi delle «donne scheletriche» e degli uomini anelanti la fisionomia dell’eroe smunto, emaciato; i ristoranti diminuiscono, quelli costosi scompaiono, a causa della costante di diminuzione del pubblico interessato al cibo; in compenso sorgono le catene bon marché per i viaggiatori di commercio, e con loro il rimpianto di quando automobilismo e alimentazione erano ancora reparti separati. «Notai un declino nella qualità dei ristoranti che non poteva essere imputato una guerra cominciata appena da un mese», scrive J. L., «il declino, capii in seguito, era già nato negli anni Venti, all’epoca dei miei primi studi sull’alimentazione; avevo preso per un’età dell’oro quella che in realtà era una tarda età dell’argento». Adieu alla classica cuisine française, ai piccoli pesci d’acqua dolce della Senna serviti en buisson, all’andouille e all’andouillette, il boudin, il civet, il pot-au-feu, lo jambon persillé…
Però non è triste, il crapulone. Sa di essere stato privilegiato, d’aver visto, prima dell’estinzione, e ovviamente goduto. Sorride, persino, a ritroso, delle sue défaillances: quando a 52 anni si ricoverò volontariamente in una «prigione svizzera» per dimagrire («ma solo perché ero affetto da una pazzia temporanea»); e quando lo prese lo sviamento verso l’esercizio fisico: deragliata che comunque gli fece annusare da vicino la Marna, seppure senza mai mettervi remo, e incontrare Carpentier o Mascart sudatissimi, appena fuori dal ring. Ride, ripensando alla tassonomia di chef, saucier e rôtissoire stilata fazzoletti in mano («come la maggior parte degli ottimi cuochi il signor Bouillon andava in collera e piangeva facilmente; il calore dei fornelli forse influisce sui dotti lacrimali, oltre che sulla disposizione d’animo»), fino alla commozione.
«Resta il fatto che dal punto di vista gastronomico ci siamo avviando verso un buio Medioevo», spara lì bruciapelo. Poco dopo aver avvistato la fine della localizzazione di piatti e ricette. Poco prima dell’intrusione dei «muffin a raggi infrarossi».
Immagine di copertina: Ernest Descalas
