Il supermercato, anzi il Supermercato, con la esse lunga, ha cominciato a strizzare l’occhio agli scrittori già nel 1955, quando Allen Ginsberg immaginò un Walt Whitman «vecchio e solitario ficcanaso» aggirarsi tra le corsie di Un supermarket in California in una poesia che anticipava il consumo bulimico di Campbell’s Soup (1962), di Brillo Box, di bottiglie di Coca-Cola: Ginsberg e Andy Wharol aprivano debitamente la strada allo spazzolino da denti di Claes Oldenburg (1983), in quegli anni ’50 e ’60 del boom, quando bisognava mettere un limite allo spauracchio dei Persuasori occulti (1957), la requisitoria di Vance Packard impegnato a svelare la minacciosa alleanza tra merci, pubblicità e libertà d’opinione. Le merci si avviavano a diventare amiche, la loro ripetizione seriale sugli scaffali e sui muri delle gallerie ne sottolineava la prossimità, si direbbe oggi, e ingigantire un dentifricio spingeva a guardarlo con gli occhi estetici che si riservano di solito agli oggetti non funzionali, perché anche un tubetto di Colgate ingrandito poteva risultare simpatico (oppure spaventare ancora di più gli apocalittici degli albori della società dei consumi).
Per fare di una merce arte, o di un luogo letteratura, bisogna essere bravi a distaccarsene oppure, all’incontrario, ad aderirvi senza pregiudizi, come fecero, in Italia, i Magazzini Criminali alla fine del 1970, segnando idealmente con i loro spettacoli teatrali (Crollo nervoso, Ebdomero, Punto di rottura) la fine degli anni di piombo e lanciando l’estetica della mercificazione generalizzata, senza alcun complesso né soggezione verso il consumo, in una sorta di liberazione ideologica dalla coercizione del negativo che aveva condizionato l’epoca immediatamente precedente. Il retaggio apocalittico quando si parla di marketing è sembrato per molto tempo un passaggio obbligato, come lo Sturm und Drang per il romanticismo. Si deve essere interrogata su questo la scrittrice francese Annie Ernaux, che alla sua bella età (è nata nel 1940) si misura con il Supermercato nel libro commissionatogli da Les éditions du Seuil nel 2012, oggi tradotto (da Lorenzo Flabbi) per L’Orma editore: Guarda le luci, amore mio. Nelle prime pagine afferma che gli ipermercati «stanno cominciando soltanto ora a figurare tra i luoghi degni di avere una loro rappresentazione», dimenticando Ginsberg, il John Updike di A&P (1961) che riscrive in questo racconto uno dei Dubliners di Joyce e che si svolge in un supermercato alla periferia di Boston, il Calvino di Marcovaldo al Supermarket (1963), mentre un anno prima Luciano Bianciardi ne La vita agra (1962) descriveva in modo strepitoso le “donnette” che, davanti al bancone della carne, si rigirano tra le mani un vassoio incellofanato e, senza nemmeno guardarlo, lo rimettono a posto: «Nelle ore di punta il vassoio non fa nemmeno in tempo a ritornare sul bancone: appena visto e tastato, passa in mano a un’altra donna, percorre tutta la fila delle donnette chine come polli a beccare in un pollaio modello. Poi ritorna indietro». Dopo, nel 1985 ci sarà Don DeLillo che in Rumore bianco descrive il senso di appagamento che le merci procuravano «a una sorta di intima casetta delle nostre anime». In Italia furono Tommaso Labranca (1962-2016) tra Nutella, metafisica delle periferie, fenomenologie del cialtronismo e altri articoli alimentari a percorrere le strade parallele dell’estasi “pecoreccia” che il consumismo procurava, mentre Aldo Nove in Puerto Plata Market (1997) dedicava un intero capitolo all’elenco dei prodotti che si potevano comprare nel Supermerket Silverio Messon di Puerto Plata, nella Repubblica Dominicana. In Superwobinda (1998), invece, affermava: «Ho ammazzato i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma assurdo, Pure & vegetal, ma io uso Vidal e voglio che tutti in casa usino Vidal».

Ernaux appare indecisa tra due strade: quella della nostalgia e dello spiazzamento, perché molti dei supermercati della sua infanzia e giovinezza non esistono più «e la loro scomparsa acuisce la malinconia del tempo», e quella della scoperta (ritardata, come abbiamo visto), perché insiste: «L’ipermercato è per tutti un luogo familiare la cui frequentazione è incorporata nell’esistenza stessa, ma il suo impatto sule nostre relazioni con gli altri, sul modo in cui nel ventunesimo secolo “fomiamo la società” con i nostri contemporanei, non viene quasi mai preso in considerazione». Ed ecco Ernaux indossare i panni di una casalinga Margaret Mead e cominciare a frequentare i supermercati, per «farsi un’idea sul modo di essere e di vivere degli altri». Questa è la sua prima ingenuità: in un supermercato, trabocchetto mascherato di informazioni, mediazioni, sguardi alienati, raccontare, come vuole fare lei, un’esperienza immediata, “in diretta” del reale, rischia di scaraventare il diario che vorrebbe scrivere – «una libera rassegna di osservazioni, di sensazioni, per tentare di cogliere qualcosa della vita che vi si svolge»- in un carrello di stereotipi, buttati là come l’accozzaglia di scatole e vasetti che li riempiono quando facciamo la spesa. Piena di buona volontà, vuole prestare «un po’ più attenzione del solito ai vari attori, dipendenti e clienti, che nel supermercato si muovono e agiscono, e alle diverse strategie commerciali».
Sembra il compito assegnato agli studenti di una scuola di scrittura, e la nostra scrittrice-antropologa lo esegue con diligenza: prova brividi di piacere all’idea «di andare al Trois Fontaines», freme «per la rabbia e il senso di impotenza» per il prezzo di una Barbie alla guida di una Volkswagen (29,90 euro), invoca le Femen (il collettivo femminista): «È qui che dovete venire, alla fonte, per mettere a soqquadro gli scaffali che modellano il nostro inconscio. Vi darei una mano», si reca nel reparto libreria per uscirne ogni volta «triste e scoraggiata» perché, nonostante ci siano anche i suoi libri tra i tascabili, la selezione «obbedisce a un solo criterio, quello dei bestseller», di fronte a una cassa automatica afferma senza esitazioni che «questo genere di dispositivi spinge all’indifferenza morale» (le era rimasta inavvertitamente attaccata a una shopper regolarmente pagata, tre centesimi, un’altra, e lei non avverte l’addetta, traendone una lezione). Se c’è la coda al banco del pesce, per Ernaux è il segno di «quanto sia stata universalmente integrata la tradizione cattolica» ma, in un soprassalto laicista: «Anche se spesso il pesce viene comprato di venerdì soprattutto per via della credenza secondo la quale sarebbe più fresco che negli altri giorni della settimana». Si mette a guardare i commessi che lavorano. Uno le chiede cosa desidera: «Niente, è che sto scrivendo una cosa sugli ipermercati». Il macellaio, il panettiere, il formaggiaio, agli occhi di Annie nel paese delle meraviglie, esprimono «fierezza», quella «conferita da una lunga esperienza, sia quella di un impiego o di un matrimonio o persino di una vita».
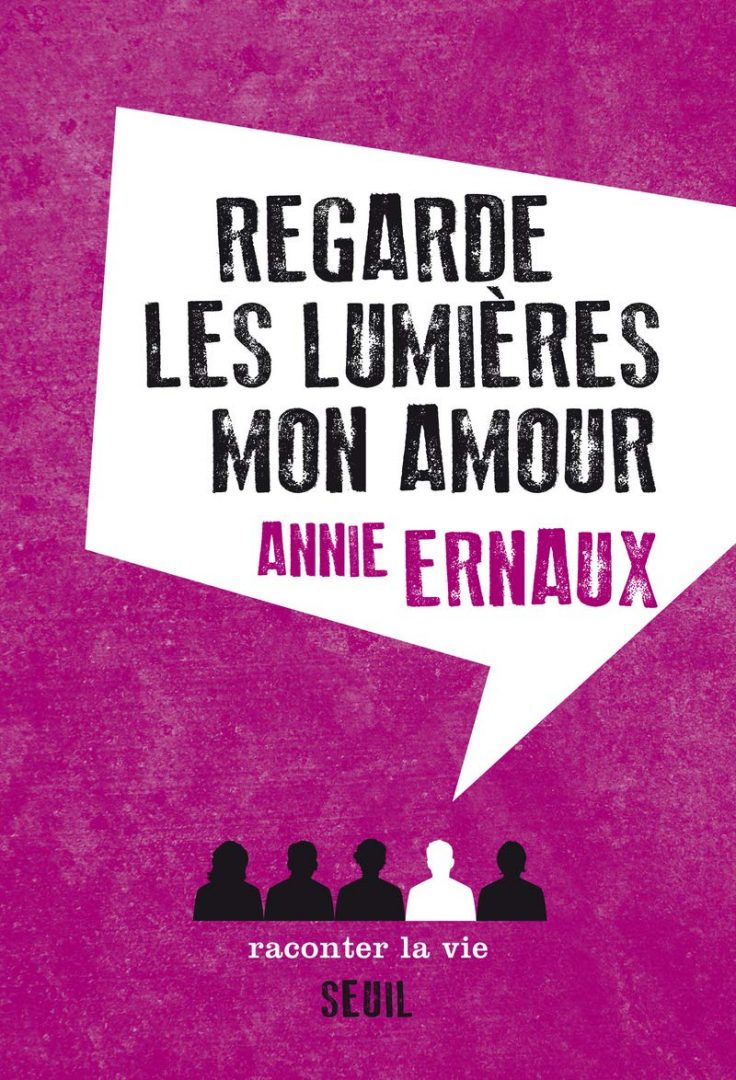
Sei anni prima che Ernaux scrivesse Regardes les lumières mon amour era uscito in Francia Le bonheur paradoxale di Gilles Lipovetsky (pubblicato in italiano da Raffaello Cortina). Ernaux sarebbe stata d’accordo con l’autore che la felicità che il consumo reiterato di merci sembra assicurare non è nient’altro che un paradosso, perché le classi più esposte alla coazione all’acquisto, quelle che guardano più televisione (oggi che stanno più sui social), che frequentano di più gli ipermercati, sono proprio quelle che non possono permettersi di comprare niente, o poco. Annie Ernaux appare impegnata a registrare gli orari della spesa delle varie tipologie di frequentatori come un «fattore di segregazione» (lei vorrebbe che i pensionati del mattino incontrassero i manager che acquistano monoporzioni la sera, in un felice incontro interclassista), a interrogarsi se deve scrivere “nero” o “asiatico” quando parla di qualcuno che incontra all’iper, ad autoconvincersi che «lo si voglia o no, qui costituiamo un’unica comunità di desideri» (ognuno in una diversa scala di possibilità di esaudirli, bisognerebbe aggiungere).
È questo “incanto” che Ernaux prova nei confronti degli ipermercati, alla ricerca dell’autentico in un luogo purtroppo esemplare per la sua prosaicità, che corrompe lo sguardo sincero di questa autrice. «Mi era sorta la domanda che mi pongo moltissime volte, la più importante di tutte: perché non ci rivoltiamo?». Topi in trappola, gente stanca, comunità di desideri e non di azione: il supermarket, che per sua natura si situa sul versante del disincanto, viene soppiantato nel racconto da un nuovo canone interpretativo: Ernaux non è soltanto la scrittrice, lei è anche la consumatrice, è il suo “io” che parla e giudica. È mentre vorrebbe farci dimenticare il “non luogo”, elevando l’ipermercato a spazio relazionale e identitario, che Annie Ernaux compie il massimo tradimento: il posto dove fare la spesa si carica di denuncia morale, e non sembrano passati due secoli dalla fabbrica fordista, con gli operai che avvitavano tondini alla catena di montaggio, sostituiti qui dai polli allevati al consumo, automi che lo sguardo della scrittrice vorrebbe redimere, per salvare anche se stessa dal «senso di impotenza e di ingiustizia» che la coglie sempre, quando entra in un iper.
In copertina: ©Getty Images
